I Calvari Salentini. Analisi Grafica E Documentazione
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Societa' Enerwind
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 8-10-2020 67833 SOCIETA’ ENERWIND Avviso pubblico presentazione progetto per la richiesta di manifestazione di interesse al Comune Di San Pancrazio Salentino (BR) per la realizzazione di un’area attrezzata integrata per il commercio e valorizzazione dei prodotti tipici e dei circuiti enogastronomici, tempo libero, benessere della persona con annessi servizi socio sanitari ed alberghieri denominata “LifeCity Parco degli Ulivi”. ENERWIND s.r.l. con sede legale in Via San Lorenzo n.155 - c.a.p. 72023 – MESAGNE (BR) p.iva 02549880744, in partnership con MSC innovative solutions srls, comunica di aver presentato in data 7 agosto 2019 prot. 9707/2019 e successivi aggiornamenti, al Comune di San Pancrazio Salentino ISTANZA di conclusione di un Accordo di Programma, previa “manifestazione di interesse”, ai sensi dell’art.34 D.Legvo n.267/2000 e s.m.i. dando atto che la predetta “manifestazione di interesse” è propedeutica all’avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regione (P.A.U.R.) ai sensi dell’art.27bis D.levo n.152/2006 e s.m.i. che sara’ avviato dall’Ente preposto Regione Puglia/Provincia di Brindisi, ai sensi di legge. L’accordo di programma da concludersi ai sensi dell’art.34 D.Legvo n.267/00 e tutti gli atti e/o pareri previsti dalla normativa, ivi compreso le autorizzazioni commerciali e sanitarie, sono atti e pareri endo-procedimentali al predetto P.A.U.R. La conclusione del predetto procedimento P.A.U.R. presso l’Ente Regionale e/o Provinciale preposto ai sensi di legge costituirà l’atto finale autorizzativo che sara’ ratificato dal Consiglio Comunale a completamento della procedura autorizzativa. -

Comuni Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazios.No, San Pietrov.Co, Torchiarolo, Torre Santa Susanna
Comuni Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San PancrazioS.no, San PietroV.co, Torchiarolo, Torre Santa Susanna AVVISO ALLE FAMIGLIE Apertura termini per iscrizioni - ANNO EDUCATIVO 2016-2017 SEZIONI PRIMAVERA per bambini e bambine tra i 24 e i 36 mesi Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti PAC Infanzia II° Riparto L’Ambito Territoriale Sociale 4 a cui afferiscono i Comuni di Mesagne (capofila), Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, in attuazione dei Progetti del Programma Servizi di Cura Infanzia - finanziati con il Primo Riparto PAC Ministero dell’Interno, in una logica di rete e potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell’istruzione, dei servizi sanitari, dei servizi socio assistenziali e sociali di Ambito), avvia per l'anno educativo 2016-2017, l’iscrizione al servizio di SEZIONE PRIMAVERA, servizio socio educativo integrativo a sostegno delle responsabilità genitoriali, della tutela dei diritti dei minori e della CONCILIAZIONE tempi VITA LAVORO. La Sezione Primavera è un servizio educativo e sociale che ha la finalità di sostenere la crescita dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali. Costituisce il ponte per l’ingresso alla scuola dell’infanzia e offre una risposta pedagogica alle richieste formative di quei bambini che non necessitano solo di cure, peculiari del nido, e garantiscono l’apprendimento in un ambiente di cura educativa, con un’attenzione forte al tempo dell’accoglienza, del benessere psico-fisico, al fine di sostenere lo sviluppo delle competenze generali per un’esperienza scolastica futura serena. -

GRADUATORIA A.T.C./TARANTO CACCIATORI AMMESSI ALL’ESERCIZIO VENATORIO PER L’ANNATA 2018-2019 Ordine N Prot
A.T.C. - PROVINCIA DI TARANTO Ambito Territoriale di Caccia – Gestione Commissariale GRADUATORIA A.T.C./TARANTO CACCIATORI AMMESSI ALL’ESERCIZIO VENATORIO PER L’ANNATA 2018-2019 Ordine N Prot. n. Cognome Nome il citta sorteggio ordinativo 517 19 A/323 Abbinante Vito 09-lug-53 Acquaviva delle Fonti 1574 1654 A/2504 Accogli Luigi Giovanni 23-ago-67 Melendugno 1846 1430 A/2226 Acito Giovanni 17-mar-70 Casamassima 1156 774 A/1461 Acquaviva Angelo 17-apr-43 Fasano 1573 883 A/1571 Acquaviva Oronzo 20-ott-60 Locorotondo 1041 52 A/383 Addabbo Francesco Leonardo P. 01-nov-66 Gioia del Colle 39 1287 A/2066 Addante Alessandro 29-ott-85 Cellamare 494 477 A/1161 Addomada Giovanni 23-gen-52 Ceglie Messapica 1173 1674 A/2524 Addomada Rocco 28-gen-77 Ceglie Messapica 1725 228 A/676 Agostino Giandomenico 01-mar-59 Alberobello 607 302 A/799 Agrusti Luigi 18-feb-56 Alberobello 920 198 A/634 Agrusti Vincenzo 18-gen-67 Alberobello 633 810 A/1497 Ala Antonio 27-lug-52 S. Pancrazio Salentino 744 1251 A/2030 Alba Nicolò 11-set-64 Monopoli 331 1595 A/2440 Albanese Giorgio 09-mar-45 Ceglie Messapica 505 1756 A/2609 Albanese Luigi 22-giu-47 Castellana Grotte 752 431 A/1046 Albanese Luigi 09-apr-73 Mesagne 1218 1113 A/1880 Albanese Giovanni 16-ago-54 Locorotondo 1424 1851 A/2706 Albanese Giuseppe 29-mag-55 Latiano 71 430 A/1045 Alighieri Gianfranco 04-mar-61 Oria 347 1417 A/2213 Alò Ciro 27-feb-44 Villa Castelli 754 765 A/1452 Alò Rocco 21-mar-41 Villa Castelli 1295 1490 A/2288 Alò Francesco 19-dic-58 Villa Castelli 1376 1206 A/1979 Alò Pietro 06-mar-62 Villa Castelli -

Elenco Operatori Mercato Settimanale
MQ anno mese giorno NOME NATO IL NATO Manduria POSTO N POSTO SETTORE INDIRIZZO COGNOME num. Ordine cod. fiscale RESIDENZA/SEDE LUOGO DI NASCITA DI LUOGO anzianità maturata nel mercato di 1 1954 28/ 05/ 2012 GUIDERDONE GIUSEPPE DARIO MANDURIA 20/12/66 MANDURIA VIALE PICENO GDRGPP66T20E882U CALZATURE 11 10 X 6 = 60 2 1959 28/ 05/ 2012CAMPA SERGIO MANDURIA 06/12/72 MANDURIA CONTRADA POZZO CUPO CMPSRG72T06E882G MERCERIA MAGLIERIA 02 06 X 4 = 24 3 1964 28/ 05/ 2012 ACQUAVIVA ALESSANDRO MANDURIA 29/06/68 MANDURIA VIA C. FILOTICO CQVLSN68H29E882K MERCERIA MAGLIERIA 18 07 X 4 = 28 4 1970 28/ 05/ 2012 FUMAROLA DAVIDE CISTERNINO 30/05/83 MARTINA FRANCA VIA ALBEROBELLO 3^ TR. FMRDVD83E30E882Q ALIMENTARI frutta e verdura 06 X 4 = 24 5 1970 28/ 05/ 2012 VACCARO RAFFAELE MANDURIA 13/08/65 MANDURIA VIA XXV APRILE, 25 VCCRFL65M13E882K ALIMENTARI alimentari - frutta secca 87/BIS 06 X 4 = 24 6 1973 28/ 05/ 2012 ANDRIULO FERNANDO ANTONIO SAVA 20/02/66 SAVA VIA VERONA NDRFNN66B20I467D ABBIGLIAMENTO 05 14 X 6 = 84 7 1973 28/ 05/ 2012 LONGO GIACOMO FRANCAVILLA FONTANA 27/02/71 FRANCAVILLA FONTANA VIA DI VAGNO LNGGCM71B27D761O ABBIGLIAMENTO 14 X 6 = 84 8 1975 28/ 05/ 2012CARBONE EUPREPIO ORIA 10/02/52 TORRE SANTA SUSANNA C.DA SPINELLI CRBPRP52B10G0981 ALIMENTARI 53 06 X 4 = 24 9 1977 28/ 05/ 2012 AMMATURO COSIMO FRANCAVILLA FONTANA 22/07/56 FRANCAVILLA FONTANA VIA MANZONI MMTCSM56L22D761W MERCERIA MAGLIERIA 21 04 X 4 = 16 10 1977 28/ 05/ 2012 11 1977 28/ 05/ 2012COMES RONZINO COPERTINO 10/04/74 FRANCAVILLA FONTANA VIA PUCCINI CMSRZN74D10C978F ABBIGLIAMENTO -
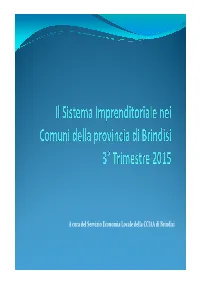
Il Sistema Imprenditoriale Nei Comuni 3 Trim. 2015
A cura del Servizio Economia Locale della CCIAA di Brindisi Il Bilancio dei Comuni- 3° Trimestre 2015 Nel corso del 3° trimestre 2015 il sistema produttivo della provincia di Brindisi ha conseguito complessivamente un bilancio demografico in attivo (+98 imprese con un tasso di crescita pari a +0,27%). Il panorama dei comuni, sul fronte della crescita, (rispetto allo stesso trimestre del 2014) mostra tassi generalmente positivi, ad eccezione di cinque comuni che attestano tassi negativi oscillanti tra (-0,12% e -0,35%). La dinamica delle imprese sotto il profilo dei diversi settori di attività economica, assesta rispetto al 3° trim.2014 una variazione percentuale positiva +0,29% Sotto l’aspetto della forma giuridica, in tutti i comuni della provincia si denota una netta prevalenza per le forme individuali, a seguire le società di capitale, quelle di persona e le altre forme. Analizzando l’universo delle imprese artigiane, il trimestre estivo chiude con un bilancio demografico in rosso –15 unità. Nella ripartizione comunale sono solo quattro comuni che registrano tassi di crescita positivi che oscillano tra lo (+0,63% e +1,60% ). La componente più giovane, all’interno del tessuto produttivo brindisino, evidenzia per il periodo di osservazione un saldo positivo pari a (83 unità) con un indice di imprenditorialità giovanile pari al 12,3%. I comuni più popolati dalle imprese giovanili sono Brindisi (792 unità), Fasano (472 unità), a seguire Francavilla Fontana (456 unità) ed Ostuni (380 unità). La distribuzione tra i settori di attività premia, tra le imprese giovanili attive, il settore commercio (1.418 imprese), le costruzioni (530 imprese), le attività di alloggio e ristorazione (452 imprese) ed infine, il settore agricolo (422 imprese). -

Vendite Immobiliari E Fallimentari
COPIA GRATUITA N. 65 FEBBRAIO 2019 www.tribunale.brindisi.giustizia.it | www.astalegale.net TRIBUNALE DIBRINDISI VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI TRIBUNALE DI BRINDISI Professionista Delegato Minimo Euro 4.000,00. CAROVIGNO - alla vendita e Per info Vendita senza incanto VIA TOMMASO Avv. Maria Pina Ferri tel. 01/04/19 ore 12:45. CAMPANELLA, 2 - LOTTO Abitazioni e box 0831511006. Rif. RGE G.E. Dott.ssa Paola 1) APPARTAMENTO 332/2015 BR615540 Liaci. Professionista DI CIVILE ABITAZIONE BRINDISI - VIA Delegato alla vendita posto al primo piano LOMBARDIA, 15 - BRINDISI - VIA della scala “A”, composto e Custode Giudiziario APPARTAMENTO ORVIETO (ANGOLO VIA di ingresso, soggiorno, Avv. Luca Bardaro tel. posto nel Quartiere CAPPUCCINI), 2 - LOTTO pranzo, disimpegno, Commenda, della 1) PIENA PROPRIETÀ 0831730498. Rif. RGE bagno, due camere da superficie commerciale DELL’APPARTAMENTO, 36/2015 BR616337 letto, un balcone ed una di 64,57 mq., Ctg. A/4, della superficie classe 3, cons. 4 vani, commerciale di 112,70 rendita 278,89 euro, mq, identificato nel piano secondo. Prezzo N.C.E.U. al foglio 195, base Euro 25.987,50. p.lla 84, sub 1 (catasto Offerta minima: Euro fabbricati), zona 19.490,63. Rilancio censuaria 1, cat. A/3, cl. 3, Minimo Euro 1.300,00. consistenza 6,5. Prezzo Vendita senza incanto base Euro 57.836,23. 01/04/19 ore 10:00. G.E. Offerta minima: Euro Dott.ssa Paola Liaci. 43.377,17. Rilancio www. veranda. Censito nel al Foglio n. 96, p.lla A distanza di qualche FASANO - VIA Nuovo Catasto Edilizio n. 386, sub. 1; Locale, metro, staccato da DELL’INDUSTRIA, 18 - Urbano del Comune in catasto al Foglio n. -

Osservatorio Politiche Sociali Provincia Di Brindisi
PROVINCIA DI BRINDISI Assessorato alle Politiche Sociali - Osservatorio Sociale - L’osservatorio Delle Politiche Sociali Della Provincia Di Brindisi: Dall’architettura Del Sistema Alla Sperimentazione Operativa Avviso n.6/2006 Misura 3.2 Azione c e Misura 3.4 Azione d Rapporto finale Aprile 2008 Il lavoro è stato diretto e redatto da Fiorenza Deriu con la collaborazione di Elisa Mariano e Marianna Giordano e la supervisione scientifica di Maria Luisa Mirabile Si ringraziano la dott.ssa Alessandra Battisti e la dott.ssa Giovanna Tresso per la redazione di due approfondimenti rispettivamente sul tema dell’integrazione scolastica dei ragazzi con disabilità e sull’implementazione della cartella sociale in Italia. INDICE Introduzione p.5 Il progetto p.8 1. L’Osservatorio delle Politiche Sociali della Provincia di Brindisi p.8 2. Le aree prioritarie di policy p.10 3. Creazione del Portale dell’Osservatorio delle Politiche Sociali di Brindisi p.13 4. La struttura dell’Osservatorio provinciale di Brindisi p.15 Appendice p.17 Parte Prima Servizi e territorio Cap. I.1 La mappatura dei servizi p.19 I.1.1 Servizi sociali e strutture presso i 20 Comuni della Porvincia di Brindisi: una prima mappatura dell’offerta pubblica a gestione diretta ed esternalizzata p.19 I.1.1a Metodo e tecnica di rilevazione: un’indagine sul campo p.19 I.1.1b I principali risultati p.21 Parte Seconda Approfondimenti Cap. II.1 I servizi socio-sanitari per disabili nella Provincia di Brindisi p.36 Introduzione. Le lacune informative sulla disabilità nella Provincia di Brindisi -

A.T.C. Provincia Di Lecce REGOLAMENTO REGIONALE N°4 Del 18-10-2004 - Art.4, Comma 2, Lett
A.T.C. Provincia di Lecce REGOLAMENTO REGIONALE N°4 del 18-10-2004 - Art.4, comma 2, lett. a (Extraprovinciali) ANNATA VENATORIA 2020/2021 Pag.1 Data di Ora di Numero Numero Cognome e Nome Residenza Ammissione partenza partenza Protocollo 1 ZACCARIA LUCIANO CAROVIGNO 01/02/2020 07:54 141 Ammesso 2 D'ORONZO LUIGI CELLINO SAN MARCO 01/02/2020 09:42 136 Ammesso 3 ATTOLINI CESARE BRINDISI 01/02/2020 10:50 137 Ammesso 4 ARGENTIERI LUIGI FRANCAVILLA FONTANA 01/02/2020 16:19 143 Ammesso 5 FORLEO ALDO FRANCAVILLA FONTANA 01/02/2020 16:55 144 Ammesso 6 MEMMOLA RAFFAELE FRANCAVILLA FONTANA 01/02/2020 17:00 139 Ammesso 7 ARGENTIERI BARTOLOMEO FRANCAVILLA FONTANA 01/02/2020 17:39 178 Ammesso 8 COCO FRANCESCO FRANCAVILLA FONTANA 01/02/2020 18:04 146 Ammesso 9 D' OSTUNI COSIMO ERCHIE 01/02/2020 19:09 152 Ammesso 10 DE SANTIS CALOGERO ALTAMURA 01/02/2020 20:39 153 Ammesso 11 LUIGI FINO BITRITTO 01/02/2020 20:45 675 Ammesso 12 D'AMURI VINCENZO FRANCAVILLA FONTANA 02/02/2020 07:34 154 Ammesso 13 PETRACCA GIOVANNI MESAGNE 02/02/2020 18:45 156 Ammesso 14 SUMA VITO CEGLIE MESSAPICA 02/02/2020 19:03 157 Ammesso 15 SERIO VINCENZO ERCHIE 02/02/2020 19:18 179 Ammesso 16 MORLEO ROBERTO ERCHIE 02/02/2020 19:54 180 Ammesso 17 MONACO ROCCO CEGLIE MESSAPICA 03/02/2020 09:16 158 Ammesso 18 CIRASINO ENRICO MARIA OSTUNI 03/02/2020 09:59 260 Ammesso 19 D'ORONZO ALESSANDRO CELLINO SAN MARCO 03/02/2020 10:41 164 Ammesso 20 ERRICO MARCELLO SAN PANCRAZIO SALENTINO 03/02/2020 11:20 165 Ammesso 21 BRANCASI SALVATORE BARI 03/02/2020 11:47 166 Ammesso 22 LO RE MARIO SAN VITO -

Latiano - Mesagne - Cittadella) - BRINDISI + Z
-/'t.Pbnnoij'i AUTOLINEA: CISTERNINO - (Speziale - Montalbano) - OSTUNI - CAROVIGNO - S.VITO - (Latiano - Mesagne - Cittadella) - BRINDISI + Z. I. ORARI IN VIGORE DAL 15 GENNAIO 2018 (*) (*) (*) (*) (*) (*) Annuale Annuale Annuale Non Scol Annuale Annuale Non Scol L/V L/S L/V L/V L/V L/S L/S L/S L/S L/S L/S L/S L/S L/S L/S L/S L/V L/S Cisternino (P.za Navigatori) 4:10 5:05 6:10 6:10 6:20 6:20 6:35 6:35 7:20 8:15 Cisternino (Ist. Pedagogico) 4:20 5:15 6:20 6:20 6:45 6:45 7:30 8:25 6:30 6:30 Speziale 6:40 6:40 Montalbano 6:45 6:45 Ostuni (V.le A.Moro) Ostuni (V.le dello Sport) (perc. A) 5:40 6:25 6:25 6:55 7:35 7:45 Ostuni (V.le A.Moro) 5:42 6:27 6:27 6:57 7:37 7:47 Ostuni (P.za Italia) (perc. B) 4:35 5:30 5:45 6:35 6:35 6:30 6:30 7:00 7.00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:40 7:40 7:45 7:50 8:45 Carovigno (Via Extr. S.Sabina) (perc.A) 6:40 6:40 7:00 7:00 Carovigno (C.so Umberto) (perc.B) 4:45 5:40 5:55 6:45 6:45 7:10 7:10 7:10 7:10 7:10 7:10 7:05 7:05 7:50 7:50 7:55 8:00 S.Vito dei N.ni (Via Carovigno) (perc.A) 4:50 5:45 6:05 6:55 6:55 6:55 6:55 7:20 7:20 7:20 7:20 7:20 7:20 7:15 7:15 8:00 8:05 8:10 8.10 S.Vito dei N.ni (Via Francavilla) (perc. -

Comuni Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazios.No, San Pietrov.Co, Torchiarolo, Torre Santa Susanna
Comuni Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San PancrazioS.no, San PietroV.co, Torchiarolo, Torre Santa Susanna Prot. nr. 0010419 del 14/04/2017 Ai Responsabili degli Uffici di Piano dei Comuni Ambito Territoriale Brindisi Ambito Territoriale Francavilla Fontana Ambito Territoriale Ostuni Ambito Territoriale Taranto Ambito Territoriale Ginosa Ambito Territoriale Grottaglie Ambito Territoriale Manduria Ambito Territoriale Martina Franca Ambito Territoriale Massafra Ambito Territoriale Lecce Ambito Territoriale Campi Salentina Ambito Territoriale Casarano Ambito Territoriale Gagliano del Capo Ambito Territoriale Galatina Ambito Territoriale Gallipoli Ambito Territoriale Maglie Ambito Territoriale Martano Ambito Territoriale Nardò Ambito Territoriale Poggiardo Al Presidente Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia Al Direttore del Distretto Socio Sanitario 4 ASL BR LORO SEDI OGGETTO: Istituzione Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 77, comma 12 e 216, del D. Lgs. 50/2016. Si comunica che presso l’Ambito Territoriale è istituito l’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure dei contratti pubblici alla cui iscrizione è possibile manifestare interesse. Gli iscritti all’Albo saranno selezionati con l’adozione dei criteri di seguito descritti. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto ne possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o Ambito Territoriale 4 – Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732254 - fax 0831 777403 www.comune.mesagne.br.it - [email protected] Comuni Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San PancrazioS.no, San PietroV.co, Torchiarolo, Torre Santa Susanna amministrativo relativamente al medesimo. -

Relazione Geologica
Studio di geologia applicata e ambientale Dott. Geologo Massimilian BRANDI Carovigno (BR) : Via L. Capuana, 13 P.IVA 01807470743 Tel. 0831 991197 - 333 7325163 INDICE 1. PREMESSA 2. NOTE GEOGRAFICHE 3. CENNI GEOLOGICI 4. MORFOLOGIA 5. CALCARENITI QUATERNARIE 6. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE ED IDROGRAFICHE 6.1 Acque superficiali 6.2 Acque sotterranee 7. CALCOLO DELLA PERMEABILITA’ 8. DIMENSIONAMENTO DELLA TRINCEA DRENANTE PER LA PRATICA DELLA SUBIRRIGAZIONE. 9. DEPURAZIONE DELLE ACQUE DA PARTE DELLA ROCCIA 10. VULNERABILITA’ DELL’ ACQUIFERO PROFONDO 11. CONCLUSIONI ALLEGATI PREMESSA Nel Comune di Carovigno, in contrada Pietrafitta, la ditta AUTOSIMEONE s.r.l., proprietaria di un terreno posto a fregio della S.S.16 Carovigno-Ostuni, intende realizzare un capannone destinato alla vendita di autoveicoli nuovi ed usati. X: 17.6493 Y: 40.7069 Ubicazione area proprietà AUTOSIMEONE S.r.l. Tutto il ciclo delle attività, a meno di una parte relativa all’ esposizione autoveicoli, si svolgono all’ interno del capannone industriale a farsi, perfettemente isolato dall’ ambiente esterno. Tutte le aree antistanti i capannoni, le aree di accesso alla proprietà, quelle destinate a standard urbanistici e a parcheggio saranno realizzate con materiale drenante. Solo i lastrici solari, sui quali saranno parcheggiati alcuni autoveicoli in esposizione, saranno superfici scolanti. Per queste è prevista la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento, le cui acque meteoriche saranno opportunamente trattate e stoccate in un serbatoio a tenuta in attesa del riutilizzo. Solo la parte eccedente sarà applicata al terreno mediante una trincea drenante. L’ impianto di trattamento delle acque di dilavamento trattarà queste ultime in continuo mediante un impianto di tipo statico, grigliatura dissabbiatura e disoleatura. -

Carovigno 10 140X100
COMUNE DI CAROVIGNO ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE Liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di sindaco e di n. 16 consiglieri comunali, che avrà luogo DOMENICA 10 GIUGNO 2018 (Articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e articolo 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570) CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 1) Marco LOTTI 2) Massimo Vittorio LANZILOTTI 3) Salvatore ANCORA 4) Antonio PAGLIARA nato a Brindisi il 23 luglio 1989 nato a Taranto il 11 ottobre 1980 nato a Carovigno il 17 gennaio 1968 nato a Carovigno il 27 agosto 1951 LISTA COLLEGATA LISTE COLLEGATE LISTA COLLEGATA LISTE COLLEGATE Lista N. 1 Lista N. 2 Lista N. 3 Lista N. 4 Lista N. 5 Lista N. 6 Lista N. 7 Lista N. 8 Lista N. 9 Lista N. 10 Angelo Giorgio LANZILOTTI Francesco LEOCI Marzia BAGNULO Giovanna LANZILOTTI Giovanni ZIZZA (detto Gianni) Daniela BRANCASI Maira MARASCHIO Francesco DE BIASI Annamaria PETROSILLO Vittorio ZIZZA Nato a Cisternino il 19/06/1980 Nato a Mesagne il 21/04/1979 Nata a Brindisi il 28/08/1978 Nata a Carovigno il 18/09/1965 Nato a Ostuni il 22/05/1985 Nata a Ostuni il 12/05/1978 Nata a Brindisi il 29/05/1989 Nato a Carovigno il 20/06/1953 Nata a Brindisi il 24/02/1977 Nato a Ostuni il 27/01/1967 Natale PEPE (detto Italo) Annamaria in Flora SAPONARO Teresa BRANDI Carlo SCALERA Pietro CECERE (detto Piero) Pasquale CRETI’ Salvatore CARLUCCI Alessandra CICORIA Angelo Antonio CARLUCCI Michela BASILE Nato