“The Nature in the Fact” Archivi Del Tempo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

93 Fari Dismessi. Dall'abbandono Alla
Annali del Turismo, V, 2016, n.1 Edizioni Geoprogress FARI DISMESSI. DALL’ABBANDONO ALLA RIGENERAZIONE Antonietta Ivona Abstract Lighthouses decommissioned. From abandonment to regeneration. - The Italian legislation on cultural heritage introduced, a few years ago, the concept of enhancement and enjoyment of cultural heritage through the outsourcing of cultural assistance and hospitality services for the public. Particularly, the national Project "Valore Paese" of the Agenzia del Demanio is dedicated to lighthouses and it intends to encourage the promotion of the Italian public real estate through the synergy between the sectors of tourism, art and culture, economic and territorial cohesion. In this sense, the recovery of public assets owned by the State and local authorities has the possibility to be considered not only in terms of cost to the community, but also as a significant lever for territorial and social development, in a logic of public- private partnership. 1. I fari nel tempo Opere di ingegneria umana, ammantate di miti e leggende, i fari sono parte della storia della navigazione. Dai bagliori dei primi fuochi accesi sulle torri di avvistamento fino ai recenti dibattiti sul futuro della rete dei fari, essi hanno da sempre rappresentato anche luoghi identitari. I primi fari che la storia conosce non erano altro che falò di legna accatastata situati nei luoghi più pericolosi per segnalare la rotta ai naviganti. “I primi fuochi, che dovevano restare accesi tutta la notte, richiedevano continua cura: occorreva combustibile, sapienza tecnica, presenza costante dell’uomo” (Mariotti, 2013, p. 10). Con l’evolversi della navigazione commerciale, occorse sostituire i falò con strumenti di segnalazione più sicuri e, quindi, più potenti da ubicare nei porti lungo le nuove rotte commerciali. -

Riposo, Tempo E Spazio». Scipione Breislak, William Thomson E La Questione Del Quarzo
Rendiconti Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL Memorie di Scienze Fisiche e Naturali 135° (2017), Vol. XLI, Parte II, Tomo I, pp. 157-204 CLAUDIA CIPOLLONE* «Riposo, tempo e spazio». Scipione Breislak, William Thomson e la questione del quarzo «[…] la cristallisation peut également s’opérer par le moyen du feu comme par celui de l’eau, & que, dans toute matière liquide ou liquéfiée, nous verrons qu’il ne faut que du temps, de l’espace & du repos pour qu’elle se cristallise»1. Abstract – The question of the origin of the liquid and gaseous inclusions in quartz cry- stals was one of the eighteenth century’s major geological problems. Scipione Breislak (1750-1826), an Italian geologist, and William Thomson (1761-1806), an English mineralogist, did not accept the «umid» origin of quartz crystals in granitic rocks. Key words: liquid and gaseous inclusions, quartz crystals, granite 1. Storie e teorie della Terra Le ricostruzioni, in termini storici, delle vicissitudini naturali e umane elaborate nel corso del secolo dei Lumi nel tentativo di dare risposta al «problema della “for- mazione” del mondo» 2 documentano la coesistenza di modelli direzionali (la freccia del tempo) e modelli ciclici (il ciclo del tempo). L’idea di una trasformazione irre- versibile estesa a tutta la realtà fisica e naturale si intreccia come è noto a spiegazioni di carattere ciclico, proprie di un tempo circolare, periodico e ripetitivo 3. * Dottore di ricerca. Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio. E.mail: [email protected] 1 G.-L. -
Lions Club Bari Svevo Pasquale Montemurro
Lions Club Bari Svevo a cura di Pasquale Montemurro Concept, progetto grafico ed editing: Dott.ssa Mariangela Cassano - Bari • 2 • Con il patrocinio di • 3 • • 4 • PRESENTAZIONE Questa opera, curata dal nostro “Superlattivo” Presidente incoming Prof. Pasquale Montemurro, vuole essere un concre- to contributo del Lions Club Bari Svevo alla grande esposizione universale di EXPO 2015. All’inizio del nostro percorso lionistico del corrente anno, ci siamo dati alcuni obiettivi di ricerca, e dif- fusione, delle Eccellenze della nostra Puglia, al fine di sostenere i bisogni delle nostre genti. A mio avviso è questo il senso della nostra appartenenza al movimento internazionale dei Lions, che è movimento d’azione, prima che di conferenze, dibattiti, e face- zie conviviali. L’iniziativa del nostro Club è stata favorita dalla assonanza con lo stile ed il credo profondo del Governatore del Distretto 108AB, dr. Giovanni Ostuni, che ci ha incoraggiato e sostenuto, anche con la calorosa partecipazione alle attività promosse. Spero che questo modesto contributo possa costituire un se- gno da cui ripartire nella speranza di un rilancio e rinnovamento della nostra attività Lionistica. Grazie a tutti. Avv. Nicola Putignano Presidente Lions Club Bari Svevo 2014-2015 • 5 • • 6 • PREFAZIONE “SUPERLATTIVE ” di Puglia di Pasquale Montemurro* “Terra di grano, di olio, di vino” sono definizioni storica- mente attribuite alla Puglia, in sintonia con la storica Triade me- diterranea “armonizzata” dai governanti dell’antica Grecia che avevano ben compreso come appunto i cereali insieme all’ulivo ed alla vite assicurassero la disponibilità di «pane, olio e vino»; la scelta di coltivare cereali, ulivo e vite, era motivata dal fatto che tali specie di piante necessitano di poca acqua e quindi risul- tavano idonee al clima dei paesi del bacino del mediterraneo. -

COPERTINA SUPPLEMENTI 09.Ai
I LEMENT PP U 09 S IL CAPITALE CULTURALE Studies on the Value of Cultural Heritage eum Rivista fondata da Massimo Montella IL CAPITALE CULTURALE Studies on the Value of Cultural Heritage Supplementi 09 / 2019 eum Il capitale culturale Invernizzi, Lutz Klinkhammer, Federico Studies on the Value of Cultural Heritage Marazzi, Fabio Mariano, Aldo M. Morace, Supplementi 09, 2019 Raffaella Morselli, Olena Motuzenko, Paola Anna Maria Paniccia, Giuliano Pinto, Marco Pizzo, ISSN 2039-2362 (online) Carlo Pongetti, Adriano Prosperi, Bernardino ISBN 978-88-6056-622-5 Quattrociocchi, Margherita Rasulo, Mauro Renna, Orietta Rossi Pinelli, Roberto Sani, Mislav Direttore / Editor Simunic, Simonetta Stopponi, Michele Tamma, Pietro Petraroia Frank Vermeulen, Stefano Vitali Co-Direttori / Co-Editors Web Tommy D. Andersson, Elio Borgonovi, http://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult Rosanna Cioffi, Stefano Della Torre, Michela e-mail di Macco, Daniele Manacorda, Serge Noiret, [email protected] Tonino Pencarelli, Angelo R. Pupino, Girolamo Sciullo Editore / Publisher eum edizioni università di macerata, Coordinatore editoriale / Editorial Coordinator Corso della Repubblica, 51 – 62100 Macerata Giuseppe Capriotti tel (39) 733 258 6081 fax (39) 733 258 6086 Coordinatore tecnico / Managing Coordinator http://eum.unimc.it Pierluigi Feliciati [email protected] Comitato editoriale / Editorial board Layout editor Giuseppe Capriotti, Mara Cerquetti, Francesca Marzia Pelati Coltrinari, Patrizia Dragoni, Pierluigi Feliciati, Valeria Merola, Enrico Nicosia, Francesco Progetto -

MOLFETTA-Piano Performance 2018
CITTA’ DI MOLFETTA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020 Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. _236_ del _20/07/2018_ 1 INDICE SEZIONE 1. PRESENTAZIONE DEL PIANO SEZIONE 2. IDENTITA’ 2.1 Chi siamo 2.2 Cosa facciamo 2.3 Come operiamo SEZIONE 3. ANALISI DEL CONTESTO 3.1 Analisi del contesto esterno 3.1.1 Analisi del contesto esterno a livello generale 3.1.2 Analisi del contesto esterno a livello specifico 3.2 Analisi del contesto interno 3.2.1 Organizzazione e risorse umane 3.2.2 Risorse strumentali 3.2.3 Risorse economiche SEZIONE 4. OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI OPERATIVI SEZIONE 5. OBIETTIVI GESTIONALI SEZIONE 6. QUALITA’ DEI SERVIZI E TEMPI DEI PROCEDIMENTI SEZIONE 7: BENESSERE ORGANIZZATIVO ED AZIONI POSITIVE PER LA PARI OPPORTUNITA’ E LA PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI SEZIONE 8: PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SEZIONE 9: CONCLUSIONI 2 SEZIONE 1: PRESENTAZIONE DEL PIANO Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta). È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target . Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target ) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance , sia a livello organizzativo che a livello individuale. Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del decreto, il Piano è redatto con lo scopo di assicurare “la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance ”. -

Stampa Questo Articolo
CLAUDIA CIPOLLONE LA TOPOGRAFIA FISICA DELLA CAMPANIA (1798) DI SCIPIONE BREISLAK: LA STORIA DELLA TERRA E LA TEORIA DEI VULCANI «Something deep in our tradition requires, for intelligibility itself, both the arrow of historical uniqueness and the cycle of timeless immanence – and nature says yes to both» (Gould, 1987, p. 200). Freccia e ciclo, fuoco e acqua nella storia della Terra. – Per quasi un secolo, tra la metà del Settecento e la prima metà dell’Ottocento, l’osservazione delle colonne del «Tempio di Serapide» a Pozzuoli perforate dai mitili, fenomeno che documenta le oscillazioni del livello marino, contribuisce in modo progressivo ad orientare il dibattito scientifico verso una concezione dinamica del globo terrestre. Si trattava di una teoria, è stato recentemente osservato, che avrebbe costituito il presupposto per estendere il concetto di storicità a tutta la realtà fisica e naturale (Ciancio, 2009, pp. 7, 9). Entro tale contesto, e partendo dalle medesime osservazioni, si colloca, sia pure con alcune incertezze e contraddizioni che peraltro sono proprie dei tempi, l’opera che qui presentiamo dello scolopio Scipione Breislak, geologo e naturalista1, allievo al Collegio 1 Di famiglia italo-svedese Breislak nacque a Roma il 16 agosto 1750. Scolopio dal 1765, a partire dal 1773 insegnò in diversi collegi dell’Ordine dei Chierici Regolari delle Scuole Pie (Albano, Ragusa in Dalmazia, Urbino, Roma, Nola). Nel 1788 ricevette l’incarico di professore di fisica presso l’Accademia militare della Nunziatella di Napoli e venne nominato direttore della fabbrica di allume della Solfatara di Pozzuoli. Nel 1798 aderì alla Repubblica romana (Commissario nel Dipartimento del Trasimeno, Ministro delle Finanze). -

Mise En Page 1
C IESM Workshop Monographs Marine geo-hazards in the Mediterranean Nicosia,2-5February2011 CIESM Workshop Monographs ◊ 42. To be cited as: CIESM, 2011. Marine geo-hazards in the Mediterranean. N° 42 in CIESM Workshop Monographs [F. Briand Ed.], 192 pages, Monaco. This collection offers a broad range of titles in the marine sciences, with a particular focus on emerging issues. The Monographs do not aim to present state-of-the-art reviews; they reflect the latest thinking of researchers gathered at CIESM invitation to assess existing knowledge, confront their hypotheses and perspectives, and to identify the most interesting paths for future action. A collection founded and edited by Frédéric Briand. Publisher : CIESM, 16 bd de Suisse, MC-98000, Monaco. MARINE GEO-HAZARDS IN THE MEDITERRANEAN - Nicosia,2-5February 2011 CONTENTS I-EXECUTIVE SUMMARY ................................................7 1. Introduction 2. Volcanoes 2.1 Tyrrhenian Sea 2.2 Aegean Sea 2.3 Gaps of knowledge related to volcanic activity 3. Earthquakes 3.1 Geodynamics and seismo-tectonics 3.2 Distribution – short history 3.3 Seismic parameter determination – data bases 3.4 Associated marine hazards 4. Submarine landslides 4.1 Slope movement stages and physical mechanisms 4.2 Observation, detection and precursory evidence 4.3 Gaps of knowledge associated with sedimentary mass movements 5. Tsunamis 6. Risk reduction: preparedness and mitigation 7. Recommendations II – WORKSHOP COMMUNICATIONS - Geo-hazards and the Mediterranean Sea. J.Mascle.............................................................23 • Eastern Mediterranean - Marine geohazards associated with active geological processes along the Hellenic Arc and Back-Arc region. D.Sakellariou ........................................................27 3 CIESM Workshop Monographs n°42 MARINE GEO-HAZARDS IN THE MEDITERRANEAN - Nicosia,2-5February 2011 - Potential tsunamigenic sources in the Eastern Mediterranean and a decision matrix for a tsunami early warning system. -

Rezzonico Tortorelli
‘La veneranda ruggine dei secoli’ C. C. Della Torre di Rezzonico. La storia naturale tra estetica del pittoresco e tutela del patrimonio culturale negli appunti di viaggio di un ‘padano’ al Sud. Maria Toscano 1.‘Un nuovo teatro di cose e di riflessioni’. I viaggi di Rezzonico come percorso di formazione Carlo Castone della Torre di Rezzonico (1742-1795) 1 era figlio dell’erudito Anton Gioseffo, artefice di un’autorevole traduzione di Plinio. 2 Trasferitosi dalla natia Como a Parma con il padre, frattanto separatosi dalla madre, dopo l’elezione, nel 1758, al soglio pontificio di suo cugino Carlo Rezzonico (Clemente XIII) nel 1758 per intercessione di quest’ultimo entrò a far parte della scuola dei paggi di Napoli, città dove rimase fino al 1761 avendo modo di arricchire la sua formazione culturale, e soprattutto la conoscenza del greco. Alla morte del Frugoni, nel 1768, Carlo Castone lo sostituì nell’incarico di segretario perpetuo dell’accademia delle belle arti di Parma. Fortemente influenzato dal Bettinelli e dallo stesso Frugoni nell’ambito della pratica letteraria, le sue teorie estetiche risentono invece dell’influenza del Condillac, a Parma dal 1758 al 1767; esse risultano infatti improntate ad una chiara impostazione sensista. 3 Rezzonico nutriva un interesse non banale anche per le scienze ed in particolare per la storia naturale e la litologia, materia nella quale non mancano osservazioni intelligenti e competenti nei suoi diari di viaggio. Al di là dell’apparente frammentazione, le sue ricerche trovano una continuità forte nel -

James Hutton's Reputation Among Geologists in the Late Eighteenth and Nineteenth Centuries
The Geological Society of America Memoir 216 Revising the Revisions: James Hutton’s Reputation among Geologists in the Late Eighteenth and Nineteenth Centuries A. M. Celâl Şengör* İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi, Jeoloji Bölümü, Ayazağa 34469 İstanbul, Turkey ABSTRACT A recent fad in the historiography of geology is to consider the Scottish polymath James Hutton’s Theory of the Earth the last of the “theories of the earth” genre of publications that had begun developing in the seventeenth century and to regard it as something behind the times already in the late eighteenth century and which was subsequently remembered only because some later geologists, particularly Hutton’s countryman Sir Archibald Geikie, found it convenient to represent it as a precursor of the prevailing opinions of the day. By contrast, the available documentation, pub- lished and unpublished, shows that Hutton’s theory was considered as something completely new by his contemporaries, very different from anything that preceded it, whether they agreed with him or not, and that it was widely discussed both in his own country and abroad—from St. Petersburg through Europe to New York. By the end of the third decade in the nineteenth century, many very respectable geologists began seeing in him “the father of modern geology” even before Sir Archibald was born (in 1835). Before long, even popular books on geology and general encyclopedias began spreading the same conviction. A review of the geological literature of the late eighteenth and the nineteenth centuries shows that Hutton was not only remembered, but his ideas were in fact considered part of the current science and discussed accord- ingly. -

Le ''Cœur, Le Talent Et La Doctrine'' De Pietro Giordani Dans La Formation De Giacomo Leopardi
Le ”cœur, le talent et la doctrine” de Pietro Giordani dans la formation de Giacomo Leopardi Mario Fernando Franco To cite this version: Mario Fernando Franco. Le ”cœur, le talent et la doctrine” de Pietro Giordani dans la formation de Giacomo Leopardi. Littératures. Université Paul Valéry - Montpellier III; Université de la Manouba (Tunisie), 2014. Français. NNT : 2014MON30076. tel-01241290 HAL Id: tel-01241290 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01241290 Submitted on 17 Dec 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. ! Délivré par UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3 Préparée au sein de l’école doctorale ED 58 (Langues, Littératures, Cultures, Civilisations) Et de l’unité de recherche LLACS (Langues, Littératures, Arts et Cultures des Suds) Spécialité : DOCTORAT ÉTUDES ROMANES, Spécialité Études italiennes Présentée par Mario Fernando FRANCO TITRE DE LA THESE Le «cœur, le talent et la doctrine» de Giacomo Leopardi dans la formation de Pietro Giordani Soutenue le Mardi 9 décembre 2014 devant le jury composé de : Mme Myriam CARMINATI, Professeur, Université Paul-Valéry Montpellier 3, Co-directrice Mme Rawdha RAZGALLAH, Professeur, Université de Carthage, Tunis, Logo !établissement ! Co-directrice M. Ahmed SOMAI, Professeur, Université La Manouba, Tunis, Président Mme Silvia FINZI, Professeur, Université La Manouba, Tunis, Rapporteur M. -
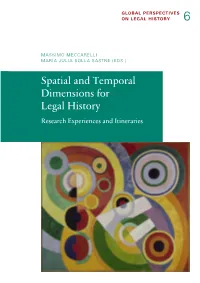
Spatial and Temporal Dimensions for Legal History. Research
GLOBAL PERSPECTIVES ON LEGAL HISTORY 6 MASSIMO MECCARELLI MARÍA JULIA SOLLA SASTRE (EDS.) Spatial and Temporal Dimensions for Legal History Research Experiences and Itineraries GLOBAL PERSPECTIVES ON LEGAL HISTORY 6 Global Perspectives on Legal History A Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication http://global.rg.mpg.de Series Editors: Thomas Duve, Stefan Vogenauer Volume 6 Global Perspectives on Legal History is a book series edited and published by the Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main, Germany. As its title suggests, the series is designed to advance the scholarly research of legal historians worldwide who seek to transcend the established boundaries of national legal scholarship that typically sets the focus on a single, dominant modus of normativity and law. The series aims to privilege studies dedicated to reconstructing the historical evolution of normativity from a global perspective. It includes monographs, editions of sources, and collaborative works. All titles in the series are available both as premium print-on-demand and in the open-access format. MASSIMO MECCARELLI MARÍA JULIA SOLLA SASTRE (EDS.) Spatial and Temporal Dimensions for Legal History Research Experiences and Itineraries MAX PLANCK INSTITUTE FOR EUROPEAN LEGAL HISTORY 2016 ISBN 978-3-944773-05-6 eISBN 978-3-944773-15-5 ISSN 2196-9752 First published in 2016 Published by Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main Printed in Germany by epubli, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlin -

Guide of Lighthouses and Semaphores
Guide of lighthouses and semaphores TM References Guide of lighthouses and semaphores. Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (France), Agence pour la protection et l’Aménagement du Littoral en Tunisie (Tunisia), Société pour la Protection de la Nature au Liban (Lebanon), Municipality of Tyre (Lebanon). Legal note These guidelines have been written under the MED-PHARES project "Integrated Management Strategies to develop the heritage of lighthouses, semaphore stations and maritime signaling systems of the Mediterranean", funded by the EU within the framework of the ENPI CBC Mediterranean Sea Basin. The contents of this document are the sole responsibility of the beneficiary of the project and partners and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or of the management structures of the Programme. Guide of lighthouses and semaphores Italy France Tunisia Lebanon Preface The MED-PHARES project is a cross-border cooperation project, funded by the European Union through the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) for the Mediterranean Maritime Basin (ENPI- CBC MED). The project brings together countries of North, South and East of the Mediterranean area with the Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna (beneficiary of the project - Italy) and four other partners: Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (France), Agence pour la protection et l'Aménagement du Littoral en Tunisie (Tunisia), Société pour la Protection de la Nature au Liban and the Municipality of Tyre (Lebanon). The project aims to develop a model that is applicable in every country of the Mediterranean area, with the purpose of emphasizing the unique material and immaterial features of this heritage including the coastal areas with the presence of lighthouses and semaphore.