561 San Giovanni in Fiore.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tommaso Astorino Attività Di Libero Professionista Come Ingegnere Civile
Curriculum Vitae Tommaso Astorino INFORMAZIONI PERSONALI Tommaso Astorino Via Luchino Visconti , snc, 87050, Rovito, Italia 3293763549 [email protected] [email protected] C.F. STRTMS79E22L781Q P.iva 03085960783 Sesso Maschile | Data di nascita 22/05/1979 | Nazionalità Italiana POSIZIONE RICOPERTA Attività di Libero Professionista come Ingegnere Civile ESPERIENZA PROFESSIONALE 21/01/2009-attualmente Servizi attinenti all'ingegneria civile e ambientale per Pubbliche Amministrazioni, Privati, e Imprese Studio Ing. Tommaso Astorino Via Luchino Visconti , snc, 87050 Rovito, Italia Attivita svolte ▪ Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e di Responsabile dei Lavori attività di competenza della funzione O.OA.AOA di Telecom Regione Calabria-Puglia Basilicata e Campania di TELECOM ITALIA." Anno 2015- 2016- 2017; Mise- Invitalia –progetti BUL E BL –Regioni Calabria-Basilicata-Campania- FONDI FESR; Committente: Telecom Italia-ESYS S.r.l ▪ Supporto al RUP per lavori di riqualificazione ed incremento delle prestazioni energetiche della struttura comunale adibita a residenza sanitaria assistenziale denominata “ Villa Silvia” comune di Altilia CS” anno 2015; Committente: Amministrazione Comunale di Altilia (CS) ▪ Progettazione strutturale “Ristrutturazione chiesa San Bartolomeo e riconversione in sala polifunzionale e centro espositivo arte orafa calabrese” Comune di San Pietro in Amantea (CS) (Importo dei lavori € 450.877,05) anno 2015;Regione Calabria-Fondi PISL; Committente: Amministrazione Comunale di San Pietro in Amantea (CS) ▪ Progettazione strutturale” Realizzazione Centro di Aggregazione giovanile , con annesse green way (percorso trekking e Mountain bike) e osservatori del paesaggio" Comune di San Pietro in Amantea (CS) (Importo dei lavori 411.000,00) anno 2015 Regione Calabria-Fondi PISL; Committente: Amministrazione Comunale di San Pietro in Amantea (CS) ▪ Calcolazione strutturale, per “Intervento di Miglioramento Sismico Sede C.O.C P/zza Collina Castello, Bisignano”(CS). -

F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – L.N.D. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE Campionato 3ª Categoria – �Girone C� S.S
F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – L.N.D. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE Campionato 3ª Categoria – Girone C s.s. 2018/2019 1^ Giornata Andata 2^ Giornata Andata Domenica 11 Novembre 2018 ore 14:30 Domenica 18 Novembre 2018 ore 14.30 ATLETICO BELVEDERE BELCASTRO REAL COTRONEI CASABONA SPORT da definire LA SAVELLESE MESORACA CALCIO CASTELLESE CALCIO PUHERIU CALCIO SPORTING ROCCA CASTELLESE CALCIO MESORACA CALCIO SPORTING ROCCA PUHERIU CALCIO REAL COTRONEI BELCASTRO LA SAVELLESE CASABONA SPORT REAL VACCARIZZO REAL VACCARIZZO ATLETICO BELVEDERE 3^ Giornata Andata 4^ Giornata Andata Domenica 25 Novembre2018 ore 14:30 Domenica 2 Dicembre 2018 ore 14:30 LA SAVELLESE ATLETICO BELVEDERE CASTELLESE CALCIO REAL COTRONEI SPORTING ROCCA BELCASTRO MESORACA CALCIO CASABONA SPORT PUHERIU CALCIO MESORACA CALCIO BELCASTRO PUHERIU CALCIO CASABONA SPORT CASTELLESE CALCIO ATLETICO BELVEDERE SPORTING ROCCA REAL COTRONEI REAL VACCARIZZO REAL VACCARIZZO LA SAVELLESE 5^ Giornata Andata 6^ Giornata Andata Domenica 9 Dicembre 2018 ore 14:30 Domenica 16 Dicembre 2018 ore 14:30 SPORTING ROCCA LA SAVELLESE MESORACA CALCIO CASTELLESE CALCIO PUHERIU CALCIO ATLETICO BELVEDERE BELCASTRO REAL COTRONEI CASABONA SPORT BELCASTRO ATLETICO BELVEDERE CASABONA SPORT REAL COTRONEI MESORACA CALCIO LA SAVELLESE PUHERIU CALCIO CASTELLESE CALCIO REAL VACCARIZZO REAL VACCARIZZO SPORTING ROCCA 7^ Giornata Andata 8^ Giornata Andata Domenica 13 Gennaio 2019 ore 14:30 Domenica 20 Gennaio 2019 ore 14:30 PUHERIU CALCIO SPORTING ROCCA BELCASTRO MESORACA CALCIO CASABONA SPORT LA SAVELLESE ATLETICO BELVEDERE CASTELLESE CALCIO REAL COTRONEI ATLETICO BELVEDERE LA SAVELLESE REAL COTRONEI CASTELLESE CALCIO BELCASTRO SPORTING ROCCA CASABONA SPORT sabato 19/1 – 14:30 MESORACA CALCIO REAL VACCARIZZO PUHERIU CALCIO REAL VACCARIZZO ore 10:00 9^ Giornata Andata Domenica 27 Gennaio 2019 ore 14:30 CASABONA SPORT PUHERIU CALCIO REAL COTRONEI SPORTING ROCCA CASTELLESE CALCIO LA SAVELLESE MESORACA CALCIO ATLETICO BELVEDERE REAL VACCARIZZO BELCASTRO F.I.G.C. -

CS) 2020-01-14 16:45:59 Acquaformosa 780010600
Programmazione unica triennale nazionale 2018-2020, Avviso Pubblico “Aggiornamento Piano regionale triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica”. (DDG N13320 del 29/10/2019). Elenco istanze di partecipazione acquisite mediante la Piattaforma Regionale di Acquisizione Domande degli Avvisi - Calabria (P.R.A.D.A.-C.) come pevisto all’art. 4.2 dell’Avviso N. ID istanza Ente Data richiesta Ora richiesta Localizzazione Cod Edificio 1 52 Comune di Acquaformosa (CS) 2020-01-14 16:45:59 Acquaformosa 780010600 2 162 Comune di Albidona (CS) 2020-01-14 13:40:44 Albidona 780060751 3 233 Comune di Amato (CZ) 2020-01-15 14:59:21 Amato 790040978 4 246 Comune di Anoia (RC) 2020-01-15 11:53:47 Anoia 800030458 5 86 Comune di Aprigliano (CS) 2020-01-15 13:40:11 Aprigliano 780120068 6 182 Comune di Bagnara Calabra (RC) 2020-01-15 11:52:04 Bagnara Calabra 800071131 7 88 Comune di Belmonte Calabro (CS) 2020-01-14 20:29:26 Belmonte Calabro 780130070 8 85 Comune di Belmonte Calabro (CS) 2020-01-14 20:24:58 Belmonte Calabro 780130073 9 187 Comune di Belsito (CS) 2020-01-14 18:40:38 Belsito 780140001 10 119 Comune di Bianchi (CS) 2020-01-15 21:22:19 Bianchi 780160800 11 206 Comune di Bisignano (CS) 2020-01-15 17:15:24 Bisignano 780170475 12 248 Comune di Bisignano (CS) 2020-01-15 13:38:16 Bisignano 780170798 13 215 Comune di Bisignano (CS) 2020-01-15 13:18:45 Bisignano 780170479 14 244 Comune di Bisignano (CS) 2020-01-15 15:52:18 Bisignano 780170086 15 117 Comune di Bocchigliero (CS) 2020-01-14 16:50:48 Bocchigliero 780180093 16 118 Comune -

06/11/2020 Determina-N-63-Liquidazione
COPIA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 63 Del 24/06/2020 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI EDUCATORI- OSS – OGGETTO: FISIOTERAPISTI – PSICOLOGI- PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019. L’anno DUEMILAVENTI il giorno 24, del mese di GIUGNO, nella Sede del Co.Pro.S.S., il Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione: Il DIRIGENTE PREMESSO CHE: Con determina n. 62 del 24/06/2020 è stata impegnata al capitolo 12011 del redigendo bilancio 2020 –residui passivi del bilancio 2019 - impegno n. 2019/08, la somma di € € 85.293,32 per il pagamento delle prestazioni integrative trimestre aprile/giugno 2019 – del progetto Home Care Premium 2017; Dai controlli effettuati risultano le seguenti ore di servizio svolto: - N. 1118 ore Fisioterapia – costo orario € 20,00 – per un importo pari ad €. 22.360,00; - N. 765,00 ore Psicologo – costo orario € 20,00 – per un importo pari ad €. 15.299,47; - N. 27 ore recupero Psicologo mese di Ottobre 2017 -– costo orario € 20,00 – per un importo pari ad €. 533,85 - N. 687 ore Educatore – costo orario € 20,00 – per un importo pari ad €. 13.740,00; - N. 1.668 ore OSS – costo orario € 20,00 – per un importo pari ad €. 33.360,00; per un importo complessivo pari ad € 85.293,32; CONSIDERATO CHE: Sono state ricevute mediante il sistema di interscambio le fatturazioni elettroniche relative ai seguenti professionisti; - Laura DURAZZI – EDUCATORE PROFESSIONALE; - Carmela VINCENZO – EDUCATORE PROFESSIONALE; - Concetta LACQUANITI – EDUCATORE PROFESSIONALE; - Angelo -

Elenco Attraversamenti REV00
Codifica ELENCO OPERE ATTRAVERSATE EE231136C1BFX00016 Rev. 00 Pag. 1 di 3 del 10/11/2010 RIFACIMENTO ELETTRODOTTO 150 kV “CALUSIA - CATANZARO” e connessione in modalità entra – esce della Nuova ST/NE “380 / 150 kV Belcastro” ELENCO OPERE ATTRAVERSATE Allegato al Piano Tecnico delle Opere Storia delle revisioni Rev. 00 del 10/11/10 Prima emissione Elaborato Verificato Approvato INSE S.R.L. G. ACONE C. MAIO A. LIMONE AOT - UPRI - LINEE AOT - UPRI - LINEE AOT - UPRI - LINEE Questo documento contiene informazioni di proprietà di Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l’esplicito consenso di Terna SpA Codifica EE231136C1BFX00016 ELENCO OPERE ATTRAVERSATE Rev. 00 Pag. 2 di 3 del 10/11/2010 n. Opera Attraversata Ente Gestore Comune 1 S.P. per Cotronei Amm. Prov.le di Crotone Caccuri 2 Linea 150 kV Cal. – Mesoraca – TMPG3 Terna S.p.A. Caccuri 3 Strada Comunale Amm. Comunale Caccuri Caccuri 4 Linea BT Enel Distribuzione Calabria Caccuri 5 S.P. - variante Amm. Prov.le di Crotone Caccuri 6 Cavo aereo BT Enel Distribuzione Calabria Caccuri 7 Strada Privata Enel ENEL Cotronei 8 Fiume Neto Amm. Prov.le di Crotone Cotronei 9 Linea BT Enel Distribuzione Calabria Cotronei 10 Fiume Neto Amm. Prov.le di Crotone Cotronei 11 Fosso Rivuti Amm. Prov.le di Crotone Cotronei 12 S.S. N° 109 ANAS Cotronei 13 Linea BT Enel Distribuzione Calabria Cotronei 14 Strada Comunale Amm. Prov.le di Crotone Cotronei 15 Linea MT Enel Distribuzione Calabria Cotronei 16 Strada Comunale Amm. -

P.S.C. Piano Strutturale Comunale (L.R
COMUNE DI VILLAPIANA (PROVINCIA DI COSENZA) P.S.C. PIANO STRUTTURALE COMUNALE (L.R. 16 Aprile 2002 N. 19 - art. 20) RELAZIONE GENERALE Sindaco Vice sindaco Segretario comunale Dott. Luigi BRIA Assessore all'Urbanistica D.ssa Loredana LATRONICO Roberto RIZZUTO Responsabile del procedimento Arch. Luigi Cesare Maria MILILLO Gruppo di progettazione: Urbanistica: Arch. Luigi Cesare Maria MILILLO Geologica: Geol. Maria Luisa CAMPISANO Geol. Maria Antonella RUSSO Agronomica: Agr. Vincenzo BIANCHIMANO Consulente per l'informatizzazione del piano in ambiente GIS: Ing. Francesco Antonio DIODATI TAVOLA N° SCALA ADOZIONE DELIBERA R1 COMUNE DI PIANO STRUTTURALE RELAZIONE GENERALE VILLAPIANA (Provincia di Cosenza) COMUNALE (PSC) PIANO STRUTTURALE COMUNALE RELAZIONE GENERALE QUADRO CONOSCITIVO PRESENTAZIONE 1. SISTEMA AMBIENTALE 1.1 Integrità fisica del territorio 1.1.1 Rischio di inondazione 1.1.2 Rischio frana 1.1.3 Rischio di erosione costiera 1.1.4 Rischio di incendio 1.1.5 Rischio sismico 1.1.6 Cambiamenti climatici 1.1.7 Aree di ammassamento per usi di protezione civile 1.2 Risorse naturali e paesaggistiche 1.2.1 Risorse paesaggistiche 1.2.1.1 Paesaggio ecologico prevalente 1.2.1.2 Paesaggio ambientale prevalente 1.2.1.3 Paesaggi rurali con valore ecologico 1.2.2 Valenza costiera 1.2.3 Aree tutelate 1.2.3.1 Parchi e riserve 1.2.3.2 Altri ambiti di tutela 1.2.3.3 I Comprensori paesaggistici 1.2.3.4 La rete ecologica regionale 1.2.4 Risorse forestali PSC – V001 Rev. definitivo Arch. Luigi Cesare Maria MILILLO 1 COMUNE DI PIANO STRUTTURALE RELAZIONE GENERALE VILLAPIANA (Provincia di Cosenza) COMUNALE (PSC) 1.2.5 Risorse agricole 1.2.6 Terre civiche 1.2.7 Attività estrattiva 1.3 Risorse storico-culturali 2. -

Casella Postale 53
53 Giugno 2000 - Mensile d’informazione e cultura - Anno VI Numero 53 CASELLA POSTALE 53 Arriviamo alla nostra pausa estiva: il giornale presenta il culmine della socialità, per raffor- ne ben oltre i nostri piccoli steccati territoria- tornerà nel mese di settembre. Questo ultimo zare gli affetti, l’amicizia. li. numero lo abbiamo chiuso a tempi di record, Ci auguriamo che il periodo coincida con una Casella Postale 53: vi aspettiamo in tanti e... per almeno due importanti motivi: spedire ve- soddisfacente politica dell’accoglienza in pae- buone vacanze. locemente il giornale in modo che arrivi a de- se: con un minimo di iniziative (musicali, tea- stinazione prima delle eventuali ferie dei letto- trali, ecc.); con i servizi funzionali (acqua, ver- P.S. - Come al solito fate in modo di farci per- ri, e poi perchè nella piccola redazione del Cen- de, r.s.u., ecc.). Come ci auguriamo che la sta- venire nuovi nominativi dove poter spedire il tro Sociale il caldo è diventato insopportabile. gione turistica in Sila porti qualche quattrino giornale. Questo ultimo numero sarà stampato Due mesi di tranquillo riposo, lontani dai ritmi agli operatori, riuscendo a recuperare una par- con una tiratura superiore, in modo da diffon- richiesti dal giornale, ci serviranno per rilas- te dei turisti persi negli ultimi anni. dere qualche copia durante il mese di luglio e sarci, per poter leggere qualche libro, per in- Cotroneinforma organizzerà un concerto pro- agosto. contrare e stare insieme ai tanti nostri amici e babilmente dopo ferragosto, come al solito nel- parenti, studenti e lavoratori che ritorneranno l’anfiteatro del Centro Sociale, con qualche per l’estate. -

1 Grimaldi Antonio 18/02/1967 Mesoraca 6 C.C.N.I. Comune Cotronei No 2 Arabia Raffaela 16/11/1970 Strongoli 12 6 C.C.N.I
GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTI SCUOLA PRIMARIA ASPIRANTI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROVINCIALE 2016-2017 PUNTI PUNTI COMUNE ALTRI COMUNE SPEZZ. N COGNOME NOME DATA NASCITA SEDE TIT. RICONGIUNGIM PREC. TIPO POSTO COMU RICONGIUNGIMENTO ORARIO ENTO NI 1 GRIMALDI ANTONIO 18/02/1967 MESORACA 6 C.C.N.I. COMUNE COTRONEI NO 2 ARABIA RAFFAELA 16/11/1970 STRONGOLI 12 6 C.C.N.I. SOSTEGNO CUTRO NO 3 AMATO MARIA ASSUNTA 13/08/1977 CUTULI CROTONE 12 C.C.N.I. COMUNE ROCCA DI NETO NO 4 VONA FRANCESCO 11/03/1961 PAPANICE 6 0 C.C.N.I. COMUNE PETILIA P.STRO NO 5 CAROLEI FRANCESCA 08/07/1974 STRONGOLI 12 C.C.N.I. SOSTEGNO - COMUNE CROTONE SI 6 SCHIPANI TERESA 20/06/1961 SCANDALE 6 0 C.C.N.I. SOSTEGNO MESORACA SI 7 AMANTEA ANNA RITA 08/06/1964 CRUCOLI 6 0 C.C.N.I. COMUNE CIRO' NO 8 IERARDI ANNA 25/07/1966 STRONGOLI 6 0 C.C.N.I. SOSTEGNO - COMUNE PETILIA P.STRO NO 9 COLOSIMO FRANCESCA 18/12/1975 K. WOJTYLA ISOLA C.R. 16 10 C.C.N.I. INGLESE - COMUNE MESORACA NO 10 MICILLO BELINDA 20/03/1976 STRONGOLI 13 7 C.C.N.I. COMUNE - INGLESE CIRO' MARINA NO 11 FONTE CLAUDIA 03/10/1982 PAPANICE 13 7 C.C.N.I. COMUNE ROCCABERNARDA NO 12 FILICE ROSA 21/04/1975 G. DA FIORE ISOLA C.R. 18 12 COMUNE MESORACA SI 13 MESORACA SILVANA 28/02/1965 STRONGOLI 6 0 SOSTEGNO CUTRO NO 14 PORCHIA ERMELINDA 19/05/1964 G. -
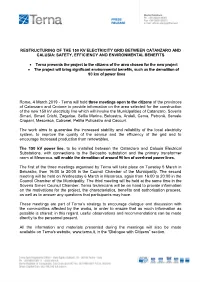
Restructuring of the 150 Kv Electricity Grid Between Catanzaro and Calusia: Safety, Efficiency and Environmental Benefits
RESTRUCTURING OF THE 150 KV ELECTRICITY GRID BETWEEN CATANZARO AND CALUSIA: SAFETY, EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL BENEFITS • Terna presents the project to the citizens of the area chosen for the new project • The project will bring significant environmental benefits, such as the demolition of 90 km of power lines Rome, 4 March 2019 - Terna will hold three meetings open to the citizens of the provinces of Catanzaro and Crotone to provide information on the area selected for the construction of the new 150 kV electricity line which will involve the Municipalities of Catanzaro, Soveria Simeri, Simeri Crichi, Zagarise, Sellia Marina, Belcastro, Andali, Cerva, Petronà, Sersale Cropani, Mesoraca, Cotronei, Petilia Policastro and Caccuri. The work aims to guarantee the increased stability and reliability of the local electricity system, to improve the quality of the service and the efficiency of the grid and to encourage increased production from renewables. The 150 kV power line, to be installed between the Catanzaro and Calusia Electrical Substations, with connections to the Belcastro substation and the primary transformer room at Mesoraca, will enable the demolition of around 90 km of overhead power lines. The first of the three meetings organised by Terna will take place on Tuesday 5 March in Belcastro, from 16:00 to 20:00 in the Council Chamber of the Municipality. The second meeting will be held on Wednesday 6 March in Mesoraca, again from 16:00 to 20:00 in the Council Chamber of the Municipality. The third meeting will be held at the same time in the Soveria Simeri Council Chamber. Terna technicians will be on hand to provide information on the motivations for the project, the characteristics, benefits and authorisation process, as well as to answer any questions that participants may have. -

PAL Energia Della Provincia Di Crotone
INQUADRAMENTO TERRITORIALE IL TERRITORIO Superficie (espressa in Km2) La Provincia di Crotone, istituita solamente nel 1993, si estende su una superficie di 1716,75 km2 e si compone di 27 Comuni, 1 Comunità Montana La Comunità Montana dell’Alto Crotonese conta circa 36.000 abitanti ed ha una superficie di 588 Kmq; si e- stende dalle pendici della Sila Grande al Mar Jonio e racchiude gran parte dei comuni della provincia e preci- samente: Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Melissa, Pallagorio, San Nicola Dell’Alto, Savelli, Strongoli, Umbriatico e Verzino. La sua dimensione è estremamente contenuta e si distribuisce tra il mare, entroterra e montagna. La dimensione territoriale dei comuni è variabile, si passa da comuni con una superficie inferiore ai 7,83 km2 (San Nicola dell’Alto) a comuni con una estensione superiore ai 179 km2 (Crotone). Altimetria Il territorio crotonese si presenta nel modo più svariato, estendendosi dal litorale ionico, che tocca il capoluogo di provincia (Crotone) nonché diversi comuni (da sud verso nord: Cutro, Isola Capo Rizzuto, Strongoli, Melissa, Cirò Marina, Cirò, Crucoli) e si inoltra sino alle punte più alte dei promontori della Sila (Cotronei, Savelli, Ca- stelsilano). Nel passaggio marina-collina-montagna, si alternano scenari naturali incantevoli. In tabella si riportano i valori della superficie suddivisa per fasce altimetrica e si nota meglio il passaggio da fa- sce marittime (inferiore a 300 metri) alle punte montane (900-1200 metri). Superficie Percentuale -

Comune Di Pallagorio Provincia Di Crotone BASHKIA E PUHERIUT – Provinça E Kutronit
Comune di Pallagorio Provincia di Crotone BASHKIA E PUHERIUT – Provinça e Kutronit Tel. 0962/761037 Fax. 0962/761444 Prot. n. 1680 del 08.05.2014 ORDINANZA n. 08 del 07.05.2014 Oggetto: Affidamento in via temporanea ed urgente del servizio di igiene pubblica urbana-raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale a seguito di revoca del contratto d’appalto alla ditta DE.Ri.Co. New Geo s.r.l. con sede in Cirò Marina alla Via Togliatti, n. 10. I L S I N D A C O PREMESSO CHE: -Il Comune di Pallagorio effettua il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani così come definiti dalle lettere a), b) e d), comma 2 dell’art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, sull’intero territorio comunale; -Tale servizio costituisce attività di pubblico interesse; -Lo svolgimento del servizio era stato affidato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, alla ditta DE.RI.Co. New Geo s.rl. con sede in Cirò Marina alla Via Togliatti, n. 10, con determina dirigenziale n. 08 del 23.01.2009; -La prefettura di Crotone con nota prot. n. 7883/2014/Area 1/AM, acclarata agli atti di questo Comune al prot. n. 1512 del 24.4.2014, comunicava informazione antimafia interdittiva nei confronti della società DE.RI.Co. New Geo s.r.l. con sede in Cirò Marina, Via Togliatti, n. 10, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; -A seguito della comunicazione della Prefettura di Crotone, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Geom. -

AVVISO PUBBLICO Fondo Non Autosufficienza
Belvedere di Spinello - Crotone - Cutro - Isola Capo Rizzuto - Rocca di Neto - S. Mauro Marchesato – Scandale AVVISO PUBBLICO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEI COMUNI DI CUTRO, SCANDALE, SAN MAURO MARCHESATO, BELVEDERE DI SPINELLO E ROCCA DI NETO. Fondo non autosufficienza - annualità 2015 Premesso che : • la legge n. 328/2000 relativa al sistema integrato di interventi e servizi sociali, in particolare l’art. 17 che prevede la possibilità dei titoli per l’acquisto delle prestazioni sociali; • l’art. 8 della legge regionale 23/2003 che individua, nell’ambito dei servizi sociali, “l’aiuto domiciliare” e i “centri diurni” • il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14.05.2015 recante “ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l’anno 2015, nell’ambito del quale sono stati stanziati in favore della Regione Calabria l'assegnazione e il trasferimento di una quota di finanziamento pari a 13.845.000 euro; • la D.G.R. n. 638 del 14.12.2018 della Regione Calabria, con la quale sono state approvate le Linee Guida per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali nel campo della non autosufficienza, relativamente al Fondo Anno 2015, destinando euro 8.057.000,00 aicomuni capofila degli ambiti territoriali sulla base della popolazione residente e dei dati statistici dell'utenza in condizioni di non autosufficienza presenti nei rispettivi ambiti e nello specifico è stato assegnato al Distretto socio-assistenziale di Crotone, composto dai Comuni di Crotone (Comune Capofila) Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, Scandale, S.