I Registri Notarili Di Giorgio Da Paluzza
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Difesa Dell
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio energia Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione Via Carducci 6 - 34133 Trieste AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO A FINI ESPROPRIATIVI (ai sensi del D.P.R. 8.6.2001 n. 327) Oggetto: costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili, impianto idroelettrico in comune di Paluzza (UD), a favore della Società cooperativa SECAB, con sede in Paluzza UD, via Pal Piccolo 31. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327. Si rende noto che sono depositati, presso la Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile e presso il comune di Paluzza, gli elaborati progettuali dell’opera in oggetto, tra i quali il piano particellare di esproprio/asservimento, costituito da planimetria catastale ed elenco ditte, nonché una relazione indicante la natura, lo scopo dell’opera e la descrizione delle aree da espropriare e da asservire. Ad ogni effetto di legge, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327, SI COMUNICA ai proprietari degli immobili sotto elencati, ubicati nei comune di Paluzza, l’avvio del procedimento diretto all’emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 e dell’art. 12 della L.R. 19/2012, per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’approvazione del progetto definitivo dell’opera di cui trattasi ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ed autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto idroelettrico in oggetto. -

Friuli Venezia Giulia: a Region for Everyone
EN FRIULI VENEZIA GIULIA: A REGION FOR EVERYONE ACCESSIBLE TOURISM AN ACCESSIBLE REGION In 2012 PromoTurismoFVG started to look into the tourist potential of the Friuli Venezia Giulia Region to become “a region for everyone”. Hence the natural collaboration with the Regional Committee for Disabled People and their Families of Friuli Venezia Giulia, an organization recognized by Regional law as representing the interests of people with disabilities on the territory, the technical service of the Council CRIBA FVG (Regional Information Centre on Architectural Barriers) and the Tetra- Paraplegic Association of FVG, in order to offer experiences truly accessible to everyone as they have been checked out and experienced by people with different disabilities. The main goal of the project is to identify and overcome not only architectural or sensory barriers but also informative and cultural ones from the sea to the mountains, from the cities to the splendid natural areas, from culture to food and wine, with the aim of making the guests true guests, whatever their needs. In this brochure, there are some suggestions for tourist experiences and accessible NATURE, ART, SEA, receptive structures in FVG. Further information and technical details on MOUNTAIN, FOOD our website www.turismofvg.it in the section AND WINE “An Accessible Region” ART AND CULTURE 94. Accessible routes in the art city 106. Top museums 117. Accessible routes in the most beautiful villages in Italy 124. Historical residences SEA 8. Lignano Sabbiadoro 16. Grado 24. Trieste MOUNTAIN 38. Winter mountains 40. Summer mountains NATURE 70. Nature areas 80. Gardens and theme parks 86. On horseback or donkey 90. -

A.S. 2020/2021 - INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE LUNEDÍ 14 SETTEMBRE 2020
ISTITUTO COMPRENSIVO “Linussio - Matiz” Via Roma n. 42 33026 PALUZZA (UD) e mail [email protected] pec: [email protected] Sito web: http://www.icpaluzza.gov.it Ai Sigg Genitori degli alunni Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di I grado Istituto Comprensivo “Linussio - Matiz”di Paluzza Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Arta Terme - Cercivento – Paluzza – Paularo Ravascletto - Sutrio - TreppoLigosullo Al personale Docente e A.T.A. Loro Sedi OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021 Per opportuna conoscenza e per gli atti di competenza, si riporta il calendario scolastico per l’anno 2020/2021, come deliberato dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 31.07.2020 e del 25.08.2020, in applicazione della delibera di Giunta regionale FVG n. 469 del 27 marzo 2020. a.s. 2020/2021 - INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE LUNEDÍ 14 SETTEMBRE 2020 LUNEDÍ INIZIO delle attività didattiche 14 SETTEMBRE 2020 scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado orario antimeridiano senza servizio mensa DELIBERA GIUNTA REG. FVG GIOVEDÍ FINE delle attività didattiche scuole primarie integrata dalla delibera del 10 GIUGNO 2021 orario antimeridiano senza servizio mensa C.d.I nr. 6 del 31.07.2020 e dalla delibera del C.d.I nr. 1 del 25.08.2020 GIOVEDÍ FINE delle attività didattiche scuole secondarie 10 GIUGNO 2021 orario antimeridiano senza servizio mensa VENERDÍ FINE delle attività didattiche scuole dell’Infanzia 30 GIUGNO 2021 orario antimeridiano senza servizio mensa Il Consiglio di Istituto ha inoltre deliberato: SCUOLE DELL’INFANZIA dal 14 al 16 settembre 2020 Lezioni antimeridiane senza servizio mensa 23.12.2020 11.02.2021 31.03.2021 28-29-30 giugno dal 17 al 18 settembre 2020 Lezioni antimeridiane con servizio mensa Giornata giochi Infanzia (pranzo al sacco Escluso il plesso di Ravascletto confezionato dalle cuoche della scuola) Per il plesso di Piano d’Arta 23.12.2020 11.02.2021 31.03.2021 28-29-30 giugno dal 21 settembre 2020 Orario completo Esclusi i plessi di TreppoLigosullo/Cercivento – Ravascletto* Codice Mecc. -

Second Report Submitted by Italy Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities
Strasbourg, 14 May 2004 ACFC/SR/II(2004)006 SECOND REPORT SUBMITTED BY ITALY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (received on 14 May 2004) MINISTRY OF THE INTERIOR DEPARTMENT FOR CIVIL LIBERTIES AND IMMIGRATION CENTRAL DIRECTORATE FOR CIVIL RIGHTS, CITIZENSHIP AND MINORITIES HISTORICAL AND NEW MINORITIES UNIT FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES II IMPLEMENTATION REPORT - Rome, February 2004 – 2 Table of contents Foreword p.4 Introduction – Part I p.6 Sections referring to the specific requests p.8 - Part II p.9 - Questionnaire - Part III p.10 Projects originating from Law No. 482/99 p.12 Monitoring p.14 Appropriately identified territorial areas p.16 List of conferences and seminars p.18 The communities of Roma, Sinti and Travellers p.20 Publications and promotional activities p.28 European Charter for Regional or Minority Languages p.30 Regional laws p.32 Initiatives in the education sector p.34 Law No. 38/2001 on the Slovenian minority p.40 Judicial procedures and minorities p.42 Database p.44 Appendix I p.49 - Appropriately identified territorial areas p.49 3 FOREWORD 4 Foreword Data and information set out in this second Report testify to the considerable effort made by Italy as regards the protection of minorities. The text is supplemented with fuller and greater details in the Appendix. The Report has been prepared by the Ministry of the Interior – Department for Civil Liberties and Immigration - Central Directorate for Civil Rights, Citizenship and Minorities – Historical and new minorities Unit When the Report was drawn up it was also considered appropriate to seek the opinion of CONFEMILI (National Federative Committee of Linguistic Minorities in Italy). -

48°EDIZIONE 1982 Neukom-Soravito (G.S Comeglians) 1H 23’ 52” 1983 De Santa-Soravito (G.S
ALBO D’ORO 1967 Maier-Maieron (U.S. Aldo Moro Paluzza) 1h 28’ 56” 1968 Di Centa-Maier (U.S. Aldo Moro Paluzza) 1h 22’ 44” 1969 Di Centa-Maier (U.S. Aldo Moro Paluzza) 1h 27’ 56” Comune di Chiusaforte Comune di Resia Comune di Resiutta 1976 Maieron-Maier-Craighero (U.S. Aldo Moro Paluzza) 2h 7’27” 1977 Cimenti–Pesamosca (U.S. Ivo Sport Tolmezzo) 1h 26’ 31” 1978 Del Gallo-Romanin (U.S. Ivo Sport Tolmezzo) 1h 31’ 56” SABATO 29 SETTEMBRE 1979 Candotti-Romanin (U.S. Aldo Moro Paluzza) 1h 29’ 44 1980 Casanova-Romanin (U.S. Aldo Moro Paluzza) 1h 22’ 43” 1981 Monai-Soravito (Polisportiva Timaucleulis) 1h 23’ 08” 48°EDIZIONE 1982 Neukom-Soravito (G.S Comeglians) 1h 23’ 52” 1983 De Santa-Soravito (G.S. Comeglians) 1h 24’ 58” 1984 Mecchia-Soravito (G.S Comeglians) 1h 23’ 50” 1985 Da Pozzo-Neukom (G.S Comeglians) 1h 28’ 43” 1986 Lot-Rover (G.S. O.Piccinato Brugnera) 1h 19’ 36” 1987 Lot-Vello (G.S. O.Piccinato Brugnera) 1h 22’ 08” 1988 Jacob-Zanni (5° Legione G.D.F) 1h 22’ 03” 1989 Jacob-Zanni (5° Legione G.D.F) 1h 22’ 41” TROFEO 1990 Puntel Tesolin (Brigata Alpina Julia) 1h 24’ 55” 1991 Tonello-Scaunich (G.S.A.U.A.F. Udine) 1h 29’ 03” 1992 Rupil-Buzzi (5° Legione G.D.F) 1h 29’ 52” 1993 Busettini-Barbacetto (U.S. Aldo Moro Paluzza) 1h 27’ 38” 1994 Pittin-De Crignis (Amatori Carnia Tolmezzo) 1h 24’ 42” 1995 Pittin-De Crignis (Amatori Carnia Tolmezzo) 1h 22’ 53” 16°MEMORIAL WALTER PERISUTTI 1996 Fontana-De Martin (Pol. -

Della Procedura
Azienda per l’ Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli- Collinare – Medio Friuli” Agency for Health Assistance n. 3 “Upper – Hilly – Middle Friuli” Aziende pe Assistence Sanitarie n. 3 "Friûl de Alte – Culinâr – di Mieç” Sanitätsbetrieb Nr. 3 “Ober- Huegel- Mittelfriaul ” Podjetje za zdravstveno varstvo št.3 "Gornja Furlanija-Gričevnata-Srednja Furlanija" POSEBEN NARČT ZA JEZIKOVNO POLITIKO KONTEKST Podjetje za zdravstveno varstvo št. 3 "Gornja Furlanija – Gričevnata – Srednja Furlanija" je prisotno na teritoriju Furlanije – Julijske krajine na gorskem predelu med Avstrijo, Slovenijo, Venetom, Karnijskimi in Julijskimi Predalpami, ter se razteza v gričevnat del San Danieleja, v nižino pri Codroipu, skoraj do morja. Poleg Glavne uprave, ki je v Guminu, je Podjetje razdeljeno na štiri socialno-zdravstvena Okrožja ter na tri oddelčne strukture, edinstvene na nivoju Podjetja: Oddelek za preventivo, Oddelek za duševno zdravje in Oddelek za zdravljenje odvisnosti. Potem so tu še bolnišnica San Daniele – Tolmeč in bolnišnica Gumin. Stične in vhodne točke za uporabnike do socialno – zdravstvenih storitev na prvem mestu sestavljajo osnovna socialno-zdravstvena oskrba, katero zagotavlja 151 zdravnikov splošne medicine in 15 pediatrov proste izbire. Negovalno in socialno-teritorialno oskrbo nudijo 8 točk zdravja, ki so razporejene po dolinah in različnih gričevnatih in nižinskih predelih, ter jih koordinirajo posamezna okrožja. Edina v deželi, je od občin iz 3 Okrožij pridobila pooblastilo za socialne funkcije in od vseh občin pooblastilo za hendikep, katerega direktno upravlja ter dopolnjuje z zdravstvenimi funkcijami glede na sklenjeno letno pooblastilo z občinami. PZV3 zajema 69 občin: od teh je 68 vključenih v zaščito za furlanski jezik. Okrožje 1: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo (Tolmeč), Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio. -

Trasferimenti MM 2013 14.Pdf
********************************************************************************** * SI-13-SM-PDO2B * * * * SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE * * * * * * SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO * * * * * * UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI * * * * * * UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : UDINE * * * * * * ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO * * * * * * ANNO SCOLASTICO 2013/2014 * * * * * * ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON * * CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA * * COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I * * CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' * * PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. * * * * * ********************************************************************************** POSTI DI SOSTEGNO PER MINORATI PSICO-FISICI ***** TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA 1. BRAVIN PIERPAOLO . 4/ 4/62 (AO) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : UDMM000VP6 - PROVINCIA DI UDINE A : UDMM842017 - VALUSSI - BELLAVITIS - UDINE ( UDINE ) PUNTI 86 2. BRUSATIN MAURIZIO . 7/ 9/67 (UD) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : UDMM000VP6 - PROVINCIA DI UDINE A : UDMM83101R - I. NIEVO - PREMARIACCO ( PREMARIACCO ) PUNTI 54 3. CAMPANA ARIANNA . 4/11/74 (UD) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : UDMM819027 - G. UNGARETTI - COSEANO ( COSEANO ) A : UDMM857011 - MANZONI - UDINE ( UDINE ) PUNTI 49 4. CANDONI PAOLA . 31/ 1/62 (UD) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : UDMM82303X - N. GRASSI - VILLA SANTINA ( VILLA SANTINA ) A : UDMM85401D - G.F.DA TOLMEZZO - TOLMEZZO ( TOLMEZZO ) SOPRANNUMERARIO TRASFERITO A DOMANDA CONDIZIONATA PUNTI 82 5. COSSIO GIUDITTA . 14/ 6/75 (UD) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : UDMM85201T - SMS PELLEGRINO DA S. DANIELE ( SAN DANIELE DEL FRIULI ) A : UDMM855019 - SMS G. MARCHETTI - CAMPOFORMIDO ( CAMPOFORMIDO ) PRECEDENZA: PREVISTA DAL C.C.N.I. PUNTI 66 6. -

Libro Ottocento OK.P65
l’ Ottocento nel Comune di Paluzza • 201 non alzino il prezzo del sale a causa della Radetzky emana un proclama con cui guerra in corso. concede piena impunità ai disertori purchè si presentino a un’Autorità Ci- 3 maggio - Ci sono 5 militari disertori vile entro il 30 settembre. del 3° Regg.to Arciduca Ferdinando d’ Este segnalati nel Comune e i genitori 18 agosto - Oggi si sposta la seduta devono rifondere il costo degli effetti del Consiglio Comunale al 28 agosto vestiari (£ 15,37 l’uno). poichè in S. Maria l’Arcivescovo, in vi- sita pastorale, celebra con un Te Deum 4 maggio - E’ in diffusione nel Comu- il natalizio di S.M. l’Imperatore. ne il vaiuolo, sia pure sotto controllo. La Deputazione Comunale deve fare la rela- 28 agosto - Oggi è stato approvato il zione sulla situazione al Commisario Bilancio Consuntivo del 1848 che si Distrettuale ogni settimana. chiude con un deficit di £ 19.305,56. 4 luglio - Florio Morocutti ottiene il 15 settembre - C’è una pressante pagamento: di £ 546,83 per spese incon- istanza dei frazionisti di Rivo per l’at- trate nell’invio a Udine nel 1848 dei tuazione dei lavori a difesa del paese dal volontari nazionali che hanno parteci- Rio Centa, dal Rio Baiarz e dal Rio pato all’insurrezione e di £ 593, 43 per Ruviais, progettati dall’ing. Broili per l’attivazione della Guardia Civica. £ 891,17. Pagamento di £ 234,52 a Mattia Juri 8 luglio - Muore a Timau un putello di e £ 271 a Giobatta Lazzara Radivo per 11 mesi, figlio di Giovanni q. -

Friuli Venezia Giulia
REGIONE: FRIULI-VENEZIA GIULIA Concentrazione di radon indoor misurata in abitazioni nell’ambito di indagini di misura: sintesi dei dati presenti nell’Archivio Nazionale Radon (ANR) per i Comuni con almeno 5 abitazioni misurate. COMUNE NUMERO MEDIA MINIMO MASSIMO ABITAZIONI ARITMETICA (Bq m–3) (Bq m–3) MISURATE (Bq m–3) AIELLO DEL FRIULI 8 102 39 181 AMARO 8 172 34 437 AMPEZZO 11 229 40 767 ANDREIS 10 266 38 705 ARBA 13 268 71 816 ARTA TERME 15 76 32 245 ATTIMIS 14 87 30 237 AVIANO 38 293 40 1409 AZZANO DECIMO 18 75 36 163 BAGNARIA ARSA 10 93 35 184 BARCIS 11 197 57 458 BASILIANO 60 163 35 747 BERTIOLO 9 183 56 737 BICINICCO 7 297 66 766 BORDANO 9 96 34 364 BRUGNERA 20 77 30 195 BUDOIA 9 91 36 201 BUJA 19 58 29 195 BUTTRIO 7 162 29 283 CAMINO AL TAGLIAMENTO 8 85 35 250 CAMPOFORMIDO 9 160 41 323 CANEVA 26 107 23 368 CAPRIVA DEL FRIULI 5 79 30 193 CARLINO 6 90 54 153 CASARSA DELLA DELIZIA 8 122 47 219 CASSACCO 6 122 32 255 CASTELNOVO DEL FRIULI 8 142 23 682 CASTIONS DI STRADA 8 200 39 513 CAVAZZO CARNICO 11 169 54 502 CERVIGNANO DEL FRIULI 8 67 43 109 CHIONS 11 63 30 110 CHIUSAFORTE 15 133 24 259 CIMOLAIS 5 235 127 340 CIVIDALE DEL FRIULI 24 82 18 556 CLAUT 26 248 55 831 CLAUZETTO 9 161 32 362 CODROIPO 27 225 27 982 1 di 5 COMUNE NUMERO MEDIA MINIMO MASSIMO ABITAZIONI ARITMETICA (Bq m–3) (Bq m–3) MISURATE (Bq m–3) COLLOREDO DI MONTE ALBANO 11 92 23 324 COMEGLIANS 8 136 28 275 CORDENONS 20 174 59 383 CORMONS 13 129 28 475 CORNO DI ROSAZZO 7 130 39 351 COSEANO 12 208 64 745 DIGNANO 12 163 65 347 DOBERDÒ DEL LAGO 12 259 54 1542 DOGNA 8 345 -

Turni Ex Ass5 2016-2017
TURNI E FERIE 2016-2017 Farmacie ex ASS 5 Il servizio di turno inizia la mattina del venerdì TURNO FERIE APERTO APERTURA MATTINO CHIUSO APERTURA POMERIGGIO APRILE 2 0 16 DDDDLS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930 AIELLO DEL FRIULI AQUILEIA BAGNARIA ARSA - SEVEGLIANO BICINICCO CAMPOLONGO TAPOGLIANO CARLINO CERVIGNANO DEL F. (Comunale) CERVIGNANO DEL F. (Lovisoni) CERVIGNANO DEL F. (Vidali) CHIOPRIS - VISCONE FIUMICELLO GONARS LATISANA (Romano & Alessi) LATISANA (Spagnolo) LATISANA (Pertegada) LIGNANO Pineta (Comunale) LIGNANO Pineta (Comunale) - Succ. LIGNANO Sabbiadoro (De Roia) LIGNANO Sabbiadoro (De R.) - Succ. MARANO LAGUNARE MUZZANA DEL TURGNANO PALAZZOLO DELLO STELLA PALMANOVA (Facini) PALMANOVA (Lipomani) PALMANOVA (Morandini) POCENIA PORPETTO PRECENICCO RIVIGNANO - TEOR (Braidotti) RIVIGNANO - TEOR (Gaion) RONCHIS RUDA SAN GIORGIO DI NOG. (Baiti) SAN GIORGIO DI NOG. (De Fina) SAN VITO AL TORRE SANTA MARIA LA LONGA TERZO DI AQUILEIA TORVISCOSA TRIVIGNANO UDINESE VILLA VICENTINA VISCO MAGGIO 2 0 16 DL D D D DMa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930 31 AIELLO DEL FRIULI AQUILEIA BAGNARIA ARSA - SEVEGLIANO BICINICCO CAMPOLONGO TAPOGLIANO CARLINO CERVIGNANO DEL F. (Comunale) CERVIGNANO DEL F. (Lovisoni) CERVIGNANO DEL F. (Vidali) CHIOPRIS - VISCONE FIUMICELLO GONARS LATISANA (Romano & Alessi) LATISANA (Spagnolo) LATISANA (Pertegada) LIGNANO Pineta (Comunale) LIGNANO Pineta (Comunale) - Succ. LIGNANO Sabbiadoro (De Roia) LIGNANO Sabbiadoro (De R.) - Succ. MARANO LAGUNARE MUZZANA DEL TURGNANO -

Densità Della Viabilità Forestale Nelle Foreste Pianificate
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE DENSITÀ DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI NELLE SUPERFICI FORESTALI PIANIFICATE (DICEMBRE 2020) Obiettivo per le strade camionabili principali: ottimale 40 m/ha - accordo interregionale di Verona 2016: 25 m/ha Strade forestali di primo livello Strade forestali di secondo livello Superficie camionabili (camionabili e trattorabili) Proprietà (*) Forestale m/ha (**) km (**) m/ha (**) km (**) ha (**) Foresta regionale di Pramosio (Paluzza) 20 3 19 3 169 Foresta regionale di Fusine (Tarvisio) 12 19 12 19 1.562 Comune di Clauzetto 11 2 6 1 173 Foresta regionale del Cansiglio orientale (Budoia, Caneva, Polcenigo) 11 14 5 6 1.295 Comune di Comeglians 10 2 16 3 196 Comune di Raveo 9 1 13 1 60 Givigliana (Rigolato) 9 1 20 3 154 Del Missier Luca (S.F. Clauzetto) 6 0 116 1 6 Comune di Verzegnis 5 7 26 33 1.234 Comune di Paluzza 4 4 29 27 927 Foresta regionale del Monte Rest (Socchieve) 4 2 10 5 472 Eberhard s.s. Società Agricola (S.F. Treppo Ligosullo) 3 0 51 3 50 Comune di Enemonzo 3 2 10 7 732 Azienda Agricola Villa Dante s.a.s. (S.F. Ampezzo) 3 0 19 3 154 Comune di Pontebba 3 4 13 18 1.412 Foresta regionale della Val Alba (Moggio Udinese) 2 3 0 1 1.531 Foresta regionale del Prescudin (Barcis) 2 1 22 8 378 Comune di San Dorligo della Valle 2 0 19 2 102 Amministrazione beni fraz. di Ovasta (Ovaro) 1 0 29 6 195 Comune di Ravascletto 1 1 24 19 816 Comune di Caneva 1 0 23 9 392 Foresta regionale dei Lotti (Tarvisio) 1 1 7 6 921 * S.F.: scheda forestale; ove -
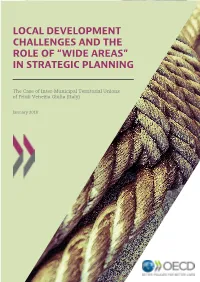
Local Development Challenges and the Role of “Wide Areas” in Strategic Planning
LOCAL DEVELOPMENT CHALLENGES AND THE ROLE OF “WIDE AREAS” IN STRATEGIC PLANNING The Case of Inter-Municipal Territorial Unions of Friuli Venezia Giulia (Italy) January 2018 2 │ OECD Working Papers should not be reported as representing the official views of the OECD or of its member countries. The opinions expressed and arguments employed are those of the authors. Working Papers describe preliminary results or research in progress by the author(s) and are published to stimulate discussion on a broad range of issues on which the OECD works. Comments on Working Papers are welcomed, and may be sent to CFE Directorate, OECD, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. Cover image: Designed by welcomia / Freepik © OECD 2018 You can copy, download or print OECD content for your own use, and you can include excerpts from OECD publications, databases and multimedia products in your own documents, presentations, blogs, websites and teaching materials, provided that suitable acknowledgment of OECD as source and copyright owner is given. All requests for public or commercial use and translation rights should be submitted to [email protected]. Requests for permission to photocopy portions of this material for public or commercial use shall be addressed directly to the Copyright Clearance Center (CCC) at [email protected] or the Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) [email protected].