Michelangelo Florio : Un Esule Religioso Attraverso L'europa Del Cinquecento
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
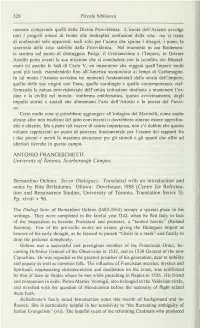
Download Download
320 Piccola biblioteca ramente comprende quelli della Divina Provvidenza. L'ironia dell'Ariosto avvolge tutti i progetti umani di fronte alle molteplici confusioni della vita: ma si tratta di confusioni solo apparenti, reali solo per l'uomo che ignora i disegni, i piani, la sincronia delle cose stabilite dalla Provvidenza. Nel momento in cui Rodomon- te sembra sul punto di distruggere Parigi, il Cristianesimo e l'Impero, in Oriente Astolfo porta avanti la sua missione che si concluderà con la sconfìtta dei Mussul- mani ed ascolta le lodi di Carlo V, un imperatore che reggerà quell'Impero molti anni più tardi, estendendolo fino all'America sconosciuta ai tempi di Carlomagno. In tal modo l'Ariosto avvicina tre momenti fondamentali della storia dell'Impero, quello delle sue origini con Enea, quello carolingio e quello contemporaneo, riaf- fermando la natura provvidenziale dell'antica istituzione destinata a mantenere l'or- dine e la civiltà nel mondo: conferma emblematica, questo avvicinamento, degli impulsi storici e sociali che alimentano l'arte dell'Ariosto e la poesia del Furio- so. Certo molte cose si potrebbero aggiungere all'indagine del Marinelli, come anche alcune altre non risultano del tutto convincenti o dovrebbero almeno essere approfon- dite e chiarite. Ma a parte tali riserve di scarsa importanza, non c'è dubbio che questo volume rappresenti un punto di partenza fondamentale per l'esame dei rapporti fra i due poemi e meriti la massima attenzione per gli stimoli e gli spunti che offre ad ulteriori ricerche in questo campo. ANTONIO FRANCESCHETTI University of Toronto, Scarborough Campus Bernardino Ochino. Seven Dialogues. -

The Creation of a Calvinist Identity in the Reformation Period
chapter 7 The Creation of a Calvinist Identity in the Reformation Period Ole Peter Grell Calvinism, as opposed to other Protestant confessions quickly developed a pan-European identity during the Reformation period – from the mid- sixteenth to the early seventeenth century. This early modern Reformed iden- tity, including the theology which underpinned it, was shaped by the prolonged experience of persecution, exodus and subsequent exile which came to form the experience of an increasingly large number of influential Calvinist fami- lies. This chapter is concerned with how and why this came about and what it resulted in.1 First, an overview of the size and nature of Calvinist emigration and re- emigration together with a record of the principal places of settlement is pro- vided. Then follows a discussion of the rationale for emigration amongst the wealthy, Calvinist merchants who came to constitute the spine of the exiled Reformed communities and to what extent it was determined by religious and/ or economic factors. This leads into an analysis of the raison d’être which Calvinist exiles applied to their own experiences of persecution, exile, and minority existence, focussing in particular on the role of providential history and the use of the Old Testament as a matrix for their personal experiences. A variety of contemporary sources illustrating the role of providential history and the use of texts from the Bible are quoted here. The second half of the chapter is focussed on the significance of the so- called ‘Weber thesis’ for explaining the success of the first three generations of wealthy Calvinist merchants-bankers who provided leadership for the exiled Calvinist communities across Europe. -

History of the Franciscan Movement
HISTORY OF THE FRANCISCAN MOVEMENT Volume 2 FROM THE YEAR 1517 TO THE SECOND VATICAN COUNCIL On-line course in Franciscan History at Washington Theological Union Washington DC By Noel Muscat OFM Jerusalem 2008 History of the Franciscan Movement. Volume 2: From 1517 to the Second Vatican Council Chapter 10 NEW REFORMS AND NEW DIVISIONS: THE BIRTH OF THE CAPUCHINS AND REFORMS WITHIN THE OBSERVANCE The friars “of the Holy Gospel” The Order of Friars Minor of the Regular Observance, after the union of all the reformed families in 1517, became a powerful religious family dedicated mainly to apostolic missions. A minority of friars, however, continued to insist upon living a simpler Franciscan life in the hermitages. Besides the Amadeiti and Coletani, there were other congregations which preferred eremitical life, like the Clareni and the friars “of the Holy Gospel” or Capuciati. This last religious family was one which the Bulla Ite vos of Leo X (1517) had not managed to integrate within the Order of the Friars Minor of the Regular Observance. They were born, as we have already seen, with the initiative of Juan de la Puebla, who had made an experience of Franciscan life in the Umbrian hermitages of central Italy, and then had returned to Spain, founding a congregation of friars who lived the literal observance of the Rule in the hermitages. Among his followers there was Juan de Guadalupe, who in 1508 obtained the approval of the Province “of the Holy Gospel”.1 The negative reaction of the Spanish Observants, who persecuted the new religious family, compelled the brothers of the Custody of Estremadura to place themselves under the obedience of the Conventuals in 1515, and thus became to be known by the name of “Reformed Conventuals”.2 They wore a short tunic with a pyramidal hood, and hence also the name Capuciati. -

Pope Paul III and the Cultural Politics of Reform Pope Paul III and the Cultural Politics of Reform
6 RENAISSANCE HISTORY, ART AND CULTURE Cussen Pope Paul III and the Cultural Politics of Reform of Politics Cultural the and III Paul Pope Bryan Cussen Pope Paul III and the Cultural Politics of Reform 1534-1549 Pope Paul III and the Cultural Politics of Reform Renaissance History, Art and Culture This series investigates the Renaissance as a complex intersection of political and cultural processes that radiated across Italian territories into wider worlds of influence, not only through Western Europe, but into the Middle East, parts of Asia and the Indian subcontinent. It will be alive to the best writing of a transnational and comparative nature and will cross canonical chronological divides of the Central Middle Ages, the Late Middle Ages and the Early Modern Period. Renaissance History, Art and Culture intends to spark new ideas and encourage debate on the meanings, extent and influence of the Renaissance within the broader European world. It encourages engagement by scholars across disciplines – history, literature, art history, musicology, and possibly the social sciences – and focuses on ideas and collective mentalities as social, political, and cultural movements that shaped a changing world from ca 1250 to 1650. Series editors Christopher Celenza, Georgetown University, USA Samuel Cohn, Jr., University of Glasgow, UK Andrea Gamberini, University of Milan, Italy Geraldine Johnson, Christ Church, Oxford, UK Isabella Lazzarini, University of Molise, Italy Pope Paul III and the Cultural Politics of Reform 1534-1549 Bryan Cussen Amsterdam University Press Cover image: Titian, Pope Paul III. Museo di Capodimonte, Naples, Italy / Bridgeman Images. Cover design: Coördesign, Leiden Lay-out: Crius Group, Hulshout isbn 978 94 6372 252 0 e-isbn 978 90 4855 025 8 doi 10.5117/9789463722520 nur 685 © B. -

A Transcription and Translation of Ms 469 (F.101R – 129R) of the Vadianische Sammlung of the Kantonsbibliothek of St. Gallen
A SCURRILOUS LETTER TO POPE PAUL III A Transcription and Translation of Ms 469 (f.101r – 129r) of the Vadianische Sammlung of the Kantonsbibliothek of St. Gallen by Paul Hanbridge PRÉCIS A Scurrilous Letter to Pope Paul III. A Transcription and Translation of Ms 469 (f.101r – 129r) of the Vadianische Sammlung of the Kantonsbibliothek of St. Gallen. This study introduces a transcription and English translation of a ‘Letter’ in VS 469. The document is titled: Epistola invectiva Bernhardj Occhinj in qua vita et res gestae Pauli tertij Pont. Max. describuntur . The study notes other versions of the letter located in Florence. It shows that one of these copied the VS469, and that the VS469 is the earliest of the four Mss and was made from an Italian exemplar. An apocryphal document, the ‘Letter’ has been studied briefly by Ochino scholars Karl Benrath and Bendetto Nicolini, though without reference to this particular Ms. The introduction considers alternative contemporary attributions to other authors, including a more proximate determination of the first publication date of the Letter. Mario da Mercato Saraceno, the first official Capuchin ‘chronicler,’ reported a letter Paul III received from Bernardino Ochino in September 1542. Cesare Cantù and the Capuchin historian Melchiorre da Pobladura (Raffaele Turrado Riesco) after him, and quite possibly the first generations of Capuchins, identified the1542 letter with the one in transcribed in these Mss. The author shows this identification to be untenable. The transcription of VS469 is followed by an annotated English translation. Variations between the Mss are footnoted in the translation. © Paul Hanbridge, 2010 A SCURRILOUS LETTER TO POPE PAUL III A Transcription and Translation of Ms 469 (f.101r – 129r) of the Vadianische Sammlung of the Kantonsbibliothek of St. -

Ochino Dialogi Sette
Dialogi sette Seven Dialogues By Bernardino Ochino Translated by Patrick Colbourne O.F.M.Cap Table of Contents TRANSLATOR’S NOTE ....................................................................................................................................... 2 INTRODUCTION BY CASTANZO CARGNONI O.F.M. CAP. .......................................................................... 2 1. DIALOGUE ON THE METHOD OF LOVING GOD .............................................................................. 3 CONVERSATIONALISTS: THE DUCHESS AND FATHER BERNARDINO ............................................................................. 3 [TO LOVE GOD IS EASY] .................................................................................................................................... 4 [NATURAL, SENSUAL AND RATIONAL LOVE] ........................................................................................................... 5 [THOSE WHO ARE TRUE FRIENDS OF GOD] ............................................................................................................ 6 [PERFECT LOVING IS DIFFICULT] .......................................................................................................................... 7 [THE BEST WAY TO LOVE GOD] .......................................................................................................................... 8 [KNOWLEDGE PRECEDES LOVE] .......................................................................................................................... 8 [HOW TO -

Considerations on the Capuchin Charism Paul Hanbridge, Nov 2011
Considerations on the Capuchin Charism Paul Hanbridge, Nov 2011 INTRODUCTION In these considerations on Capuchin identity I wish to recall briefly some of the principles for the renewal of the religious life that emerged with Vatican II and subsequently. The documents also emphasise the importance within the Church of our fidelity to our charism. What will also emerge from these documents, I hope, is the important distinction between the charism of the founders and the charism of the institutes they founded, as well as the bond between the two. By taking a quick glance of two moments in the history of the Capuchin Order, I will attempt to demonstrate that the identity of the charism of our Order has never really been entirely fixed or static, but has evolved in response to needs and even crises within the Order. The various editions of the Constitutions over the centuries bear witness to that evolution in the Order’s interpretation of its charism. The identification of the Capuchin charism is a task for each generation as it struggles with the tension between fidelity to and continuity with Francis’ charism and the principles that guided the Capuchin Order in the beginning, and the need to adapt the application of those principles to the particular circumstances in which the Order finds itself. “Faithfulness to the past is the guarantee of the charism in the present, and is a challenge for the future.” 1 The assertion is not about nostalgia for the past and the ‘good old days’ with which to judge ourselves inferior to friars in the beginning. -

Celio Secondo Curione a Cura Di Chiara Lastraioli
“Cinquecento plurale” BIBLIOGRAFIA Celio Secondo Curione a cura di Chiara Lastraioli aggiornato al 28 maggio 2018 Con la presente bibliografia curioniana si tenta di tracciare un panorama per quanto possibile completo e coerente delle opere del Piemontese e dei princi- pali studi ad esso dedicati. Data la complessa vicenda editoriale dei volumi pasquineschi, la rarità di certe edizioni e la scarsa affidabilità di alcune fonti bibliografiche, nella sezione Testi pasquineschi si è ritenuto opportuno asso- ciare ad ogni riferimento bibliografico la localizzazione e la segnatura di al- meno un esemplare conosciuto. Devo a Davide Dalmas, oltre all’attenta rilet- tura del testo, la segnalazione di alcune edizioni e di svariati suggerimenti bi- bliografici. TESTI PASQUINESCHI o Pasquino in estasi. Ragionamento di Marforio, e di Pasquino, Stampata in Ro- ma, a instantia di Mro Pasquino, s. d. [British Library 1080.h.22.(1) – (uni- cum?)] o Der verzucket Pasquinus. Auß Welscher Sprach inn das Teütsch gebracht, Rom [Augsburg], Pasquinus [Philipp Ulhart d. A.], 1543 [Münich UB, 8° Thol 2151] o Pasquilli extatici seu nuper e coelo reversi de rebus partim superis, partim in- ter homines in christiana religione passim hodie controversis cum Marphorio colloquium, multa pietate, elegantia, ac festivitate refertum; Suivi de: Rhythmi; Epigrammata, [s.l., ca. 1543?] [Bibl. Cantonale et Universitaire de Dorigny, LL 3741 (esemplare non consultato)] o Caelij Secundi Curionis Pasquillus ecstaticus, unà cum alijs etiam aliquot san- ctis pariter et lepidis Dialogis, quibus pracipua religionis nostrae Capita ele- gantissime explicantur. Omnia quam unquam antea, cum auctiora, tum emen- datoria. quorum Catalogum uersa pagella indicat. Adiectae quoque sunt Quae- stiones Pasquilli, in futuro Concilio à Paulo III. -

Bernardino Ochino of Siena
202 BERNARDINO OCHINO OF SIENA BERNARDINO OCHINO OF SIENA: CAPUCHIN AND REFORMER (1487-1564). BY JOHN KNIPE. " False Christians desire a Christ after their manner, rich, proud and magnificent."-OcHINO. 0CHINO THE FRANCISCAN. OR thirty years the most famous of Italian preachers, the F personality of Bernardino Ochino has been compared to a defaced portrait in the gallery of the great men of the Later Renais sance. His name has been blotted out for centuries by the deliberate malice of an unforgiving Church. It is a local nickname. Siena was divided into Contrada (Quarters). One was called" Oca" (Goose). It extended from the Dominican Church to Dante's Fonte Branda, and here there stands to this day the house of the Dyer's daughter, Caterina. We know his father's name by an item in the Account Book of the Cathedral Treasury: "January I540. Was paid 32 Lire to Fra Bernardino son of Domenico Tommasini called Ochino." It is the preacher's modest fee. He was still a lad when he joined the Observants, a Reformed Order of the Franciscans, whose monastery was some two miles from the City Gate, and it is quite possible that he had been influenced by Savonarola's preaching. Ochino declared in later life that he never regretted his decision, which had kept him from many temptations and sins of the world, and given him the oppor tunity to study the Scriptures and contemplative theology. Bible study was then only permissible in the Cloister. He took the cowl, hoping thus " to gain Paradise, though not without the aid of Divine Grace," and he concluded "that the Observant Rule, being the most austere, should best represent the example of Christ." There is a doubtful statement that he left the Order for some years to study medicine in Perugia. -

Introduction: the Spirituali and Their Goals
NOT BY FAITH ALONE: VITTORIA COLONNA, MICHELANGELO AND REGINALD POLE AND THE EVANGELICAL MOVEMENT IN SIXTEENTH CENTURY ITALY A Thesis Submitted to the Faculty of The School of Continuing Studies and of The Graduate School of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Liberal Studies Christopher Allan Dunn, J.D. Georgetown University Washington, D.C. March 19, 2014 NOT BY FAITH ALONE: VITTORIA COLONNA, MICHELANGELO AND REGINALD POLE AND THE EVANGELICAL MOVEMENT IN SIXTEENTH CENTURY ITALY Christopher Allan Dunn, J.D. MALS Mentor: Michael Collins, Ph.D. ABSTRACT Beginning in the 1530’s, groups of scholars, poets, artists and Catholic Church prelates came together in Italy in a series of salons and group meetings to try to move themselves and the Church toward a concept of faith that was centered on the individual’s personal relationship to God and grounded in the gospels rather than upon Church tradition. The most prominent of these groups was known as the spirituali, or spiritual ones, and it included among its members some of the most renowned and celebrated people of the age. And yet, despite the fame, standing and unrivaled access to power of its members, the group failed utterly to achieve any of its goals. By 1560 all of the spirituali were either dead, in exile, or imprisoned by the Roman Inquisition, and their ideas had been completely repudiated by the Church. The question arises: how could such a “conspiracy of geniuses” have failed so abjectly? To answer the question, this paper examines the careers of three of the spirituali’s most prominent members, Vittoria Colonna, Michelangelo and Reginald Pole. -

Lambeth Palace Library Research Guide King Henry VIII (1491-1547)
Lambeth Palace Library Research Guide King Henry VIII (1491-1547) 1 Manuscript Resources at Lambeth ................................................................................. 2 1.1 Individual Manuscripts............................................................................................. 2 1.2 Manuscript Collections ............................................................................................ 4 1.2.1 Wharton Manuscripts (MSS 577-595) ............................................................. 4 1.2.2 The Carew Manuscripts (MSS 596-638) ......................................................... 4 1.2.3 Shrewsbury and Talbot Papers (MSS 694-710, 3192-3206)........................... 5 1.3 Archival Collections................................................................................................. 7 1.3.1 Archbishops’ Registers.................................................................................... 7 1.3.2 Faculty Office Registers .................................................................................. 9 1.3.3 Estate Documents and Temporalities.............................................................. 9 1.3.4 Carte Antique et Miscellanee (Lambeth Charters) .......................................... 9 2 Printed Resources at Lambeth...................................................................................... 10 2.1 Letters of Henry VIII .............................................................................................. 10 2.2 Henry VIII’s Controversy with -

Religious Reform in Sixteenth-Century Italy
Edinburgh Research Explorer Religious Reform in Sixteenth-Century Italy Citation for published version: Bowd, S 2011, 'Religious Reform in Sixteenth-Century Italy', Reformation, vol. 16, no. 1, pp. 181-194. https://doi.org/10.1558/refm.v16i0.179 Digital Object Identifier (DOI): 10.1558/refm.v16i0.179 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Peer reviewed version Published In: Reformation General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 25. Sep. 2021 1 Religious Reform in Sixteenth-Century Italy Brian Richardson. Manuscript Culture in Renaissance Italy. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Pp. xiv + 317. ISBN 978-0-521-88847-9. £53.00. Abigail Brundin. Vittoria Colonna and the Spiritual Poetics of the Italian Reformation. Aldershot: Ashgate, 2008. Pp. xvi + 218. ISBN 978-0-7546-4049-3. £65.00. Forms of Faith in Sixteenth-Century Italy. Edited by Abigail Brundin and Matthew Treherne. Aldershot: Ashgate, 2009. Pp. xiv + 260. ISBN 978-0-7546-6555-7. £60.00. Anne Overell. Italian Reform and the English Reformations, c.1535-c.1585.