I Coleotteri Carabidi Come Bio Indicatori Nell' Agroecosistema: Un
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ground Beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Region of Cape Emine (Central Bulgarian Black Sea Coast)
ZooNotes 68: 1-18 (2015) …68… www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg ISSN 1313-9916 Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the region of Cape Emine (Central Bulgarian Black sea coast). Part I. Taxonomic and zoogeographic structure, life forms, habitat and humidity preferences TEODORA TEOFILOVA1, EMILIA MARKOVA2, NIKOLAI KODZHABASHEV3 1Institute of Biodiversity and Ecosystem Research (IBER), Bulgarian Academy of Sciences, 1000 Sofia, 1 Tsar Osvoboditel Blvd.; e-mail: [email protected] 2Sofia University, Faculty of Biology, Department of Ecology and Environmental Protection, 1164 Sofia, Bulgaria, 8 Dragan Tsankov Blvd. 3Forestry University, Faculty of Forestry, Department of Hunting and Game Management, 1756 Sofia, Bulgaria, 10 Kliment Ohridski Blvd. Abstract. For the first time the carabid fauna of the area of Cape Emine (the middle of the Bulgarian Black sea coast) was studied. Over the period 2010 – 2012 adult carabid beetles were collected. Investigations were performed at 13 sampling sites and pitfall traps were used. During the study a total of 12618 specimens were captured. They belonged to 134 species, classified into 46 genera, 18 tribes, and 3 subfamilies. Dyschirius rufipes Dejean, 1825 and Laemostenus janthinus (Duftschmid, 1812) were reported as new species for the carabid fauna of Bulgaria. Three species were new for the fauna of the Bulgarian Black Sea coast. Fifty-four species were defined as new for the area of Cape Emine. Two endemics were found: Pterostichus merkli Frivaldszky, 1879 (Bulgarian endemic) and Cychrus semigranosus balcanicus Hopffgarten, 1881 (Balkan endemic). Species of ground beetles were characterized and classified according to their zoogeographical belonging, degree of endemism and rarity, habitat and humidity preferences; the life forms they refer to were determined. -
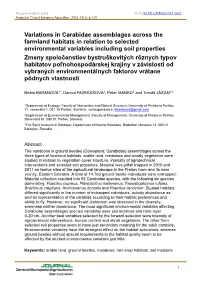
Variations in Carabidae Assemblages Across The
Original scientific paper DOI: /10.5513/JCEA01/19.1.2022 Journal of Central European Agriculture, 2018, 19(1), p.1-23 Variations in Carabidae assemblages across the farmland habitats in relation to selected environmental variables including soil properties Zmeny spoločenstiev bystruškovitých rôznych typov habitatov poľnohospodárskej krajiny v závislosti od vybraných environmentálnych faktorov vrátane pôdnych vlastností Beáta BARANOVÁ1*, Danica FAZEKAŠOVÁ2, Peter MANKO1 and Tomáš JÁSZAY3 1Department of Ecology, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov in Prešov, 17. novembra 1, 081 16 Prešov, Slovakia, *correspondence: [email protected] 2Department of Environmental Management, Faculty of Management, University of Prešov in Prešov, Slovenská 67, 080 01 Prešov, Slovakia 3The Šariš Museum in Bardejov, Department of Natural Sciences, Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov, Slovakia Abstract The variations in ground beetles (Coleoptera: Carabidae) assemblages across the three types of farmland habitats, arable land, meadows and woody vegetation were studied in relation to vegetation cover structure, intensity of agrotechnical interventions and selected soil properties. Material was pitfall trapped in 2010 and 2011 on twelve sites of the agricultural landscape in the Prešov town and its near vicinity, Eastern Slovakia. A total of 14,763 ground beetle individuals were entrapped. Material collection resulted into 92 Carabidae species, with the following six species dominating: Poecilus cupreus, Pterostichus melanarius, Pseudoophonus rufipes, Brachinus crepitans, Anchomenus dorsalis and Poecilus versicolor. Studied habitats differed significantly in the number of entrapped individuals, activity abundance as well as representation of the carabids according to their habitat preferences and ability to fly. However, no significant distinction was observed in the diversity, evenness neither dominance. -

Carabids and Other Beneficial Arthropods in Cereal Crops and Permanent Grasslands and Influence of Field and Landscape Parameters D
Carabids and other beneficial arthropods in cereal crops and permanent grasslands and influence of field and landscape parameters D. Massaloux To cite this version: D. Massaloux. Carabids and other beneficial arthropods in cereal crops and permanent grasslands and influence of field and landscape parameters. Biodiversity and Ecology. AgroParisTech, 2020. English. tel-02886480v2 HAL Id: tel-02886480 https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/tel-02886480v2 Submitted on 9 Dec 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. NNT : 2020 IAVF 0012 THESE DE DOCTORAT préparée à l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) pour obtenir le grade de Docteur de l’Institut agronomique vétérinaire et forestier de France Spécialité : Écologie École doctorale n°581 Agriculture, alimentation, biologie, environnement et santé (ABIES) par Damien MASSALOUX Influence du paysage et de la parcelle sur les diversités de carabes et d’autres arthropodes en céréales et prairies permanentes Directeur de thèse : Alexander Wezel Co-encadrement de la thèse : Benoit Sarrazin Thèse présentée et soutenue à Lyon le 22 juin 2020 Composition du jury : M. Pierre-Henri Gouyon, Professeur, Muséum National d’Histoire Naturelle Rapporteur M. -

Ground Beetles (Coleoptera: Carabidae) of Azarbaijan, Iran
Turkish Journal of Zoology Turk J Zool (2013) 37: 188-194 http://journals.tubitak.gov.tr/zoology/ © TÜBİTAK Research Article doi:10.3906/zoo-1206-32 Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of Azarbaijan, Iran Ahmad ATAMEHR* Department of Agriculture, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran Received: 27.06.2012 Accepted: 24.11.2012 Published Online: 25.02.2013 Printed: 25.03.2013 Abstract: The Carabidae family (Coleoptera) is among the dominant groups of terrestrial predators and includes more than 40,000 species worldwide, making it one of the largest families of beetles. The fauna of Carabidae in Azarbaijan, Iran, is very diverse and has not been studied thoroughly. In the following paper, this group of beneficial predators is studied, using samples taken through 2007–2010 across Azarbaijan. Species belonging to 12 subfamilies were collected from 24 different localities. Among this diverse fauna, 3 species, Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758), Harpalus (Pseudoophonus) calceatus (Duftschmid, 1812), and Amara (Xenocelia) ingenua Duftschmid, 1812 are new records for Iranian fauna. Key words: Carabidae, ground beetle, new record, Azarbaijan, Iran 1. Introduction (2007), Toledano and Marggi (2007), and Muilwijk and Carabidae Latreille 1802, or ground beetles, belong to Felix (2008). the suborder Adephaga and order Coleoptera, and they Despite the importance of ground beetles as predators comprise more than 40,000 species worldwide. Carabids of insect pests in agroecosystems, few faunistic studies often are found on the ground and under stones or have been carried out in the study area (Afshar, 1944; logs, or in leaf litter, but many of them, especially those Farahbakhsh, 1961; Zomorrodi, 1990; Esmaili et al., 1991; in the tropics, are arboreal. -

Effects of Some Ecological Variables on Carabid
Effects of some ecological variables on carabid communities in native and non native forests in the Ibaizabal basin (Basque Country: Spain) Adoración Martínez, Juan Carlos Iturrondobeitia, Arturo Goldarazena To cite this version: Adoración Martínez, Juan Carlos Iturrondobeitia, Arturo Goldarazena. Effects of some ecological variables on carabid communities in native and non native forests in the Ibaizabal basin (Basque Country: Spain). Annals of Forest Science, Springer Nature (since 2011)/EDP Science (until 2010), 2009, 66 (3), 10.1051/forest/2009003. hal-00883447 HAL Id: hal-00883447 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00883447 Submitted on 1 Jan 2009 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Ann. For. Sci. 66 (2009) 304 Available online at: c INRA, EDP Sciences, 2009 www.afs-journal.org DOI: 10.1051/forest/2009003 Original article Effects of some ecological variables on carabid communities in native and non native forests in the Ibaizabal basin (Basque Country: Spain) Adoración Mart´inez1,JuanCarlosIturrondobeitia2,ArturoGoldarazena1* 1 -

Distinguendus Duft., Harpalus Rufipes (De Geer), Poecilus Cupreus (L.), Poecilus Sericeus F.W
distinguendus Duft., Harpalus rufipes (De Geer), Poecilus cupreus (L.), Poecilus sericeus F.W. 4. ÎЧăЫОгЮХЭКЭЮХăКЧКХТгОТăЩКЫКЦОЭЫТХШЫăОМШХШРТМТăКЬЮЩЫКăМШХОШЩЭОЫОХШЫăНТЧăПКЦТХТКăCКЫКЛТНКО,ă s-КЮăОЯТНОЧТКЭă7ăЬЩОМТТăКНЮЧНОЧЭОăşТăОЮНШЦТЧКЧЭО:ăHarpalus distinguendus Duft., Amara aenea (De Geer), Amara ovata (F.), Amara similata (Gyll.), Brachinus elegans Chd., Brachinus explodens DЮПЭ.,ăТăHarpalus rufipes (De Geer). BIBLIOGRAFIE 1. Freude H., Harde K., Lohse G. DТОăKтПОЫăMТЭЭОХОЮЫШЩКЬ.ăBКЧНă2,ăAНОЩСКРКă1.ăKЫОПОХН,ă 1976, 300 p. 2. Panin S. FКЮЧКăRОЩЮЛХТМТТăЩШЩЮХКЫОăRШЦсЧО.ăIЧЬОМЭК.ă– Vol. 10 (2), familia Carabidae. BucureşЭТ,ă1955,ăЩ. 5-140. 3. Simionescu V. LЮМЫЫТăЩЫКМЭТМОăНОăОМШХШРТО.ă- IКşТ:ăUЧТЯОЫЬТЭКЭОКă„A.ăI.ăCЮгК”,ă1983,ăЩ.ă 174-190. 4. Stan G. MОЭШНОă ЬЭКЭТЬЭТМОă МЮă КЩХТМКТТă ьЧă МОЫМОЭЫТă ОЧЭШЦШХШРТМОă //ă BЮХ.ă НОă ТЧПШЫЦКЫО,ă 1994. – N. 5(2), p. 113-126. 5. ă.ăă,ăăă.ă,ă2002, 167 . 6. ă.ăă.ă.ăă„”,ă1983Л.ă. I, 340c. 7. ă . ă ă ă ă ă ă ă .ă,ă1982,ă285. CZU 632.78(4-11) O NOUĂ SPECIE DE CICADE, METCALFA PRUINOSA ÎN EUROPA DE EST– PREГENT ȘI PERSPECTIVE A NEW SPECIES OF CICADA, METCALFA PRUINOSA, IN EASTERN EUROPE- PRESENT AND FUTURE GROZEA IOANA*,ăTEF RAMONA,ăVÎRTEIU ANA MARIA, CRBE A., MOLNAR L., țAГRE V. UЧТЯОrЬТЭКЭОКăНОăЭТТЧОăAРrТМШХОăТățОНТМТЧăVОЭОrТЧКrăКăBКЧКЭЮХЮТ"RОРОХОățТСКТăIăКХăRШЦсЧТОТ"ăНТЧăTТЦТШКrКă Abstract. Metcalfa pruinosa Say ОЬЭОăМШЧЬТНОЫКЭăШăЬЩОМТОăНЮЧЭШКЫОăТЦЩШЫЭКЧЭăЩОЧЭЫЮăЩХКЧЭОХОă ШЫЧКЦОЧЭКХОăНТЧăЩКЫМЮЫТăТăЬЩКТТХОăЯОЫгТăТăЩОЧЭЫЮăЩХКЧЭОХОăСШЫЭТМШХОăЩЫШНЮМЭТЯОă(ЩШЦТăПЫЮМЭТПОЫТăТăЯТКăНОă ЯТО).ăÎЧăEЮЫШЩКăНОăEЬЭăТăSЮН-EЬЭăКăПШЬЭăЬОЦЧКХКЭăЫОХКЭТЯăЫОМОЧЭ,ăТЧЬОМЭКăЬТЭЮсЧНЮ-ЬОăьЧăПКгКăНОăТЧЬЭКХКЫО,ă -

The Ground Beetles (Coleoptera: Carabidae) of the Bulgarian Black Sea Coast
370 Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18 (No 3) 2012, 370-386 Agricultural Academy THE GROUND BEETLES (COLEOPTERA: CARABIDAE) OF THE BULGARIAN BLACK SEA COAST T. TEOFILOVA1, E. MARKOVA1 and N. KODZHABASHEV2 1 Sofia University, Faculty of Biology, Department of Ecology and Environmental Protection, BG - 1164 Sofia, Bulgaria 2University of Forestry, Faculty of Forestry, Department of Hunting and Game Management, BG - 1756 Sofia, Bulgaria Abstract TEOFILOVA, T., E. MARKOVA and N. KODZHABASHEV, 2012. The ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of the Bulgarian Black Sea coast. Bulg. J. Agric. Sci., 18: 370-386 The publication represents the first complete overview of the established in the area of the Bulgarian Black Sea coast spe- cies from the Carabidae family. Full checklist of the all 465 species is given. Species of ground beetles are characterized and classified by their zoogeographical belonging, degree of endemism, habitat preferences, and life form they refer to Carabid’s subsuming to the subdivisions Northern or Southern Black Sea coast is pointed. Key words: Carabidae, ground beetles, Black Sea coast Introduction occurring in the area of the Bulgarian Black Sea coast 98 species were described, and for 5 more it was consid- Combination of various environmental factors con- ered that they would probably be found there. Data for tributed to the definition of the Black Sea coast as a de- the species of the researched zoogeographical region tached zoogeographical region (Gruev and Kuzmanov, was found also in the revision of Rambousek (1912). 1994) and in terms of wildlife, it could be claimed that The second period of studies included the time until ground beetles are convenient and expedient group for around 1950 and was characterized by more intensive monitoring and bioindication researches (Desender and and detailed faunistic researches. -

The Family of Carabidae (Coleoptera) in Artvin Hatila National Park of Turkey Temel Gokturk1*, Alim Celik2
International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB) Vol-2, Issue-2, Mar -Apr- 2017 http://dx.doi.org/10.22161/ijeab/2.2.55 ISSN: 2456-1878 The Family of Carabidae (Coleoptera) in Artvin Hatila National Park of Turkey Temel Gokturk1*, Alim Celik2 1*Artvin Coruh University, Faculty of Forestry, Department of Forest Entomology and Protection, Artvin, Turkey 2Artvin Forest Department, Forest Protection, Artvin, Turkey Abstract— The faunistical studies on the family Carabidae Hatila Valley National Park and around by using of the (Coleoptera) species in Artvin Hatila National Park in pitfall trap method. Turkey. In this study, totally 32 species belonging to Pterostichinae, Brachininae, Carabinae, Platyninae, II. MATERIAL AND METHODS Lebiinae, Nebriinae and Harpalinae subfamilies of Artvin Hatila Valley National Park was announced as a Carabidae were collected from Artvin province during national park in 1994 and became one of the 40 national 2011-2014. Among these, Amara lucida Duftschmid, parks in our country. This national park area has 16998- Amara aulica Panzer, Brachinus elegans Chaudoir, hectare area and the GPS coordinates of 41º 11′ 11′′ N, 41º Brachinus crepitans Linné, Carabus scabrosus Olivier, 44′ 09′ E′. The altitude of the highest point is 3224 m (Kurt Anisodactylus binotatus Fabricius, Carabus coriaceus Mountain), and the lowest point is 160 m (Çoruh River). Linnaeus, Carabus mulsantianus Paykull, Carabus This national park area has relict and endemic plant cover, graecus Dejean, Harpalus affinis Schrank, Harpalus unusual geological and geomorphological structure, unique caspius Panzer, Ophonus cribricollis Dejean, Ophonus scenic beauty, rich fauna and recreational potential. Semi- azureus Fabricius, Ophonus subquadratus Dejean, arid, subhumid and humid climates are seen in the area. -

Effects of Altered Mowing Regimes in Extensively Managed Meadows on Ground and Rove Beetles
Effects of altered mowing regimes in extensively managed meadows on ground and rove beetles Masterarbeit der Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der !Universität Bern vorgelegt von Lukas Lischer 2016 Leiter der Arbeit !Dr Jean-Yves Humbert Dr Roel van Klink Prof Dr Raphaël Arlettaz Effects of altered mowing regimes in extensively managed meadows on ground and rove beetles Lukas Lischer1, Jean-Yves Humbert1, Roel van Klink1, 3, Raphaël Arlettaz1, 2 1Division of Conservation Biology, Institute of Ecology and Evolution, University of Bern, Baltzerstrasse 6, 3012 Bern, Switzerland 2Swiss Ornithological Institute, Valais Field Station, Rue du Rhône 11, 1950 Sion, Switzerland 3 Nature Conservation and Plant Ecology Group, Wageningen University, Droevendaalsest 2/35 Abstract 1. The agri-environment schemes (AES) that were launched in Western Europe two decades ago have failed to increase biodiversity in grasslands, which have suffered from massive farmland conversion and intensification since World War II. New AES regulations are thus needed to improve the status of grassland biodiversity. 2. We tested the effects of experimentally altered mowing regimes on ground (Carabidae) and rove (Staphylinidae) beetle communities of extensively managed meadows (EMM) declared as AES measures in 12 replicated areas across the Swiss Plateau. In each area, four different mowing regimes were randomly applied to four meadows, with one treatment per meadow: 1) control EMM (hereafter C-meadow), with first cut not before 15 June, no fertilisation and no restriction on number and frequency of subsequent cuts (in line with the standard Swiss AES regulation); 2) delayed mowing EMM (D-meadow), with first cut not before 15 July; 3) 8 weeks EMM (8w-meadow), like C-meadows but with maximum two cuts per year and a minimum of 8 weeks in between; and 4) refuge EMM (R-meadow), like C-meadows but with a rotational uncut refuge on 10–20% of the meadow area. -

On the Fauna of Ground Beetles (Coleoptera, Carabidae) of Iran, with Additional Notes on the Variability and Identity of Omophron (S.Str.) Rotundatum Chaudoir, 1852
Baltic J. Coleopterol. 16(1) 2016 ISSN 1407 - 8619 On the fauna of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of Iran, with additional notes on the variability and identity of Omophron (s.str.) rotundatum Chaudoir, 1852 Saeed Azadbakhsh Azadbakhsh S. 2016. On the fauna of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of Iran, with additional notes on the variability and identity of Omophron (s.str.) rotundatum Chaudoir, 1852. Baltic J. Coleopterol. 16 (1): 45-57. The paper presents faunistic results for 50 species of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from different provinces of Iran. Poecilus (s.str.) festivus (Chaudoir, 1868) and Bembidion (Ocydromus) hiekei Muller-Motzfeld, 1986 are reported from Iran for the first time. The vari- ability of Omophron (s.str.) rotundatum Chaudoir, 1852 in a population from South Iran is discussed. Key words. Carabidae, Iran, Omophron, faunistics, new records. Department of Plant Protection of Razi University, Kermanshah. Iran; e-mail: [email protected] INTRODUCTION elucidating the fauna of ground beetles and en- hancing our knowledge about the distribution of Iran is the 16th largest country in the world and ground beetles in these parts have allowed for subdivided into 31 provinces, which represent a the discovery of some interesting species that broad range of climates. In Iran, 955 species of can be assumed as new records for these prov- Carabidae are known based on the checklist of inces or for Iran. Explorations done in the South Iranian ground beetles as arranged by Azadbaksh of Iran (Hormozgan province) have resulted in & Nozari (2015). Although there have been many the discovery of a new population of O. -

The Matrix Affects Carabid Beetle Assemblages in Linear Urban Ruderal Habitats Marju Prass 1 • Al Vrezec 2 • Heikki Setälä 1 • D
The matrix affects carabid beetle assemblages in linear urban ruderal habitats Marju Prass 1 • Al Vrezec 2 • Heikki Setälä 1 • D. Johan Kotze 1 Abstract Matrix contrasts affect communities in patchy landscapes by influencing resources, abiotic conditions and spill-over effects. However, current knowledge is significantly biased towards forest and rural communities. We examined the effects of three different matrix types, i.e., low, intermediate and high contrasts, on carabid beetle assemblages at urban railway verges in two climatic regions. Study sites were located in Finland and in Slovenia. Using pitfall trapping, non-metric multidimensional scaling and generalised linear mixed models, we investigated carabid assemblages at railway verges and in differently contrasting adjacent matrices, i.e. built-up, grassland and forest. The matrix influenced carabid assemblages at railway verges. Assemblages grouped with adjacent matrix types, although some Finnish railway assemblages included a characteristic set of open dry habitat species. Abundances of generalist species at railway verges were higher when next to grassland or forest than urban matrices. Habitat specialists responded negatively to high contrast matrices, resulting in lower abundances of open habitat specialists in railway verges when next to forests and nearly no spill-over of forest specialists into railway verges. These patterns were consistent in both countries, i.e. irrespective of climatic region. Our study emphasises effects of the adjacent matrix and matrix contrasts on communities in linear open habitat patches in cities. Knowledge on matrix effects in patchy landscapes, such as urban environments, is essential in understanding the distribution and composition of communities in discrete patches. This knowledge can be used in conservation planning. -

Inizio Anno 2018 MM
ATTI DELLA ACCADEMIA NAZIONALE ITALIANA DI ENTOMOLOGIA RENDICONTI Anno LXVI 2018 TIPOGRAFIA COPPINI - FIRENZE ATTI DELLA ACCADEMIA NAZIONALE ITALIANA DI ENTOMOLOGIA RENDICONTI Anno LXVI 2018 TIPOGRAFIA COPPINI - FIRENZE ISSN 0065-0757 Direttore Responsabile: Prof. Romano Dallai Presidente Accademia Nazionale Italiana di Entomologia Coordinatore della Redazione: Dr. Roberto Nannelli La responsabilità dei lavori pubblicati è esclusivamente degli autori Registrazione al Tribunale di Firenze n. 5422 del 24 maggio 2005 INDICE Rendiconti Consiglio di Presidenza . Pag. 5 Elenco degli Accademici . »6 Verbali delle adunanze del 23-24 febbraio 2018 . »9 Verbali delle adunanze del 8-9 giugno 2018 . »19 Verbali delle adunanze del 16-17 novembre 2018 . »27 Commemorazione ROBERTO NANNELLI – Breve ricordo di Fausta Pegazzano . »51 Letture GIUSEPPE GARGIULO – Interazione ospite-parassitoide: analisi dei fattori di virulenza nel modello Drosophila . »57 EMILIO BALLETTO, FRANCESCA BARBERO, SIMONA BONELLI,LUCA PIETRO CASACCI – La mirmecofilia nelle farfalle diurne europee . »63 ROBERTO A. PANTALEONI, MAURO RUSTICI – Il nemico condiviso e l’entomologia applicata: alcune chiavi di lettura . »69 Tavola Rotonda su: DISCESE TERMICHE E TEMPERATURE BASSE E ULTRABASSE PER LA CREAZIONE DI COLLEZIONI VIVENTI DI INTERESSE AGROFORESTALE PIO FEDERICO ROVERSI, FRANCESCO PAOLI, SILVIA LANDI – Embriologia e crioconservazione di insetti . »77 MAURIZIO LAMBARDI – La crioconservazione di specie arboree: dal laboratorio alla criobanca . »81 SAURO SIMONI, ENRICO DE LILLO – Note su conservazione a basse temperature di ceppi di acari utilizza- bili per il controllo biologico . »89 GIAN PAOLO BARZANTI, VALERIA FRANCARDI – Tecniche per la crioconservazione di microrganismi ento- mopatogeni . »95 SILVIA LANDI, GIULIA TORRINI, EUSTACHIO TARASCO – Temperature ultrabasse e protocolli cryo per la costituzione di collezioni viventi di nematodi entomopatogeni .