1997: Caravaggio E I Suoi Primi Seguaci[10600
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

El Viaje a Italia De Luis Tristán. a Propósito De Una Crucifixión Firmada (16I Ismael Gutiérrez Pastor Universidad Autónoma De Madrid
El viaje a Italia de Luis Tristán. A propósito de una Crucifixión firmada (16i Ismael Gutiérrez Pastor Universidad Autónoma de Madrid Anuario del Depariaiuniiw ur; ruxuia y iaiiiauu ruir: RESUMEN SUMMARY Una Crucimón del pintor Luis Tristán, firmada y A "CrucijkG by Luis Ti nn VA fechada en Toledo en 1609, que muestra aún el estilo de and dated in Toleao in IOUY. rr srirl snows nrs masrers su maestro El Greco, permite fijar en los años 1610 y style, El Greco. The painting enables us tofu. his trip to 1611 su viaje a Italia y relacionar el cambio de estilo con Italy during 1610 and 1611. His style change can be rela- sus relaciones, tanto con Ribera documentodo por ted with !lis relarionships with Ribem (Documented by Jusepe Martínez- como con Orazio Borgianni, pintor Jusepe Manínezl i as wefl a3 with Ongzio Borgi anni. The que había estado en España en dos ocasiones y que hacia latter h 7 Spain tw,ice and about 1608 r rhifted his 1608 transformó su estilo adecuándolo al de Caravaggio. style al to Caravalrgio's one. clusión i las prime de su vid; cambi6 sus apeiiiaos:8.2- - en iov~,ai nrmar su aprenaizaje Elpintor que conocemos como Luis Tristán (c. 1590- con El Greco, lo hace como Luis Escamilla y así se man- Toledo, 1624) fue hijo de Domingo Rodríguez y de Ana tiene en otros varios documentos relativos a su maestro. de Escamilla. Hasta fechas muy avanzadas firmó como Pero en fecha inmediatamente posterior, la cual podemos Luis Escamilla, utilizando el apellido materno, mientras ahora acotar con la aparición de una CruciQkión firmada que otros hermanos suyos utilizaban el compuesto Rodrí- "LUYS TRISTAN FACIEBATI TOLETi 1609", comenzó guez de Escamilla (por ejemplo, Manuel o Agustina) y su a usar el apellido Tristán, siendo de especial importancia hermana Úrsula se hacía apellidar Tristán. -
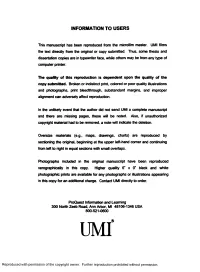
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy subm itted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6’ x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. ProQuest Information and Learning 300 North Zeeb Road. Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 800-521-0600 Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. NOTE TO USERS Copyrighted materials in this document have not been filmed at the request of the author. They are available for consultation at the author’s university library. -

The Pennsylvania State University
The Pennsylvania State University The Graduate School College of Arts and Architecture THE CRISTOS YACENTES OF GREGORIO FERNÁNDEZ: POLYCHROME SCULPTURES OF THE SUPINE CHRIST IN SEVENTEENTH-CENTURY SPAIN A Dissertation in Art History by Ilenia Colón Mendoza © 2008 Ilenia Colón Mendoza Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy August 2008 The dissertation of Ilenia Colón Mendoza was reviewed and approved* by the following: Jeanne Chenault Porter Associate Professor Emeritus of Art History Dissertation Co-Advisor Co-Chair of Committee Brian A. Curran Associate Professor of Art History Dissertation Co-Advisor Co-Chair of Committee Elizabeth J. Walters Associate Professor of Art History Simone Osthoff Associate Professor of Art Craig Zabel Associate Professor of Art History Head of the Department of Art History *Signatures are on file in the Graduate School. ii Abstract The Cristo yacente, or supine Christ, is a sculptural type whose origins date back to the Middle Ages. In seventeenth-century Spain these images became immensely popular as devotional aids and vehicles for spiritual contemplation. As a form of sacred drama these sculptures encouraged the faithful to reflect upon the suffering, death, and Resurrection of Christ as well as His promise of salvation. Perhaps the most well-known example of this type is by the Valladolidian sculptor, Gregorio Fernández (1576-1636). Located in the Capuchin Convent of El Pardo near Madrid, this work was created in accordance with Counter-Reformation mandates that required religious images inspire both piety and empathy. As a “semi-narrative”, the Cristo yacente encompasses different moments in the Passion of Christ, including the Lamentation, Anointment, and Entombment. -

Saint Matthews
Luis Tristán (1580/1585 - 1624) Saint Matthews Oil on canvas Measurements: 107 x 77 cm Spanish XVII century Painted about 1613 Description Apostle Saint Matthews? Saint Jude Tadeo?, Saint Matías ? or Saint Thomas ? AN APOSTLE BY LUIS TRISTÁN: RELATIONSHIP WITH EL GRECO, RIBERA, VELAZQUEZ AND THE NEW ITALIAN NATURALISTIC CURRENTS. The work we are studying represents an apostle in all his splendour and monumentality, whose iconographic identification is doubtful since the only attribute appearing is the halberd which is common to various apostles. Saint Matthews, creator of the first Gospel and Saint Jude Tadeo, also represented by El Greco with a halberd, are the most probable; San Matías is less probable due to having been martirized with an axe; and Saint Thomas, although the attribute does not correspond, since he died pierced by a lance, also could be the apostle represented due to his close relationship to the composition with the Saint Thomas of the Apostles by El Greco (El Greco Museum, Toledo) and the Saint Thomas by Velazquez (Orleans Museum). The painter certainly did not wish to centre his attention on an individualized identification of the saint, but rather on his general symbology as apostle: the halberd or lance with regard to his martyrdom as a form of death, the heavy tunic, with imposing folds, referring to his mighty task of spreading the Gospel continuously for the Church and the strong expression on his face in allusion to his tenacious character and indomitable conviction needed to accomplish his mission. The work can be attributed to the best work of Luis Tristán, and due to its quality may be considered a masterpiece carried out just on his return from his journey to Italy, in about 1613 when his spirit was still teeming excitedly with the ideas gathered in El Greco’s workshop and his contact with the modern Roman naturalistic currents shared with the young José Ribera. -

1 Caravaggio and a Neuroarthistory Of
CARAVAGGIO AND A NEUROARTHISTORY OF ENGAGEMENT Kajsa Berg A thesis submitted in fulfilment of the requirements For the degree of Doctor of Philosophy University of East Anglia September 2009 © This copy of the thesis has been supplied on the condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and that no quotation from the thesis, nor any information derived therefrom, may be published without the author’s prior written consent. 1 Abstract ABSTRACT John Onians, David Freedberg and Norman Bryson have all suggested that neuroscience may be particularly useful in examining emotional responses to art. This thesis presents a neuroarthistorical approach to viewer engagement in order to examine Caravaggio’s paintings and the responses of early-seventeenth-century viewers in Rome. Data concerning mirror neurons suggests that people engaged empathetically with Caravaggio’s paintings because of his innovative use of movement. While spiritual exercises have been connected to Caravaggio’s interpretation of subject matter, knowledge about neural plasticity (how the brain changes as a result of experience and training), indicates that people who continually practiced these exercises would be more susceptible to emotionally engaging imagery. The thesis develops Baxandall’s concept of the ‘period eye’ in order to demonstrate that neuroscience is useful in context specific art-historical queries. Applying data concerning the ‘contextual brain’ facilitates the examination of both the cognitive skills and the emotional factors involved in viewer engagement. The skilful rendering of gestures and expressions was a part of the artist’s repertoire and Artemisia Gentileschi’s adaptation of the violent action emphasised in Caravaggio’s Judith Beheading Holofernes testifies to her engagement with his painting. -

TASTE and PRUDENCE in the ART of JUSEPE DE RIBERA by Hannah Joy Friedman a Dissertation Submitted to the Johns Hopkins Universit
TASTE AND PRUDENCE IN THE ART OF JUSEPE DE RIBERA by Hannah Joy Friedman A dissertation submitted to the Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Baltimore, Maryland May, 2016 Copyright Hannah Joy Friedman, 2016 (c) Abstract: Throughout his long career in southern Italy, the Spanish artist Jusepe de Ribera (1591- 1652) showed a vested interest in the shifting practices and expectations that went into looking at pictures. As I argue, the artist’s evident preoccupation with sensory experience is inseparable from his attention to the ways in which people evaluated and spoke about art. Ribera’s depictions of sensory experience, in works such as the circa 1615 Five Senses, the circa 1622 Studies of Features, and the 1637 Isaac Blessing Jacob, approach the subject of the bodily senses in terms of evaluation and questioning, emphasizing the link between sensory experience and prudence. Ribera worked at a time and place when practices of connoisseurship were not, as they are today, a narrow set of preoccupations with attribution and chronology but a wide range of qualitative evaluations, and early sources describe him as a tasteful participant in a spoken connoisseurial culture. In these texts, the usage of the term “taste,” gusto, links the assessment of Ribera’s work to his own capacity to judge the works of other artists. Both taste and prudence were crucial social skills within the courtly culture that composed the upper tier of Ribera’s audience, and his pictures respond to the tensions surrounding sincerity of expression or acceptance of sensory experience in a novel and often satirical vein. -

Lamentation Over the Dead Christ
1 PINACOTECA DI BRERA BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Via Brera 28, 20121 Milano t +39 02 72263264 - 229 [email protected] www.pinacotecabrera.org press release June, 13th 2016 Milan, Pinacoteca di Brera June, 16th 2016- Grand Opening: free admission from 8.30 a.m. to 10.15 p.m. MANTEGNA AND CARRACCI. AROUND THE LAMENTATION OVER THE DEAD CHRIST Annibale Carracci’s Lamentation over the Dead Christ is coming to Brera 2 to engage in dialogue with Andrea Mantegna’s masterpiece. rom 16 June to 25 September 2016 the Pinacoteca di Brera will be hosting a spectacular new dialogue between two masterpieces in the history of world art: FAndrea Mantegna’s Lamentation over the Dead Christ, one of the Milan picture gallery’s most emblematic works and a universal icon of the Renaissance, and the Corpse of Christ (or The Body of Christ and the Implements of His Martyrdom), a version of the same subject painted by Annibale Carracci in 1583–1585 and on loan from the Staatsgalerie in Stuttgart. The two works, displayed side by side for the very first time, comprise the second outstanding dialogue devised by the Pinacoteca di Brera, a museum in the process of renewing its approach in an effort to offer its visitors food for thought with a collec- tion that includes some of the most important masterpieces of painting in the world. Mantegna’s work will be shown not only alongside Carracci’s version but also with another version of the same theme, the Lamentation over the Dead Christ, painted by Orazio Borgianni in 1615 and on loan from the Galleria Spada in Rome. -

Still Life with Fruit on a Stone Ledge
CARAVAGGIO Still Life with Fruit on a Stone Ledge AARON H. DE GROFT, PH.D., EDITOR PAPERS OF THE MUSCARELLE MUSEUM OF ART VOL. I From the Symposium held at the Muscarelle Museum of Art at The College of William & Mary November 9 - 10, 2006 Caravaggio: Still Life with Fruit on a Stone Ledge, Papers of the Muscarelle Museum of Art, Vol. 1, The College of William & Mary, Williamsburg, Virginia. © 2010, Muscarelle Museum of Art The College of William & Mary All rights reserved. Produced by the Muscarelle Museum of Art Printed in the USA by Taylored Printing Co., Yorktown, Virginia Production & Design by Amy K. Gorman MUSEUM STAFF Aaron H. De Groft, Ph.D., Director Elana Carpinone, Registrar’s Fellow Christina Carroll, Manager of Institutional Advancement Caravaggio: Still Life with Fruit on a Stone Ledge, Papers of the Kevin Gilliam, Exhibitions/Operations Manager Amy K. Gorman, Ph.D., Curator of Education & New Media Symposium held at the Muscarelle Museum of Art at The College Cindy Lucas, Assistant to the Director of William & Mary. Vol. 1. / edited by Rusty A. Meadows, Assistant to Development & Education Aaron H. De Groft, Ph.D. Ursula McLaughlin-Miller, Special Projects Administrator Melissa Parris, Registrar Elayne Russell, Education Specialist p. 160 : 98 ills. ; 27.8 cm. Bronwen Watts, Membership Manager Includes bibliographical references. BOARD OF DIRECTORS Contents: Introduction / Aaron H. De Groft—Caravaggio and the Theresa Thompson, W&M ‘67 - Chair Connie Desaulniers, W&M ‘75 - Secretary Origins of Roman Still Life Painting /John T. Spike—The Final William B. Bales Insult: Caravaggio, Baglione, and Still Life on a Stone Ledge / John Anne H. -

Michael Sweerts (1618-1664) and the Academic Tradition
ABSTRACT Title of Document: MICHAEL SWEERTS (1618-1664) AND THE ACADEMIC TRADITION Lara Rebecca Yeager-Crasselt, Doctor of Philosophy, 2013 Directed By: Professor Arthur K. Wheelock, Jr., Department of Art History and Archaeology This dissertation examines the career of Flemish artist Michael Sweerts (1618-1664) in Brussels and Rome, and his place in the development of an academic tradition in the Netherlands in the seventeenth century. Sweerts demonstrated a deep interest in artistic practice, theory and pedagogy over the course of his career, which found remarkable expression in a number of paintings that represent artists learning and practicing their profession. In studios and local neighborhoods, Sweerts depicts artists drawing or painting after antique sculpture and live models, reflecting the coalescence of Northern and Southern attitudes towards the education of artists and the function and meaning of the early modern academy. By shifting the emphasis on Sweerts away from the Bamboccianti – the contemporary group of Dutch and Flemish genre painters who depicted Rome’s everyday subject matter – to a different set of artistic traditions, this dissertation is able to approach the artist from new contextual and theoretical perspectives. It firmly situates Sweerts within the artistic and intellectual contexts of his native Brussels, examining the classicistic traditions and tapestry industry that he encountered as a young, aspiring artist. It positions him and his work in relation to the Italian academic culture he experienced in Rome, as well as investigating his engagement with the work of the Flemish sculptor François Duquesnoy (1597-1643) and the French painter Nicholas Poussin (1594-1665). The breadth of Sweerts’ artistic and academic pursuits ultimately provide significant insight into the ways in which the Netherlandish artistic traditions of naturalism and working from life coalesced with the theoretical and practical aims of the academy. -

Making Self Portraits
Podcast transcript MAKING SELF PORTRAITS Hello, and welcome to a podcast from Royal Collection Trust. Today's lecture at The Queen's Gallery, Buckingham Palace, is given by Lucy Peter, Assistant Curator of Paintings. In this lecture, Lucy talks about the art of creating a self-portrait. Other talks and lectures within our events programme can be found using our what's on guide on our website. So hello, and welcome to The Queen's Gallery, for those of you who haven't been here before. So as Lexi said, I'm Lucy Peter and I'm Assistant Curator at Royal Collection Trust. Today, in this talk, I'm going to be looking really at how artists made self-portraits. Firstly, thinking about the production and availability of mirrors and what impact the invention of flat glass mirrors had on the development of self-portraiture in general. And then in the second half I'm going to be looking at how artists use mirrors to paint self-portraits and what unique challenges this presented them with. So really to start with I just want to say that before the invention of photography artists had to use mirrors to produce self-portraits. Thus one of the fundamental, practical considerations with painted self-portraits, and easy to forget today, was the availability and the quality of the mirrors. The mirror, as we know it today, a flat glass surface with a metal coated back, was not invented until around 1500. And before this, artists had to make do with what mirrors were available, which invariably would produce either a discoloured or a distorted reflection. -
Abengoa in 2006502 KB
Abengoa in 2006 Abengoa in 2006 · Social Action Internal Social Action External Social Action · Economic Performance · Environmental Performance · Dialogue with Interested Parties ABENGOA Corporate Social Responsibility Report 2006 33 Abengoa in 2006 Social Action Social Action We have selected two focal points based on specific groups that aid us in structuring our efforts and channelling our concerns to be of greater assistance to In today’s climate of constant change and global them. The first is internal social action within the company itself, and the second is competition, Abengoa regards the innovative external social action in benefit of society. company as an efficient and necessary tool to achieve a sustainable development society. With this in mind, we have incorporated corporate social Internal Social Action responsibility values in our everyday activity, naturally integrating them into our company strategy, its During 2006, Abengoa’s staff amounted to an average of 13,608 employees, culture and its organisation. Not only do we actively which represents an increase of 23%. work for economic progress, we also want to make By Business Groups, employees are distributed as follows a positive contribution to social and environmental improvements in the interests of humanity. Business Groups 2005 2006 % Using solar energy, biomass, residue, information Solar 19 41 116 technology and engineering, Abengoa applies Bioenergy 421 527 25 innovative technological solutions to attain Environmental Services 1,348 1,563 16 sustainable development. At the same time, the company uses the Focus-Abengoa Foundation as a Information Technologies 2,373 3,155 33 Industrial Engineering and channel to express its commitment to society. -

The Male Gaze and Other Reasons for the Hypothetical End of Christian
THE ETIENNE GILSON SERIES 26 The Male Gaze and Other Reasons for the Hypothetical End of Christian Art in the West KARL F. MORRISON 5 March 2004 PONTIFICAL INSTITUTE OF MEDIAEVAL STUDIES Karl F. Morrison is Lessing Professor of History and Poetics at Rutgers University. His books include The Mimetic Tradition of Reform in the West (1982), Holiness and Politics in Early Medieval Thought (1985), “I Am You”: The Hermeneutics of Empathy in Western Literature, Theology, and Art (1988), History as a Visual Art in the Twelfth-Century Renaissance (1990), and Understanding Conversion and Conversion and Text (1992). Front cover Detail from Jan Van Bijlert, The Calling of Matthew (ca 1620–1629). Budapest: Museum of Fine Art. The Etienne Gilson Series 26 ISSN 0–708–319X ISBN 0–88844–726–4 © 2005 Pontifical Institute of Mediaeval Studies 59 Queen’s Park Crescent East Toronto, Ontario, Canada M5S 2C4 PRINTED IN CANADA www.pims.ca begin this talk in a contrite frame of mind. My intention was, and is, to pay tribute to Étienne Gilson (1884–1978), because we are here to honor I him and, speaking for myself, because, with a fragment by Xenophon of Colophon, his writings suggested a connection to my mind between the project of self-knowing and religious art as a kind of mirror that makes it possible for us to see, and know, ourselves. (After all, we cannot see our own faces without some kind of mirror.) However, Gilson’s writings offer little on the subject of medieval art. That is why, incongruously enough, I am offering to the Pontifical Institute of Mediaeval Studies a talk that follows where Gilson’s enthusiasms led, to the Counter-Reformation and its aftermath down to Cubism.