Aprile 1999 N°35
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Curriculum Vitae
Curriculum Vitae INFORMAZIONI PERSONALI Nome GIUSEPPE Cognome VENTURELLA Recapiti Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali Telefono 329-6156064 E-mail [email protected] [email protected] FORMAZIONE TITOLI • Date 3 gennaio 2008 • Nome e tipo di istituto di istruzione o Facoltà di Agraria di Palermo - Decreto formazione Rettorale n°30 • Principali materie / abilità professionali Botanica Sistematica, Botanica forestale e oggetto dello studio micologia • Qualifica conseguita Conferma in ruolo a Professore Ordinario per il settore BIO/02 • Livello nella classificazione nazionale Professore Ordinario per il settore BIO/02 • Date 3 gennaio 2005 • Nome e tipo di istituto di istruzione o Facoltà di Agraria di Palermo- Decreto formazione Rettorale n°30 • Principali materie / abilità professionali Botanica Sistematica, Botanica forestale e oggetto dello studio micologia • Qualifica conseguita Nomina a Professore Straordinario per il settore BIO/02 • Livello nella classificazione nazionale Professore Straordinario per il settore BIO/ 02 • Date novembre 1992 – gennaio 2005 • Nome e tipo di istituto di istruzione o Facoltà di Agraria di Palermo formazione • Principali materie / abilità professionali Botanica Ambientale e Applicata, Botanica oggetto dello studio forestale e micologia • Qualifica conseguita Professore Associato gruppo E011 (BIO/03) • Livello nella classificazione nazionale Professore Associato gruppo E011 (BIO/ 03) • Date 1990 • Nome e tipo di istituto di istruzione o Corso di Laurea in Scienze Biologiche formazione -

Findings from the Preliminary Analysis of Faunal Remains at Ancient Eleon
Findings from the Preliminary Analysis of Faunal Remains at Ancient Eleon by Matthew Bullock B.A, Anthropology, University of Victoria, 2012 A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF ARTS in the Department of Anthropology © Matthew Bullock, 2018 University of Victoria All rights reserved. This thesis may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without the permission of the author. ii Supervisory Committee Findings from the Preliminary Analysis of Faunal Remains at Ancient Eleon by Matthew Bullock B.A, Anthropology, University of Victoria, 2012 Supervisory Committee Dr. Yin Lam, Co-supervisor Department of Anthropology Dr. Brendan Burke, Co-supervisor Department of Greek and Roman Studies iii Abstract A relatively small, but well-preserved, assemblage of faunal remains centered around an apparent refuse heap in the southwest quadrant of Eleon has been analyzed to determine the relative representation of domesticated and wild taxa, as well as mortality profiles for sheep and goats. Although the total number of identified specimens is low, at 1059 fragments, several patterns have emerged in the data that warrant further analysis. The representation of deer among these remains is higher than at other sites on the Greek mainland. Lower utility elements such as metapodials and tibiae are better represented than meatier portions of the skeleton, suggesting that entire carcasses were being processed onsite. Mortality profiles developed from sheep and goat mandibles indicate distinct management strategies for each species, with a high number of very young and juvenile goats, compared with many more mature sheep. -

Area Marina Protetta Capo Milazzo Istruttoria Tecnica
Convenzione DPNM-ISPRA per la collaborazione all’istituzione delle aree marine protette “Capo Milazzo”, Grotte di Ripalta-Torre Calderina”, “Costa del Monte Conero” e “Capo Testa-Punta Falcone” PR ISPRA 33018 STUDIO PROPEDEUTICO ALL’ISTITUZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “CAPO MILAZZO” E PROPOSTA DI ZONAZIONE 22 Dicembre 2016 Responsabile scientifico: Dr. Leonardo Tunesi Responsabile della pianificazione e del coordinamento delle attività: Dr.ssa Taira Di Nora Coordinamento aspetti ambientali: Dr. Gabriele La Mesa Dr.ssa. Sabrina Agnesi Collaboratori allo studio: Dr. Ivan Consalvo Redazione testi: Dr.ssa Taira Di Nora Dr. Gabriele La Mesa Dr. Ivan Consalvo Dr.ssa Rosa Anna Mascolo Dr.ssa Eva Salvati Dr.ssa Michela Giusti Attività di campo: Aspetti ambientali Dr. Leonardo Tunesi Dr. Gabriele La Mesa Dr.ssa Eva Salvati Dr. Simonepietro Canese Dr.ssa Michela Giusti Dr.ssa Sabrina Agnesi Aspetti socio-economici Dr.ssa Taira Di Nora Dr. Gabriele La Mesa Dr. Ivan Consalvo Elaborazione cartografica: Dr. Emiliano Canali Dr.ssa Michela Giusti Dr. Aldo Annunziatellis Dr. Carlo Innocenti Si ringraziano per la collaborazione: Il Comune di Milazzo La Capitaneria di Porto di Milazzo Gli operatori che hanno partecipato ai tavoli tecnici I colleghi della Sede ISPRA di Milazzo ed in particolare la dott.ssa Teresa Romeo Sommario CAPITOLO 1. INTRODUZIONE ...................................................................................................1 1.1 Premessa .................................................................................................................................1 -

Report on Two Further Human Inhumations from Campanaio, Province of Agrigento, Sicily (Site Code MO98)
Reports from the Environmental Archaeology Unit, York 98/39, 8 pp. Report on two further human inhumations from Campanaio, Province of Agrigento, Sicily (site code MO98) by Cluny Johnstone Summary Two further human skeletons, both assumed to be late Roman or early post-Roman in date, were recovered during the 1998 field season at Campanaio. They were initially recorded in situ and examined in more detail after excavation and cleaning. The burial positions of both individuals were virtually identical (east-west alignment, lying on right side, arms and legs extended) and the same as the skeleton (E328) excavated in the 1997 field season. Skeleton E349 was a male individual, between 25 and 35 years of age and about 182 cm tall. Several pathological conditions were noted, including thalassaemia and a lesion tentatively identified as a metastatic carcinoma. Skeleton E350 was a subadult individual between 12 and 15 years of age. Keywords: SICILY; CAMPANAIO; LATE ROMAN - EARLY POST-ROMAN; HUMAN REMAINS; INHUMATIONS; SUBADULT; PATHOLOGY; THALASSAEMIA Author’s address: Prepared for: Palaeoecology Research Services Professor Roger Wilson Environmental Archaeology Unit Dept. of Archaeology Dept. of Biology University of Nottingham University of York Nottingham PO Box 373 NG7 2RD York YO10 5YW, UK Telephone: (01904) 433846/ 434487/434475 16th December 1998 Fax: (01904) 433850 Reports from the EAU, York, 98/39 Human skeletons from Campanaio, Sicily Report on two further human skeletons from Campanaio, Province of Agrigento, Sicily (site code: MO98) Introduction well preserved. The site of Campanaio, commune of Description of the inhumation Montallegro (Province of Agrigento), lies on a gently sloping hill facing west towards a The skeleton lay on its right-hand side with small lake. -

Trap Door 17
Issue No. 17, April 1997. Edited and published by Robert Lichtman, P. O. Box 30, Glen Ellen, CA 95442 USA. Please send all trade fanzines and letters of comment to this address. Founding member and Past President1991: fwa. Also a supporter of afal. A Fanzine of Record (see below), available by Editorial Whim in response to The Usual, or $4.00 per issue (reviewers please note!). The Usual includes your letters, contributions both written and artistic, and accepted trades. If there’s an “X” on your mailing label, this may be your last issue unless you respond. All contents copyright © 1997 by Trap Door with all rights reverting to individual contributors upon publication. Contents of This Issue: Doorway Robert Lichtman 2 For Dick Ellington, Berkeley Typesetter Julia Vinograd 5 Agbergs Abroad: Paris & Sicily Karen Haber Silverberg 6 It’s A Mystery To Me, Too Ron Bennett 11 Stuff Carol Carr 14 Bodies In Rest & Motion Richard Brandt 17 The Cosmopolitan Boy Steve Stiles 19 Shock Horror Probe! Dave Langford 22 Our Man in... Sidney Coleman 24 Grunt Calvin Demmon 26 The (Science) Fiction of History Christina Lake 28 The Ether Still Vibrates the Readers 31 ART A GRAPHICS: ATom (2), Brad Foster (cover), Lee Hoffman (14), William Rotsler (13,16, 27, 30, 48), Craig Smith (22), Dan Steffan (2, 6, 11, 19, 26), Steve Stiles (17, 24, 25, 28, 31). A little background: Hoover Dam is part of the American tourist experience, right up there with the Grand Canyon and Disneyland. Completed in 1936, the steel and concrete dam is 726 feet tall and measures 1,244 feet across its widest point. -

Reports from the Environmental Archaeology Unit, York 97/53, 10 Pp
Reports from the Environmental Archaeology Unit, York 97/53, 11 pp. & 6 pp. Appendix. Preliminary results from the investigation of the vertebrate remains from Castagna, Sicily (site code: CA94) by Cluny Johnstone Summary This report gives preliminary results of the investigation of the vertebrate assemblage from Castagna, Sicily. As the assemblage is so small the results should be treated with due caution. The assemblage yielded little information about the occupation of the site. However, the assemblage contained an unusually high proportion of deer bones, of which three were possibly the first identifications of fallow deer (cf. Dama dama L.) remains from Roman Sicily (and one of very few from Italy as a whole). Deer hunting was perhaps a high status activity, which seems to contradict the evidence from the main domesticated species indicating (on very limited evidence)that this was a lower status producer site (i.e. farmstead). In addition, a pit fill (Context E5) contained the remains of at least 99 individual amphibians (probably toad (Bufo sp(p).) of one age group, suggesting this was a naturally formed >pit-fall trap= assemblage. Keywords: SICILY; CASTAGNA; ROMAN; 1ST - 6TH CENTURIES AD; OCCUPATION DEPOSITS; VERTEBRATE REMAINS; FALLOW DEER; RED DEER; AMPHIBIANS Author=s address: Prepared for: Palaeoecology Research Services Prof. Roger Wilson Environmental Archaeology Unit Dept. of Archaeology University of York University of Nottingham Heslington Nottingham York YO10 5DD NG7 2RD England Telephone: (01904) 434474 Fax: (01904) 433850 13th August 1998 Reports from the EAU, York, 97/53 Vertebrate remains from Castagna, Sicily. Preliminary results from the investigation of the vertebrate remains from Castagna, Sicily (site code: CA94) Introduction sealing the building. -

Relazione Acque Marine Costiere
SOGESID S.p.A . Alla predisposizione dell‘attività — Fase di analisi - Classificazione dello stato ecologico e dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali “ hanno collaborato con SOGESID S.p.A.: Coordinamento tecnico scientifico e stesura della relazione finale prof. Sebastiano Calvo Raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati e collaborazione alla stesura della relazione finale dott. Agostino Tomasello dott. ssa Maria Pirrotta dott. ssa Germana Di Maida Il coordinatore ringrazia per la collaborazione il dott. Antonino Scannavino e il dott. Filippo Luzzu Sogesid SpA Classificazione dello stato ecologico e dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali œ Acque marino costiere INDICE 1. PREMESSA............................................................................................................................ 5 2. SCHEDE MONOGRAFICHE DEI TRATTI COSTIERI.................................................... 10 2.1 CAPO GALLO - CAPO ZAFFERANO........................................................................ 10 2.1.1 Stato ecologico ai sensi del D. Lgs. 152/99.......................................................... 11 2.1.2 La prateria di Posidonia oceanica ....................................................................... 11 2.2 PUNTA RAISI - CAPO GALLO .................................................................................. 13 2.2.1 Stato ecologico ai sensi del D. Lgs. 152/99.......................................................... 14 2.2.2 La prateria di Posidonia oceanica ...................................................................... -

Ancient Engineers' Inventions
Ancient Engineers’ Inventions HISTORY OF MECHANISM AND MACHINE SCIENCE Vo l u m e 8 Series Editor MARCO CECCARELLI Aims and Scope of the Series This book series aims to establish a well defined forum for Monographs and Pro- ceedings on the History of Mechanism and Machine Science (MMS). The series publishes works that give an overview of the historical developments, from the earli- est times up to and including the recent past, of MMS in all its technical aspects. This technical approach is an essential characteristic of the series. By discussing technical details and formulations and even reformulating those in terms of modern formalisms the possibility is created not only to track the historical technical devel- opments but also to use past experiences in technical teaching and research today. In order to do so, the emphasis must be on technical aspects rather than a purely historical focus, although the latter has its place too. Furthermore, the series will consider the republication of out-of-print older works with English translation and comments. The book series is intended to collect technical views on historical developments of the broad field of MMS in a unique frame that can be seen in its totality as an En- cyclopaedia of the History of MMS but with the additional purpose of archiving and teaching the History of MMS. Therefore the book series is intended not only for re- searchers of the History of Engineering but also for professionals and students who are interested in obtaining a clear perspective of the past for their future technical works. -

Perspectives on Ancient Greece
SKRIFTER UTGIVNA AV SVENSKA INSTITUTET I ATHEN, 8°, 22 Acta INSTITUTI athENIENSIS REGNI SUECIAE, SERIES IN 8°, 22 Perspectives on ancient Greece Papers in celebration of the 60th anniversary of the Swedish Institute at Athens Edited by Ann-Louise Schallin STOCKHOLM 2013 FORELEGS IN GREEK CUlt • GUNNEL EKRoth • 113 GUNNEL EKRoth Forelegs in Greek cult Abstract* tinguish immortals from mortals within the 1 In Greek animal sacrifice, the victim’s body was divided ritual. between the divine and the human participants. The In this process, the back leg of the victim back leg was of particular importance, as the thigh- was of particular importance. The thighbones bones were cut out and burnt on the altar, and the (femora), meria or meroi in Greek, were among meat used as honorary gifts for both gods and men. The the parts cut out and burnt on the altar to cre- forelegs of the victims have received less attention, how- 2 ever. This paper discusses the ritual uses of forelegs in ate a fragrant smoke for the gods to enjoy. Also Greek cult by reviewing the epigraphical, osteological burnt as the god’s share was the osphys, a term and iconographical evidence, as well as orienting this which in religious contexts usually signifies the part of the body of the sacrificial victim within a wider sacrum bone and the tail, a section that is ana- mythic and ritual context. Shoulders or forelegs of sac- tomically adjacent to the back leg.3 The entire rificial animals are mentioned as perquisites for priests back leg had a role to fulfil within the cult as or religious personnel in a small group of inscriptions, well, as it could be used as an honorary offer- while recently published osteological material indicates a particular use of this part at some sanctuaries. -

PROSODIA VILLAGARSIENSIS in DUOS INDICES TRIBUTA, ET EX EA, QUAM Joannes Baptiffa Ricciolius È Soc
Informazioni su questo libro Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo. Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire. Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te. Linee guide per l’utilizzo Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate. Inoltre ti chiediamo di: + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali. -

Phoma Ficuzzae Sp
Sauteria 15, 2008 Contributions in 103-120 Honour of Volkmar WIRTH Phoma ficuzzae sp. nov. and some other lichenicolous fungi from Sicily, Italy Phoma ficuzzae sp. nov. und einige andere flechtenbewoh- nende Pilze aus Sizilien, Italien Wolfgang VON BRACKEL Key words : Phoma ficuzzae, lichenicolous fungi, Sicily, Italy. Schlagwörter: Phoma ficuzzae, lichenicole Pilze, Sizilien, Italien. Summary: During an excursion through Sicily in summer 2006 several sites of lichenological interest were investigated such as the lava boulder screes of Mount Etna as well as limestone rocks and relictic forests in the Madonie mountains. The new species Phoma ficuzzae, lichenicolous on Ramalina fraxinea, is described, and a list of 33 collected taxa is provided. New to Sicily are: Arthonia intexta, Arthonia molendoi, Cercidospora epipolytropa, In- tralichen baccisporus, Leptosphaeria ramalinae, Lichenochora obscuroides, Lichenoconium erodens, Lichenoconium lecanorae, Lichenoconium usneae, Lichenostigma cosmopolites, Muellerella ventosicola, Nectriopsis parmeliae, Phacopsis fusca, Polycoccum kerneri, Pronectria leptaleae, Pseudocercospora lichenum, Stigmidium congestum, Stigmidium neofusceliae, Stigmidium squa- mariae, Taeniolella beschiana, Telogalla olivieri, Tremella ramalinae, Vouauxio- myces ramalinae, Zwackhiomyces coepulonus. Zusammenfassung: Während einer Exkursion durch Sizilien im Sommer 2006 wurden meh- rere lichenologisch interessante Orte besucht, darunter sowohl die Lavafelder des Ät- na wie auch Kalkfelsen und reliktische Wälder in den Bergen -
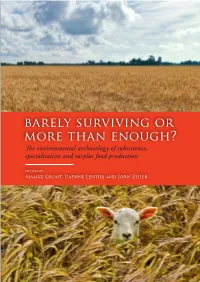
Barely Surviving Or More Than Enough?
Lentjes & Zeiler edited by Groot, barely surviving or more than enough? How people produced or acquired their food in the past is one of the main questions in archaeology. Everyone needs food to survive, so the ways in which people managed to acquire it forms the very basis of human existence. Farming barely surviving or more than enough? was key to the rise of human sedentarism. Once farming moved beyond subsistence, and regularly produced a surplus, it supported the development of specialisation, speeded up the development of socio-economic as well as social complexity, the rise of towns and the development of city states. In short, studying food production is of critical importance in understanding how societies developed. Environmental archaeology often studies the direct remains of food or food processing, and is therefore well-suited to address this topic. What is more, a barely surviving or wealth of new data has become available in this field of research in recent years. This allows synthesising research with a regional and diachronic approach. more than enough? Indeed, most of the papers in this volume offer studies on subsistence and surplus production with a wide geographical perspective. The research areas The environmental archaeology of subsistence, vary considerably, ranging from the American Mid-South to Turkey. The range specialisation and surplus food production in time periods is just as wide, from c. 7000 BC to the 16th century AD. Topics covered include foraging strategies, the combination of domestic and wild edited by food resources in the Neolithic, water supply, crop specialisation, the effect Maaike Groot, Daphne Lentjes and Jørn Zeiler of the Roman occupation on animal husbandry, town-country relationships and the monastic economy.