Marcelli-Pannuzi Layout 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Il Consumo Di Suolo Di Roma Capitale
Roma Capitale Dipartimento Trasformazione Digitale UO Statistica – Open Data Via della Greca, 5 – 00186 Roma www.comune.roma.it ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma www.isprambiente.gov.it Riproduzione autorizzata citando la fonte Curatori Michele Munafò ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale [email protected] Fabio Cesetti Roma Capitale – Dipartimento Trasformazione digitale - UO Statistica-Open Data [email protected] Autori Marialuigia De Stefano – Servizio Civile Universale Daniele Giustozzi – Servizio Civile Universale Miranda Lippolis – Servizio Civile Universale Alice Cavalli – Università degli Studi della Tuscia Supporto tecnico Alice Cavalli – Università degli Studi della Tuscia Fotointerpretazione, classificazione, produzione cartografica Marialuigia De Stefano Daniele Giustozzi Miranda Lippolis Le attività di elaborazione dei dati e di preparazione del rapporto sono state realizzate nell’ambito di un progetto sviluppato per il Servizio Civile Universale ed inserito nel Piano statistico nazionale vigente Dati e cartografia www.isprambiente.gov.it www.comune.roma.it Ringraziamenti Si ringraziano per il contributo tecnico e scientifico: Roma Capitale: Mario Carbone - Dipartimento Trasformazione Digitale UO Statistica-Open Data Gino Casale – Dipartimento Trasformazione Digitale UO Statistica-Open Data Fabio Cesetti - Dipartimento Trasformazione Digitale UO Statistica-Open Data Maria Ciuffreda - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Gianluca Ferri - Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile Roma Capitale Giulio Rauco - Dipartimento Trasformazione digitale UO Statistica-Open Data Claudio Succhiarelli – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ISPRA: Luca Congedo Chiara Giuliani Ines Marinosci La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. -

Roma Strategia Di Resilienza
MA Roma Strategia di Resilienza Roma Strategia di Resilienza PREFAZIONE Roma è stata selezionata nel dicembre del 2013 tra il primo gruppo di 32 città per far parte della rete di città 100RC. II progetto “100 Resilient Cities” (100 Città Resilienti), avviato da Rockefeller Foundation (100RC), si prefigge di aiutare le città di tutto il mondo a diventare più resilienti di fronte alle sfide ambientali, sociali ed economiche in rapida evoluzione nel XXI secolo. Il Programma promuove la resilienza delle città attraverso la nomina di un Chief Resilience Officer (CRO), la creazione di una Strategia di Resilienza e la condivisione delle conoscenze e di casi studio, tramite la rete globale di città 100RC e l’accesso ad una piattaforma di partner. 100RC affronta il tema della resilienza con un approccio olistico che coinvolge una vasta gamma di soggetti interessati e consente alle città di costruire la propria capacità di adattamento e miglioramento preparandosi al crescente numero di shock e stress cronici cui sono sottoposte (eventi traumatici come terremoti, inondazioni, epidemie ecc. ed eventi stressanti che indeboliscono il tessuto di una città). Roma ha iniziato questo percorso il 4 dicembre 2013. Dopo una prima fase di analisi, è stata pubblicata la “Valutazione Preliminare di Resilienza” nella quale sono elencati e descritti i punti di forza e di debolezza, gli shock e gli stress nonché le azioni in essere della città. La Strategia è il risultato di una stretta collaborazione tra l’Amministrazione Capitolina, 100 Resilient Cities e i loro partner strategici. Durante l’esecuzione dei lavori sono stati individuati e coinvolti numerosi stakeholder interni ed esterni all’Amministrazione Capitolina. -
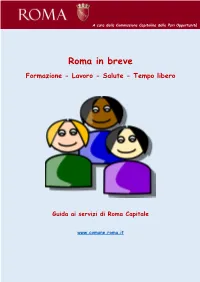
Opuscolo Roma in Breve.Pdf
A cura della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità Roma in breve Formazione - Lavoro - Salute - Tempo libero Guida ai servizi di Roma Capitale www.comune.roma.it A cura della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità INDICE Introduzione 3 Servizi di Roma Capitale. Iniziamo dal sito 4 Iscrizione anagrafica 5 o Gli uffici anagrafici nei Municipi 5 Punti Roma Facile 6 o Sedi Punti Roma Facile 6 Centri di Formazione Professionale - CFP 9 Scuole d’Arte e Mestieri 10 Centri per l’Istruzione e la formazione degli Adulti 11 Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro 12 o Sedi C.O.L. 12 La tua salute è importante 13 Farmacie Comunali 14 o Elenco delle farmacie comunali 14 o Elenco dei presidi sociali e punti RECUP Lazio 15 Persone fragili e con disabilità 16 Salute al femminile 16 o Consultori a Roma 17 Violenza e maltrattamenti 18 o Lo sai che la legge italiana è dalla tua parte? 18 Se sei vittima di abusi chiedi aiuto! Come? 19 o Centri Anti Violenza – CAV 19 Sistema Bibliotecario 22 Sistema Museale 25 Impianti Sportivi Comunali 26 Centri Sportivi Municipali 26 Luoghi di culto a Roma 27 Consulte 28 Numeri utili 29 Siti utili 29 Elenco uffici postali nel Comune di Roma 30 2 A cura della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità Introduzione L’opuscolo “Roma in breve. Formazione, Lavoro, Salute e Tempo libero - Guida ai Servizi di Roma Capitale” vuole essere un vademecum per i cittadini che hanno bisogno di informazioni su quanto l’Amministrazione Capitolina mette a disposizione per le necessità degli stessi, su alcuni servizî essenziali presenti sul territorio e su quanto può essere utile nella quotidianità, fornendo per questo anche una guida alla navigazione sul sito di Roma Capitale. -

Struttura Proponente - Municipio Roma X - C.F
Struttura Proponente - Municipio Roma X - C.F. 02438750586 Pubblicazione Tabelle Riassuntive dei dati di scelta del Contraente Periodo 1.1.2020 / 31.12.2020 Importo Importo Somme Cig Struttura proponente Oggetto Scelta Contraente Partecipanti Aggiudicatario Data Inizio Data Fine Aggiudicazione Liquidate 5179833569 02438750586 ROMA CAPITALE - MUNICIPIO ROMA X M.O.E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STELLA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE • 10679771005 LA.E.STRA SRL • 11107941004 EDILIZIA E RESTAURI SRL 86.200,00 0 DEL MARE VIA MAR DEI CARAIBI 28 - GLI EUCALIPTI VIA CAPO • 11107941004 EDILIZIA E RESTAURI SRL D'ARMI, 80 - PESCE MAGICO VIA GHERARDI, 39 - ADEGUAMENTO • 10109021005 MAMI SRL E POTENZIAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI FONDI DIP.TO XI • 06031990580 RESINE INDUSTRIALI SRL • 08938701003 D'ANNUNZIO LUCIANO 5538834668 02438750586 ROMA CAPITALE - MUNICIPIO ROMA X M.O. STRADE PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA ZONA B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO • 00704490580 VARUSA STRADE SRL • 00704490580 VARUSA STRADE SRL 0 0 ENTROTERRA -ANNO 2014 - PERIODO 01/01/2014 - 28/02/2014 51868514D9 02438750586 ROMA CAPITALE - MUNICIPIO ROMA X M.O. E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GLI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE • 04677370589 EDILCIEFFE SRL • 03639410582 I.C.E.S.A. SRL 0 0 EUCALIPTI VIA CAPO D'ARMI,80 - FONDI DIP.TO XI • 01050321007 GER SRL • 08360221009 I.C.E.R. 2005 SRL • 03639410582 I.C.E.S.A. SRL • 11461611003 PETRUCCI MARIANO SRL Z070A83813 02438750586 ROMA CAPITALE - MUNICIPIO ROMA X INTERVENTI MANUTENTIVI E ADEGUAMENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO • 01188761008 EDIL METAL SRL • 01188761008 EDIL METAL SRL 372.908,95 0 NORMATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI F.O. 2013 DIP.TO S.E.E.S. -

Lista Dei Centri Di Aggregazione Di Roma Capitale
Lista dei Centri di aggregazione di Roma Capitale Municipio I "Una mano per..." Centro diurno per adolescenti Ente gestore: CIOFS FP LAZIO (centro italiano opere femminili salesiane) Indirizzo: via Ginori, 10 Contatti: Tel. 06.5783433 - 345.1347230 email: [email protected] - [email protected] Centro di aggregazione preadolescenti e adolescenti MaTeMu' Ente gestore: CiES ong Indirizzo: via Vittorio Amedeo II, 14 Contatti: Tel. 06.77070411 - 06.77264611 email: [email protected] Centro polivalente giovani Ente gestore: Associazione Culturale di volontariato S.S.C.M. Indirizzo: via Boezio, 1c Contatti: Tel. Fax 06.68392163 email: [email protected] Municipio II Progettare con l'adolescenza La Bottega delle Idee Ente gestore: Pegaso Cooperativa Sociale Integrata Indirizzo: via dei Campani, 77 Contatti: Tel. 06.4957871 - 06.6273654 email: [email protected] Municipio III Centro Diurno Spazio Adolescenti ... alla scoperta del mondo Ente gestore: ANSEA Associazione Nazionale Sport Educazione Ambientale Indirizzo: via Francesco Cocco Ortu, 22 Contatti: Tel. 06.89766106 - 06.8108249 email: [email protected] Municipio IV Area Agio - La casa dei ragazzi e delle ragazze Ente gestore: UISP Comitato di Roma Indirizzo: via dell'Acqua Marcia, 51 Contatti: Tel. 06.5758395 - 340.8212353 email: [email protected] Frequenza200 San Basilio Ente gestore: Cemea del mezzogiorno Indirizzo: Via Pergola 21, Plesso scuola Gandhi Contatti: Tel. 06.27800248 Municipio V Centro 6 Spazio No Stop giovani - Centro Diurno Polivalente per Minori Ente gestore: Ruotalibera soc. coop. sociale ONLUS Indirizzo: via Albona (angolo via Buie d'Istria) Contatti: Tel. 06.21800754 - 06.25393527; Tel./Fax 06.27801063 email: [email protected] Centro aggregazione adolescenti Ente gestore: Antropos Associazione Indirizzo: Viale Giorgio Morandi, 98 Contatti: Tel. -

Iprincipali Indicatori Di Fabbisogno Per Municipio A
Dipartimento Trasformazione Digitale U.O. Statistica - Open Data I PRINCIPALI INDICATORI DI FABBISOGNO PER MUNICIPIO A ROMA CAPITALE Anno 2016 Dipartimento Trasformazione Digitale U.O. Statistica - Open Data Indice Fabbisogno di servizi sociali .............................................................................................................. 4 I campi d’indagine ........................................................................................................................... 4 Gli asili nido ..................................................................................................................................... 4 Famiglie e minori ............................................................................................................................. 5 Anziani ............................................................................................................................................. 6 Disagio sociale ed emarginazione ................................................................................................... 8 Pubblicato nel mese di dicembre 2018 I principali indicatori di fabbisogno per municipio a Roma Capitale Pag. 2 Dipartimento Trasformazione Digitale U.O. Statistica - Open Data I numeri più significativi VI, VII I municipi con più alto fabbisogno di asili nido Il valore dell’Indice di Disagio Sociale nel Municipio VI, il più alto calcolato rispetto alla 4,96 media di Roma (pari a 0) 161.913 Stima degli over 65 residenti a Roma con reddito sotto gli 11.000€ 125.577 Stima -

Rapporto Sullo Stato Di Salute Della Popolazione a Roma E Nel Lazio
STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE A ROMA E NEL LAZIO Aggiornamento dati al 31/12/2014 Maggio 2016 Indice Premessa ............................................................................................................ 5 Parte A – Mortalità ............................................................................................. 6 Metodi .......................................................................................................................... 6 Fonte dei dati .............................................................................................................6 Misure epidemiologiche ................................................................................................6 Risultati ........................................................................................................................ 6 Tutte le cause ............................................................................................................9 Malattie infettive e parassitarie ................................................................................... 15 Tubercolosi .............................................................................................................. 20 Tumori maligni ......................................................................................................... 22 Tumori maligni dell'esofago ........................................................................................ 27 Tumori maligni dello stomaco .................................................................................... -

Diapositiva 1
Assessorato Trasformazione Urbana Deliberazione della Giunta Capitolina del 24/04/2014 n. 115 Approvazione dell’Invito pubblico alla manifestazione d’Interesse per la formulazione di proposte di interventi privati finalizzata alla redazione dei Programmi Preliminari relativi agli Ambiti per i Programmi Integrati contenenti i Tessuti per attività della Città da ristrutturare. Assessorato Trasformazione Urbana Ambiti per i Programmi integrati PRG approvato con Del. C.C. n. 18/2008 PRINT prevalentemente per Attività Mun / Ex Mun Numero Denominazione Tipologia Città Superfice territoriale (ha) II / Ex II IIa1 Acqua Acetosa attività da ristrutturare 5,29 III / Ex IV IVa1 Villa Ada attività da ristrutturare 35,05 III / Ex IV IVa2 Salario attività da ristrutturare 27,11 III / Ex IV IVa3 Castel Giubileo attività da ristrutturare 21,24 III / Ex IV IVa4 Settebagni attività da ristrutturare 46,32 III / Ex IV IVa5 Ficarone attività da ristrutturare 56,55 III / Ex IV IVa6 S. Colomba attività da ristrutturare 65,76 III / Ex IV IVa8 Città del Mobile attività da ristrutturare 35,15 III / Ex IV IVa9 Cesarina Nuova attività da ristrutturare 16,28 III / Ex IV IVa10 Bufalotta - Marcigliana attività da ristrutturare 5,73 III / Ex IV IVa11 Casal Boccone attività da ristrutturare 3,04 IV / Ex V Va4 Tor Cervara attività da ristrutturare 73,61 IV / Ex V Va5 Tiburtino - Quarto S. Eusebio attività da ristrutturare 133,01 IV / Ex V Va6 Casal Monastero attività da ristrutturare 19,79 IV / Ex V Va7 S. Eusebio - Salone attività da ristrutturare 291,39 IV / Ex V Va8 -

Territorio E Climatologia
CAP.1 Territorio e climatologia Annuario statistico 2019 Cap.1 Territorio e climatologia Indice Analisi sintetica dei dati .............................................................................................................................. 3 Fig.1.1 - Territorio del comune di Roma Capitale con le principali vie di accesso e i limiti dei municipi.......... 5 Tab.1.1 - Coordinate geografiche ................................................................................................................. 6 Fig.1.2 - Estensione dei Municipi. ................................................................................................................. 6 Tab.1.2 - Superficie, popolazione, densità della popolazione per municipio al 31 dicembre 2018 ....................... 7 Graf.1.1 - Densità della popolazione per municipio al 31 dicembre 2018 ........................................................... 7 Tab.1.3 - Superficie, popolazione e densità della popolazione per suddivisioni toponomastiche al 31/12/2018 ... 8 Tab.1.4 - Superficie, popolazione e densità della popolazione per zona urbanistica al 31/12/2018 ..............10 Tab.1.5 - Verde urbano, aree naturali protette e parchi agricoli nei grandi comuni (m2). Anno 2018 ...........15 Tab.1.6 - Superficie Agricola Totale (SAT) nei grandi comuni (m2). Anno 2010 .............................................15 Graf.1.2 - Tipologie di Aree Naturali Protette comprese nel territorio di Roma Capitale. Composizione % ...16 Tab.1.7 - Aree Naturali Protette comprese nel territorio di -

Gruppo Di Lavoro ASL Roma 3
Gruppo di Lavoro Componenti del Gruppo: Dott.ssa Maria Letizia Eleuteri ASL ROMA 3 Dott. Filippo Muscolo Dott. Oliviero Mascarucci Dott.ssa Milena Cuccu Dott.ssa Giuseppina Poliandri Relazione a cura Dott.ssa Giovanna de Bellis Dott.ssa Maria Rita Noviello Dott.ssa Daniela Sgroi Dott.ssa Raffaella Scoyni Dott. Marcelli Pili Dott.ssa Marina Germano Coordinatore Francesco Sciscione Il contesto dell’Azienda • La ASL Roma 3 si estende dal centro della città di Roma ad ovest verso il mare e comprende 3 Distretti del Comune di Roma (corrispondenti ai Municipi X, XI e XII) ed il Distretto del Comune di Fiumicino per un’estensione complessiva di 517 Kmq. al 31/12/2020 la popolazione totale residente nei 3 Municipi e nel Comune di Fiumicino è pari al 609.450 (Maschi: 298.194, Femmine: 319.256) • Le caratteristiche demografiche della popolazione residente sono piuttosto disomogenee, in quanto la Roma 3 include sia aree urbane, caratterizzate da una popolazione in rapido invecchiamento come i Distretti Sanitari Municipio XI e Municipio XII, sia aree periferiche con un ritmo di crescita demografico più “giovane”, come il Distretto Sanitario Comune di Fiumicino e il Distretto Sanitario Municipio X. La popolazione residente nei Distretti è così distribuita: 1. Comune di Fiumicino è pari a 80.470 abitanti (ab.); 2. Municipio X è pari a 231.854 ab.; 3. Municipio XI è pari a 175.714 ab.; 4. Municipio XII è pari a 141.412 ab. Popolazione e demografia ASL ROMA 3 INDICI DEMOGRAFICI ASL ROMA 3 - 2020 155,1 33,4 54,9 INDICE INDICE INDICE VECCHIAIA DIPENDENZA -

Stemma Di Roma
Stemma di Roma «Questa signoria [dei Consoli] portò col vessillo dell'aquila S.P.Q.R. le quali lettere così dicono: Senatus PopulusQue Romanus cioè il Senato et Popolo Romano; et queste lettere erano d'oro in campo rosso. L'oro è giallo et appropriato al Sole che dà lume, prudentia et signoria a ciascuno che col suo valore cerca aggrandire. Il rosso è dato da Marte il quale essendo il dio della battaglia, a chi francamente lo segue porge vittoria et maggioranza» (Bernardino Corio, Le Vite degl'Imperatori Incominciando da Giulio Cesare fino à Federico Barbarossa, …) Blasonatura Lo stemma è stato approvato con decreto del 26 agosto 1927. La blasonatura ufficiale è la seguente: «Scudo di forma appuntato di rosso alla croce bizantina posta in capo a destra, seguita dalle lettere maiuscole S.P.Q.R. poste in banda e scalinate, il tutto d'oro.» La Bandiera LAZIO Regione Lazio mod. 1995 in uso Bandiera approntata nel 1995 e mai resa ufficiale, copia fedele del gonfalone adottato insieme allo stemma con legge regionale del 17 settembre 1984 (emendata l'8 gennaio 1986). Il modello originario aveva, come il gonfalone, un bordo blu scuro e la scritta "Regione Lazio" su due righe. La bandiera effettivamente in uso non ha il bordo e la scritta è su una sola linea. L'emblema, di forma ottagonale, reca i colori nazionali e gli stemmi delle cinque province laziali: al centro Roma, in alto Frosinone e Latina, in basso Rieti e Viterbo. Ai lati dell'ottagono, spighe di grano e un ramo di quercia, in alto una corona molto peculiare ROMA Bandiera di Roma, rosso porpora e giallo ocra, colori di antica origine bizantina, con o senza stemma. -

Le Risorse Economiche E Del Lavoro
CAP. 2 LE RISORSE ECONOMICHE E DEL LAVORO Città Metropolitana di Roma Capitale - Direzione Generale - Servizio 1- Ufficio metropolitano di Statistica Roma Capitale – Ragioneria Generale - I Direzione - Ufficio di Statistica Indice 2.1 Il sistema locale delle imprese .......................................................................................... 89 2.1.1 La base delle imprese in Italia e nelle città metropolitane ................................................ 89 2.1.2 Lo stock e la dinamica delle imprese nell’area metropolitana romana ............................. 107 2.1.3 Lo stock e la dinamica delle imprese a Roma Capitale e nei Municipi ............................... 113 2.1.4 L’imprenditorialità degli stranieri ....................................................................................... 123 2.1.5 L’imprenditorialità femminile ............................................................................................ 129 2.1.6 La struttura settoriale delle imprese nell’area metropolitana romana ............................. 136 2.1.7 La distribuzione territoriale delle imprese nei macroambiti metropolitani ...................... 138 2.2 La struttura del sistema distributivo commerciale ............................................................. 152 2.2.1 Il commercio al dettaglio nell’area metropolitana romana ............................................... 152 2.2.2 - Il commercio al dettaglio nei comuni dell’hinterland metropolitano .............................. 157 2.2.3 - La grande distribuzione nell’area