Guar Ne Ria Ni
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Justinianic Plague's Origins and Consequences
The Justinianic plague’s origins and consequences Georgiana Bianca Constantin1, Ionuţ Căluian2 1Faculty of Medicine and Pharmacy, Dunarea de Jos University Galati, Romania 2Valahia University Targoviste, Romania Corresponding author: Georgiana Bianca Constantin Abstract The bubonic plague is an extremely old disease (apparentely from the late Neolitic era). The so-called “Justinianic plague”of the sixth century was the first well-attested outbreak of bubonic plague in the history of the Mediterranean world. It was thought that the Justinianic Plague, along with barbarian invasions, contributed directly to the so-called “Fall of the Roman Empire.” Keywords: plague, pandemics, history Introduction The bubonic plague is an extremely old disease, and scientists have detected the DNA of the pathogen that causes it—the bacterium Yersinia pestis—in the remains of late Neolithic era [1]. The limited details in historical texts have led scholars to question whether the causative agent of Justinianic Plague was truly Yersinia pestis, a debate that was only resolved recently through ancient DNA analysis [2-4]. Three major plague epidemics have been recorded worldwide so far: the “Justinian” plague in the 6th century, the “Black Death” in the 14th century and the recent 20th century pandemic [5]. The plague first hit cities in the southeastern Mediterranean, and moved swiftly through the Levant to the imperial capital of Constantinople. It seems that the plague arrived in Constantinople in 542 CE and the outbreak continued to sweep throughout the Mediterranean world for another 225 years, finally disappearing in 750 CE [1,6]. It is difficult to approximate the overall mortality rate due to the 542 plague, because of the lack of demographical data. -
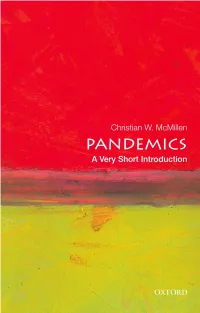
Pandemics: a Very Short Introduction VERY SHORT INTRODUCTIONS Are for Anyone Wanting a Stimulating and Accessible Way Into a New Subject
Pandemics: A Very Short Introduction VERY SHORT INTRODUCTIONS are for anyone wanting a stimulating and accessible way into a new subject. They are written by experts, and have been translated into more than 40 different languages. The series began in 1995, and now covers a wide variety of topics in every discipline. The VSI library now contains over 450 volumes—a Very Short Introduction to everything from Indian philosophy to psychology and American history and relativity—and continues to grow in every subject area. Very Short Introductions available now: ACCOUNTING Christopher Nobes ANAESTHESIA Aidan O’Donnell ADOLESCENCE Peter K. Smith ANARCHISM Colin Ward ADVERTISING Winston Fletcher ANCIENT ASSYRIA Karen Radner AFRICAN AMERICAN RELIGION ANCIENT EGYPT Ian Shaw Eddie S. Glaude Jr ANCIENT EGYPTIAN ART AND AFRICAN HISTORY John Parker and ARCHITECTURE Christina Riggs Richard Rathbone ANCIENT GREECE Paul Cartledge AFRICAN RELIGIONS Jacob K. Olupona THE ANCIENT NEAR EAST AGNOSTICISM Robin Le Poidevin Amanda H. Podany AGRICULTURE Paul Brassley and ANCIENT PHILOSOPHY Julia Annas Richard Soffe ANCIENT WARFARE ALEXANDER THE GREAT Harry Sidebottom Hugh Bowden ANGELS David Albert Jones ALGEBRA Peter M. Higgins ANGLICANISM Mark Chapman AMERICAN HISTORY Paul S. Boyer THE ANGLO-SAXON AGE AMERICAN IMMIGRATION John Blair David A. Gerber THE ANIMAL KINGDOM AMERICAN LEGAL HISTORY Peter Holland G. Edward White ANIMAL RIGHTS David DeGrazia AMERICAN POLITICAL HISTORY THE ANTARCTIC Klaus Dodds Donald Critchlow ANTISEMITISM Steven Beller AMERICAN POLITICAL PARTIES ANXIETY Daniel Freeman and AND ELECTIONS L. Sandy Maisel Jason Freeman AMERICAN POLITICS THE APOCRYPHAL GOSPELS Richard M. Valelly Paul Foster THE AMERICAN PRESIDENCY ARCHAEOLOGY Paul Bahn Charles O. -

Life and Afterlife of the First Plague Pandemic
1 Life and Afterlife of the First Plague Pandemic Lester K. Little In the summer of 541 AD a deadly infectious disease broke out in the Egyptian port city of Pelusium, located on the eastern edge of the Nile delta. It quickly spread eastward along the coast to Gaza and westward to Alexandria. By the following spring it had found its way to Constantino- ple, capital of the Roman Empire. Syria, Anatolia, Greece, Italy, Gaul, Iberia, and North Africa: none of the lands bordering the Mediterranean escaped it. Here and there, it followed river valleys or overland routes and thus penetrated far into the interior, reaching, for example, as far east as Persia or as far north, after another sea-crossing, as the British Isles.1 The disease remained virulent in these lands for slighty more than two centuries, although it never settled anywhere for long. Instead, it came and went, and as is frequently the case with unwelcome visitors, its appearances were unannounced. Overall, there was not a decade in the course of those two centuries when it was not inflicting death somewhere in the Mediterranean region. In those places where it appeared several times, the intervals between recurrences ranged from about six to twenty years. And then, in the middle of the eighth century, it vanished with as little ceremony as when it first arrived.2 Thus did bubonic plague make its first appearance on the world his- torical scene. Diagnosis of historical illnesses on the basis of descriptions in ancient texts can rarely be made with compelling certainty because all infectious diseases involve fever and the other symptoms tend not to be exclusive to particular diseases. -

Pandemics in Historical Perspective: a Bibliography for Evaluating the Impacts of Diseases Past and Present by Hannah Johnston, NYAM Library Volunteer June 2020
Pandemics in Historical Perspective: A Bibliography for Evaluating the Impacts of Diseases Past and Present by Hannah Johnston, NYAM Library Volunteer June 2020 Over the course of only a few months, the COVID-19 pandemic has radically changed the way people live their lives and relate to the world around them. For many, quarantining at home or practicing social distancing on a wide scale are new experiences; however, this is far from the first time that the global spread of disease has had large and lasting impacts on the world. Pandemics and epidemics throughout history — the bubonic plague in 1347, influenza in 1918, HIV/AIDS in the late 20th-early 21st centuries, and many others — have repeatedly reshaped the ways people think, love, and go about their daily lives. Below is an annotated bibliography of journal articles published between 2000 and 2020 that examine various pandemic or epidemic events from a historical perspective. This bibliography, while not exhaustive, should serve as a resource for beginning to consider how epidemic disease has changed the world in the past, and beginning to reckon with COVID-19’s impact on the future. 1 Abeysinghe, Sudeepa. "When the Spread of Disease Becomes a Global Event: The Classification of Pandemics." Social Studies of Science 43, no. 6 (2013): 905-26. Evaluates the WHO's Pandemic Alert Phases as used in the 2009 H1N1 pandemic. Alexander, Ryan M. "The Spanish Flu and the Sanitary Dictatorship: Mexico’s Response to the 1918 Influenza Pandemic." The Americas 76, no. 3 (2019): 443-465. Examining Mexico's response to the pandemic and that response's effect on the Mexican government and people. -

3 | 2020 Anno Xviii
Tabaccologia 3-2015 | xxxxxxxxxxxxxxxxx 1 3 | 2020 ANNO XVIII Organo Uffciale della Società Italiana di Tabaccologia-SITAB Offcial Journal of the Italian Society of Tobaccology www.tabaccologia.it Tabaccologia Poste italiane SPA Spedizione in Tobaccology Abbonamento Postale 70%-LO/BG Lo strano caso dei prodotti a tabacco riscaldato in Italia Quel tabacco che non si fuma Digital Health e Smoking Cessation Come modifcare l’edifcio del fumatore? OSA e fumo Ruolo del paziente e del medico di medicina generale nel percorso di smoking cessation Infezione da SARS-CoV-2 e nicotina Revisione sistematica della letteratura La regolamentazione ambigua delle sigarette elettroniche in Italia Trimestrale a carattere scientifco per lo studio del tabacco, del tabagismo e delle patologie fumo-correlate Quarterly scientifc journal for the study of tobacco, tobacco use and tobacco-related diseases Tabaccologia - v2.pdf 1 09/12/20 09:35 CONGRESSO NAZIONALE DELLA XXII PNEUMOLOGIA ITALIANA XLVI LA SALUTE RESPIRATORIA: LE RISPOSTE DELLA PNEUMOLOGIA DEL 21° SECOLO DI FRONTE AI NUOVI SCENARI AMBIENTALI, TECNOLOGICI C ED ORGANIZZATIVI M Y CM Endorsement MY CY CMY K UN TEAM PREZIOSO PER IL SUCCESSO WWW.PNEUMOLOGIA2021.IT DI QUALITA’ 6-9 Novembre 2021 - Milano, MiCo Dal 2004Via al servizio Antonio della da Recanate, Pneumologia 2 | 20124 Italian aMILANO Tel. +39 aiposegreteria@aiporicer02 36590350 | Fax +39 c02he.it 66790405 [email protected] Un modo nuovo di comunicare in Sanità La soluzione mirata ed efficace a supporto del Cliente in seguici -

The Plague That Never Left: Restoring the Second Pandemic to Ottoman and Turkish History in the Time of COVID-19
176 The plague that never left: restoring the Second Pandemic to Ottoman and Turkish history in the time of COVID-19 Nükhet Varlık NEW PERSPECTIVES ON TURKEY We are now in the midst of the most significant pandemic in living memory. At the time of writing in August 2020, COVID-19 has resulted in more than 23 million confirmed cases and over 800,000 deaths globally, and continues to have a serious impact in all aspects of life. For the majority of the world’s living population, this is the first time they have experienced a full-blown pandemic of this scale. The influenza pandemics of the second half of the twentieth cen- tury, such as the “Asian flu” of 1957–8 or the “Hong Kong flu” of 1968–9, which caused over a million deaths each, are seemingly comparable examples; but they can only be remembered by those aged 65 and older, which is less than 10 percent of the world’s population.1 For everyone else, the current scale of the COVID-19 pandemic is far beyond anything they have seen or experi- enced during their lifetime. In the absence of knowledge drawn from comparable experience, all eyes are now turned to historical pandemics. Over the last few months, the history of pandemics – a topic that otherwise receives interest from a small group of enthusiasts and specialists – has quickly come to the attention of an anxious public in search of answers. It seems difficult to judge whether the interest of the public stems from a desire to draw practical lessons from the past, or per- haps from a need to seek comfort in the idea that pandemics like this (or per- haps even worse ones) occurred in the past. -

The Justinianic Plague: an Inconsequential Pandemic?
The Justinianic Plague: An inconsequential pandemic? Lee Mordechaia,b,1, Merle Eisenberga,c, Timothy P. Newfieldd,e, Adam Izdebskif,g, Janet E. Kayh, and Hendrik Poinari,j,k,l aNational Socio-Environmental Synthesis Center, Annapolis, MD 21401; bHistory Department, Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus, 9190501 Jerusalem, Israel; cHistory Department, Princeton University, Princeton, NJ 08544; dHistory Department, Georgetown University, NW, Washington, DC 20057; eBiology Department, Georgetown University, NW, Washington, DC 20057; fPaleo-Science & History Independent Research Group, Max Planck Institute for the Science of Human History, 07745 Jena, Germany; gInstitute of History, Jagiellonian University, 31-007 Kraków, Poland; hSociety of Fellows in the Liberal Arts, Princeton University, Princeton, NJ 08544; iDepartment of Anthropology, McMaster University, Hamilton, ON L8S 4L9, Canada; jDepartment of Biochemistry, McMaster University, Hamilton, ON L8S 4L9, Canada; kMcMaster Ancient DNA Centre, McMaster University, Hamilton, ON L8S 4L9, Canada; and lMichael G. DeGroote Institute for Infectious Disease Research, McMaster University, Hamilton, ON L8S 4L9, Canada Edited by Noel Lenski, Yale University, New Haven, CT, and accepted by Editorial Board Member Elsa M. Redmond October 7, 2019 (received for review March 4, 2019) Existing mortality estimates assert that the Justinianic Plague tiquity (e.g., refs. 5 and 6). Yet this narrative overlooks the fact (circa 541 to 750 CE) caused tens of millions of deaths throughout that the political structures of the Western Empire had already the Mediterranean world and Europe, helping to end antiquity collapsed in the 5th century and the Eastern Empire did not de- and start the Middle Ages. In this article, we argue that this cline politically until the 7th century (18, 19). -

Lessons Learned from Historic Plague Epidemics
a ise ses & D P s r u e o v ti e Journal of Infectious Diseases & c n Boire et al., J Anc Dis Prev Rem 2013, 2:2 e t f i v n I DOI: 10.4172/2329-8731.1000114 e f M o e l d a i n ISSN: 2329-8731 Preventive Medicine c r i u n o e J Review Article Open Access Lessons Learned from Historic Plague Epidemics: The Relevance of an Ancient Disease in Modern Times Nicholas A Boire1*, Victoria Avery A Riedel2, Nicole M Parrish1 and Stefan Riedel1,3 1The Johns Hopkins University, School of Medicine, Department of Pathology, Division of Microbiology, Baltimore, Maryland, USA 2The Bryn Mawr School, Baltimore, Maryland, USA 3Johns Hopkins Bayview Medical Center, Department of Pathology, Baltimore, Maryland, USA Abstract Plague has been without doubt one of the most important and devastating epidemic diseases of mankind. During the past decade, this disease has received much attention because of its potential use as an agent of biowarfare and bioterrorism. However, while it is easy to forget its importance in the 21st century and view the disease only as a historic curiosity, relegating it to the sidelines of infectious diseases, plague is clearly an important and re-emerging infectious disease. In today’s world, it is easy to focus on its potential use as a bioweapon, however, one must also consider that there is still much to learn about the pathogenicity and enzoonotic transmission cycles connected to the natural occurrence of this disease. Plague is still an important, naturally occurring disease as it was 1,000 years ago. -

Conflicts and the Spread of Plagues in Pre-Industrial Europe
ARTICLE https://doi.org/10.1057/s41599-020-00661-1 OPEN Conflicts and the spread of plagues in pre-industrial Europe ✉ David Kaniewski1 & Nick Marriner2 One of the most devastating environmental consequences of war is the disruption of peacetime human–microbe relationships, leading to outbreaks of infectious diseases. Indir- ectly, conflicts also have severe health consequences due to population displacements, with a fl 1234567890():,; heightened risk of disease transmission. While previous research suggests that con icts may have accentuated historical epidemics, this relationship has never been quantified. Here, we use annually resolved data to probe the link between climate, human behavior (i.e. conflicts), and the spread of plague epidemics in pre-industrial Europe (AD 1347–1840). We find that AD 1450–1670 was a particularly violent period of Europe’s history, characterized by a mean twofold increase in conflicts. This period was concurrent with steep upsurges in plague outbreaks. Cooler climate conditions during the Little Ice Age further weakened afflicted groups, making European populations less resistant to pathogens, through malnutrition and deteriorating living/sanitary conditions. Our analysis demonstrates that warfare provided a backdrop for significant microbial opportunity in pre-industrial Europe. 1 Laboratoire Ecologie fonctionnelle et Environnement, Université de Toulouse, CNRS, INP, UPS, Toulouse cedex 9, France. 2 CNRS, ThéMA, Université de ✉ Franche-Comté, UMR 6049, MSHE Ledoux, 32 rue Mégevand, 25030 Besançon Cedex, France. email: [email protected] HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES COMMUNICATIONS | (2020) 7:162 | https://doi.org/10.1057/s41599-020-00661-1 1 ARTICLE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES COMMUNICATIONS | https://doi.org/10.1057/s41599-020-00661-1 Introduction istorians, scientists, and wider society have generally paid Results Hlittle attention to bygone epidemics, with the marked Plague outbreaks. -
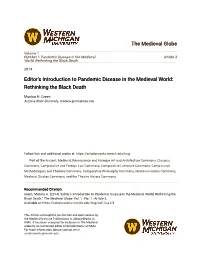
Editor's Introduction to Pandemic Disease in the Medieval World: Rethinking the Black Death
The Medieval Globe Volume 1 Number 1 Pandemic Disease in the Medieval Article 3 World: Rethinking the Black Death 2014 Editor's Introduction to Pandemic Disease in the Medieval World: Rethinking the Black Death Monica H. Green Arizona State University, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.wmich.edu/tmg Part of the Ancient, Medieval, Renaissance and Baroque Art and Architecture Commons, Classics Commons, Comparative and Foreign Law Commons, Comparative Literature Commons, Comparative Methodologies and Theories Commons, Comparative Philosophy Commons, Medieval History Commons, Medieval Studies Commons, and the Theatre History Commons Recommended Citation Green, Monica H. (2014) "Editor's Introduction to Pandemic Disease in the Medieval World: Rethinking the Black Death," The Medieval Globe: Vol. 1 : No. 1 , Article 3. Available at: https://scholarworks.wmich.edu/tmg/vol1/iss1/3 This Article is brought to you for free and open access by the Medieval Institute Publications at ScholarWorks at WMU. It has been accepted for inclusion in The Medieval Globe by an authorized editor of ScholarWorks at WMU. For more information, please contact wmu- [email protected]. THE MEDIEVAL GLOBE Volume 1 | 2014 INAUGURAL DOUBLE ISSUE PANDEMIC DISEASE IN THE MEDIEVAL WORLD RETHINKING THE BLACK DEATH Edited by MONICA H. GREEN Immediate Open Access publication of this special issue was made possible by the generous support of the World History Center at the University of Pittsburgh. Copyeditor Shannon Cunningham Editorial Assistant PageAnn Hubert design and typesetting Martine Maguire-Weltecke Library of Congress Cataloging in Publication Data ©A catalog2014 Arc record Medieval for this Press, book Kalamazoois available from and Bradfordthe Library of Congress This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Licence. -

A Genomic and Historical Synthesis of Plague in 18Th Century Eurasia
A genomic and historical synthesis of plague in 18th century Eurasia Meriam Guellila,b,1, Oliver Kerstena, Amine Namouchia,c, Stefania Lucianid, Isolina Marotad, Caroline A. Arcinie, Elisabeth Iregrenf, Robert A. Lindemanng, Gunnar Warfvingeh, Lela Bakanidzei, Lia Bitadzej, Mauro Rubinik,l, Paola Zaiok, Monica Zaiok, Damiano Nerik, N. C. Stensetha,1, and Barbara Bramantia,b,m,1 aCentre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Department of Biosciences, University of Oslo, 0316 Oslo, Norway; bInstitute of Genomics, University of Tartu, 51010 Tartu, Estonia; cCentre for Integrative Genetics, Department of Animal and Aquacultural Sciences, Norwegian University of Life Sciences, 1430 Ås, Norway; dLaboratory of Molecular Archaeo-Anthropology/ancientDNA, School of Biosciences and Veterinary Medicine, University of Camerino, 62032 Camerino, Italy; eArkeologerna, National Historical Museums, SE-226 60 Lund, Sweden; fDepartment of Archaeology and Ancient History, Lund University, SE-221 00, Lund, Sweden; gSchool of Dentistry, University of California Los Angeles, CA 90024; hFaculty of Odontology, Malmö University, SE-205 06 Malmö, Sweden; iNational Center for Disease Control and Public Health, 0198 Tbilisi, Georgia; jAnthropological Studies of the Institute of History and Ethnology, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 0177 Tbilisi, Georgia; kAnthropological Service of Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti (Lazio), Ministry of Cultural Heritage and Activities, 00192 Rome, Italy; lDepartment of Archaeology, University of Foggia, 71122 Foggia, Italy; and mDepartment of Biomedical and Specialty Surgical Sciences, Faculty of Medicine, Pharmacy and Prevention, University of Ferrara, 44121 Ferrara, Italy Contributed by N. C. Stenseth, September 2, 2020 (sent for review May 29, 2020; reviewed by Guido Alfani and Ludovic Orlando) Plague continued to afflict Europe for more than five centuries genomes from this period. -

The Third Plague Pandemic and British India: a Transformation of Science, Policy, and Indian Society
Tenor of Our Times Volume 10 Article 18 Spring 4-29-2021 The Third Plague Pandemic and British India: A Transformation of Science, Policy, and Indian Society Rebecca L. Burrows Harding University, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.harding.edu/tenor Part of the Asian History Commons, Diseases Commons, European History Commons, History of Science, Technology, and Medicine Commons, Medical Humanities Commons, and the Public Health Commons Recommended Citation Burrows, Rebecca L. (Spring 2021) "The Third Plague Pandemic and British India: A Transformation of Science, Policy, and Indian Society," Tenor of Our Times: Vol. 10, Article 18. Available at: https://scholarworks.harding.edu/tenor/vol10/iss1/18 This Article is brought to you for free and open access by the College of Arts & Humanities at Scholar Works at Harding. It has been accepted for inclusion in Tenor of Our Times by an authorized editor of Scholar Works at Harding. For more information, please contact [email protected]. Rebecca L. Burrows graduated in the Spring of 2020 with a History and Medical Humanities double major. While at Harding, she served as the President of Phi Alpha Theta, Vice President of Chi Omega Pi social club, and the Anatomy and Physiology II Teacher’s Assistant. She plans to pursue her master’s, and hopefully doctoral, degree in history. 125 Doctor tending to a patient in Karachi, 1897 126 THE THIRD PLAGUE PANDEMIC AND BRITISH INDIA: A TRANSFORMATION OF SCIENCE, POLICY, AND INDIAN SOCIETY By Rebecca L. Burrows Cholera, malaria, influenza, and now COVID-19 all have cast fear and panic into the hearts of mankind.