Diagnosi Territoriale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Deliberazioni Di G.M. Anno 2015
Deliberazioni di G.M. anno 2015 N. Data Oggetto 1 08.01.2015 Anticipazione somma Economato – 1° trimestre 2015 2 12.01.2015 Rinnovo assicurazione automezzi comunali (responsabilità civile e copertura infortuni conducenti) – Anno 2015 – Autorizzazione a contrattare e assegnazione risorse al Segretario Comunale 3 12.01.2015 Assegnazione risorse al dirigente del 2° settore per la fornitura di abbonamenti per i mesi Gennaio/maggio 2015. 4 19.01.2015 Prosecuzione lavori socialmente utili, bacino a carico del fondo sociale per l’occupazione e formazione – bimestre Gennaio/Febbraio 2015 5 19.01.2015 Assegnazione somme al dirigente 4° settore per servizio di Igiene Ambientale – anno 2015 - 6 19.01.2015 Assegnazione risorse al dirigente del 4° settore tecnico per intervento di manutenzione straordinaria per installazione nuove caldaie autonome e relativa tubazione nell’edificio comunale di Piazza . Fedele – Piano 1° e 2° 7 21.01.2015 Concessione contributo alla Direzione Didattica “G.G.Sinopoli” per l’anno solare 2015. Prenotazione di spesa e assegnazione risorse al dirigente del 2° settore 8 21.01.2015 Proroga contratti LSU prioritari ex L.R. 85/95 a tempo parziale a 24 ore settimanali – anno 2015 – ai sensi dell’art. 4 L.R. 2/2015 9 28.01.2015 Progetto esecutivo per il Piano di investigazione iniziale della discarica dismessa di r.s.u. sita in C.da Scardiulli – Agira – Approvazione amministrativa. 10 28.01.2015 Approvazione schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche relative al triennio 2015/2017 11 28.01.2015 Cantieri di servizio anno -

Riepilogo Periodo
Riepilogo periodo: 31/12/2020 - 29/04/2021 Giorni effettivi di vaccinazione Comune di Gagliano Castelferrato (EN) Prot. N.0004568 del 04-05-2021 arrivo Cat14 Cl.1 Fascicolo 113 / Periodo selezionato Centro vaccinale Riepilogo delle vaccinazioni effettuate 31/12/2020 29/04/2021 Tutte Somministrazioni e Totali per Data Vaccinazione e Tipo Vaccino Somministrazioni cumulate per data vaccinazione e proiezione a 10 gg Tipo Vaccino ASTRAZENECA MODERNA PFIZER Totali 70K 1.400 60K 1.200 ate 50K 1.000 ul um c oni i 40K oni az 800 i tr az s tr ni i s 30K m ni 600 i m om S om 20K 400 S 200 10K 0 0K gen 2021 feb 2021 mar 2021 apr 2021 gen 2021 feb 2021 mar 2021 apr 2021 mag 2021 Data Vaccinazione Data Vaccinazione Dosi somministrate % per Vaccino Dosi 1 2 Dose 1 2 Totale Vaccino Somministra % Somministra % Somministra % 3,6K (6,7%) 9,02K zioni zioni zioni (16,79%) ASTRAZENECA 8999 16,76% 17 0,03% 9016 16,79% MODERNA 2225 4,14% 1375 2,56% 3600 6,70% Vaccino 68,22% 31,78% PFIZER 25412 47,32% 15671 29,18% 41083 76,51% PFIZER Comune di Gagliano Castelferrato (EN) Prot. N.0004568 del 04-05-2021 arrivo Cat14 Cl.1 Fascicolo ASTRAZENECA Totale 36636 68,22% 17063 31,78% 53699 100,00% MODERNA 53699 475,21 41,08K (76,51%) 0% 50% 100% Totale somministrazioni Media giornaliera Somministrazioni / Periodo selezionato Centro vaccinazione Somministrazioni per centro di 31/12/2020 29/04/2021 vaccinazione Tutte Somministrazioni per centro vaccinale Somministrazioni per centro vaccinale 2,3K Vaccino ASTRAZENECA MODERNA PFIZER Totale 2,4K (4,46%) (4,28%) Città 1 2 Totale -

Modalità Di Espressione Del Voto Nelle Elezioni Amministrative in Sicilia
Erma, data del protocollo AI SIGG. SINDACI AI SIGG. SEGRETARI COMUNALI AI SIGG. UFFICIALI ELETTORALI DEI COMUNI DI AGIRA, CENTURIPE, ENNA, NICOSIA, PIETRAPERZIA E VALGUARNERA CAROPEPE LORO SEDI OGGETTO: Elezioni amministrative 2020. Modalità di espressione del voto nelle elezioni amministrative in Sicilia. ********* I - Premessa In tema di espressione di voto, alla luce delle modifiche normative succedutesi e recentemente introdotte, la Regione Siciliana - Assessorato Delle Autonomie Locali e Della Funzione Pubblica - con nota prot. n. 9209 del 31 agosto 2020, ha emanato la presente direttiva volta ai Presidenti degli Uffici di sezione affinchè gli stessi possano correttamente illustrare agli elettori le diverse modalità ed opzioni di espressione di voto, per l'elezione del sindaco e/o dei consiglieri comunali. Infatti, la legge regionale n. 6 del 5 aprile 2011, pubblicata nella G.U.R.S. n. 16 dell'11 aprile 2011, recante "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali" e la legge regionale n. 8 del 10-04- 2013, pubblicata nella G.U.R.S. n. 18 del 12 aprile 2013, recante "Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere", hanno introdotto alcune sostanziali modifiche al sistema elettorale riguardanti le modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco, la rappresentanza di genere, l'attribuzione del premio di maggioranza, l'elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente, la rappresentanza e la doppia preferenza di genere, elementi tutti che hanno inciso, in particolare, sulla manifestazione di voto. Alcune delle principali disposizioni normative testé richiamate, sono rivolte a promuovere direttamente la parità tra generi nell'accesso alla cariche elettive comunali, incidendo sulla materia attribuita alla competenza statale, ai sensi dell'ari. -

Prefettura Di Enna Ufficio Territoriale Del Governo
Prefettura di Enna Ufficio territoriale del Governo ELENCO FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (Art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) Sezione 10 SERVIZI AMBIENTALI, COMPRESE LE ATTIVITA' DI RACCOLTA, DI TRASPORTO NAZIONALE E TRANSFRONTALIERO, ANCHE PER CONTO DI TERZI, DI TRATTAMENTO E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, NONCHE' LE ATTIVITA' DI RISANAMNETO E DI BONIFICA E GLI ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI RAGIONE SEDE CODICE FISCALE DATA DI DATA SCADENZA NOTE SOCIALE LEGALE / PARTITA IVA ISCRIZIONE ISCRIZIONE 6 C M S.R.L. NICOSIA (EN) - VIA MAMMAFIGLIA N. 1 01186040869 13/02/2019 29/03/2022 ALEO GIUSEPPE CLAUDIO & C. S.N.C. BARRAFRANCA (EN) - VIA MASTROBUONO N. 15 00563470863 07/10/2015 16/11/2021 ALF SERVICES DI OTTIMO FABIO ENNA - STRADA COMUNALE S.C.49S.CATERINA VOLTA PALUMBO 181 D 01258530862 05/06/2020 04/06/2021 AN.SA. S.R.L. REGALBUTO (EN) - CONTRADA MANCHE SAVARINO SN 00672560869 22/08/2016 16/03/2022 ARENA MOVIMENTO TERRA S.R.L. ENNA - STRADA COMUNALE 193 BARRESI-BERARDI 799 01282350865 08/01/2021 07/01/2022 ASARESI S.N.C. DI ASARESI SALVATORE E C. BARRAFRANCA (EN) - VIA F.P. DI BLASI N. 21 00520600867 31/03/2021 30/03/2022 ATTARDI ANTONIO TROINA (EN) - VIA SOLLIMA N. 98 00372000869 09/02/2021 08/02/2022 ATTARDI GROUP S.R.L. TROINA (EN) - VIA SOLLIMA N. 98 01036560868 07/08/2018 29/03/2022 ATTARDI PAOLO ENNA - CONTRADA POLLICARINI SNC 01252270861 20/11/2018 03/03/2021 AUTOTRASPORTI C/TERZI DI ALLEGRO LUIGI & C. -
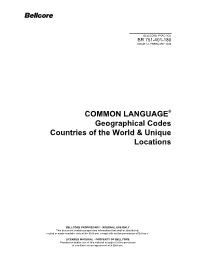
Geographical Codes Countries of the World & Unique Locations
BELLCORE PRACTICE BR 751-401-180 ISSUE 16, FEBRUARY 1999 COMMON LANGUAGE® Geographical Codes Countries of the World & Unique Locations BELLCORE PROPRIETARY - INTERNAL USE ONLY This document contains proprietary information that shall be distributed, routed or made available only within Bellcore, except with written permission of Bellcore. LICENSED MATERIAL - PROPERTY OF BELLCORE Possession and/or use of this material is subject to the provisions of a written license agreement with Bellcore. Geographical Codes Countries of the World & Unique Locations BR 751-401-180 Copyright Page Issue 16, February 1999 Prepared for Bellcore by: R. Keller For further information, please contact: R. Keller (732) 699-5330 To obtain copies of this document, Regional Company/BCC personnel should contact their company’s document coordinator; Bellcore personnel should call (732) 699-5802. Copyright 1999 Bellcore. All rights reserved. Project funding year: 1999. BELLCORE PROPRIETARY - INTERNAL USE ONLY See proprietary restrictions on title page. ii LICENSED MATERIAL - PROPERTY OF BELLCORE BR 751-401-180 Geographical Codes Countries of the World & Unique Locations Issue 16, February 1999 Trademark Acknowledgements Trademark Acknowledgements COMMON LANGUAGE is a registered trademark and CLLI is a trademark of Bellcore. BELLCORE PROPRIETARY - INTERNAL USE ONLY See proprietary restrictions on title page. LICENSED MATERIAL - PROPERTY OF BELLCORE iii Geographical Codes Countries of the World & Unique Locations BR 751-401-180 Trademark Acknowledgements Issue 16, February 1999 BELLCORE PROPRIETARY - INTERNAL USE ONLY See proprietary restrictions on title page. iv LICENSED MATERIAL - PROPERTY OF BELLCORE BR 751-401-180 Geographical Codes Countries of the World & Unique Locations Issue 16, February 1999 Table of Contents COMMON LANGUAGE Geographic Codes Countries of the World & Unique Locations Table of Contents 1. -

Rischio Idrogeologico Indice
Provincia Regionale di Enna – Piano Provinciale di Protezione Civile – Rischio Idrogeologico Indice INDICE PARTE GENERALE Premessa …………………………………. Pag. 2 Riferimenti Normativi …………………………………. Pag. 3 Acquisizione dei dati – Elenco Elaborati …………………………………. pag. 4 Classificazione degli eventi …………………………………. pag. 5 Struttura provinciale di Protezione Civile …………………………………. pag. 5 ASSETTO DEL TERRITORIO PROVINCIALE Generalità …………………………………. pag. 7 Geologia – Litologia – Geomorfologia …………………………………. pag. 7 Climatologia …………………………………. pag. 17 Dati sui comuni …………………………………. pag. 22 Viabilità Provinciale …………………………………. pag. 23 Bacini Idrografici – Idrografia …………………………………. pag. 25 Dighe …………………………………. pag. 29 Riserve Naturali Protette …………………………………. pag. 30 SCENARIO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO Dissesti Geomorfologici ed Idraulici …………………………………. pag. 32 Indicatori di Evento …………………………………. pag. 35 Dighe ed attraversamenti …………………………………. pag. 47 Zone di allerta …………………………………. pag. 48 LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE Gruppo di Coordinamento Provinciale …………………………………. pag. 49 C.C.S. (Centri Coordinamento Soccorsi) …………………………………. pag. 50 C. O. M. (Centri Operativi Misti) …………………………………. pag. 51 Elenco delle Risorse …………………………………. pag. 56 Strutture Sanitarie …………………………………. pag. 58 Associazioni di Volontariato …………………………………. pag. 60 Vie di Fuga …………………………………. pag. 64 Aree di Emergenza …………………………………. pag. 78 Presidi Territoriali Operativi …………………………………. pag. 79 Acronimi …………………………………. pag. 80 - 1 - Provincia Regionale di Enna – Piano Provinciale di Protezione -

Page 1 SMOW2B 20-06-08PAG. 1
SMOW2B 20-06-08PAG. 1 ********************************************************************************** * SI-13-SM-PDO2B * * * * SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE * * * * * * SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO * * * * * * UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA * * * * * * UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : ENNA * * * * * * ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO * * * * * * ANNO SCOLASTICO 2008/2009 * * * * * * ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON * * CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA * * COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I * * CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' * * PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. * * * * * ********************************************************************************** SMOW2B 20-06-08PAG. 2 POSTI DI SOSTEGNO PER MINORATI PSICO-FISICI ***** TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE 1. CENTAMORE SANDRO . 23/ 3/61 (EN) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. UDITO) DA : ENMM808018 - L. CAPUANA ( PIAZZA ARMERINA ) A : ENMM808018 - L. CAPUANA ( PIAZZA ARMERINA ) PRECEDENZA: UFF. NELLA SCUOLA SU ALTRA TIP. SOSTEGNO PUNTI 200 2. TRIMARCHI LOREDANA . 11/ 7/64 (EN) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : ENMM002009 - SMS G.PASCOLI ( ENNA ) A : ENMM00100D - G.GARIBALDI ( ENNA ) PUNTI 127 ***** TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA 1. BUSCEMA ROSARIO . 5/10/52 (RG) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : ENMM108005 - VERGA - DON MILANI ( BARRAFRANCA ) A : ENMM107009 - N. SAVARESE ( ENNA ) PUNTI 254 2. CENSABELLA CRISTINA . 3/10/72 (NU) DA : ENMM804011 - " V. DE SIMONE " ( VILLAROSA ) A : ENMM109001 - DANTE ALIGHIERI ( LEONFORTE ) DA CLASSE DI CONCORSO 43/A ITALIANO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA PUNTI 75 3. DI MARIO PAOLA . 5/12/69 (EN) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : ENMM80601L - E.FERMI ( CATENANUOVA ) A : ENMM002009 - SMS G.PASCOLI ( ENNA ) PUNTI 96 SMOW2B 20-06-08PAG. -

Comune Di Valguarnera Caropepe Provincia Di ENNA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Comune di Valguarnera Caropepe Provincia di ENNA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE VERBALE N. 8 OPERAZIONE DI NOMINA DEGLI SCRUTATORI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI EVENTUALI SOSTITUTI. VOTAZIONI DEL GIORNO 24-02-2013, Nell'Ufficio municipale, addì QUATTRO FEBBRAIO DUEMILATREDICI, alle ore 16:00, regolarmente convocata, si è riunita in convocazione la Commissione elettorale comunale,' nelle persone dei signori: COMPONENTI Presente Assente LEANZA SEBASTIANO SINDACO PRESIDENTE X SALVATORE ALFONSO TROVATO COMPONENTE EFFETTIVO X CARMELINA CUTRONA COMPONENTE. EFFETTIVO X GRECO FILIPPA COMPONENTE SUPPLENTE X Assistita, con funzioni di segretario da DR. ALFREDO VERSO SEGRETARIO COMUNALE. Riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art.14 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto. LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE Visto l'ari. 4-bis, del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n.223. Visto che il giorno 10-01-2013, con decreto sono stati convocati i comizi elettorali. Visto I'art.6 della legge 8 marzo 1989, n.95 e successive modificazioni (art. 9 della legge n.270/2005), che detta nuove norme per la nomina degli scrutatori; Dato atto che il Sindaco, in data 01/02/2013 , ha disposto la pubblicazione, all'albo pretorio di questo Comune, del manifesto preannunziante la presente riunione; Visto che a cura dell'ufficio di segreteria, e' stato messo a disposizione di questa Commissione il materiale necessario per dare corso alle operazioni di nomina; Visto che il corpo elettorale di questo comune e-' suddiviso in complessive n. -
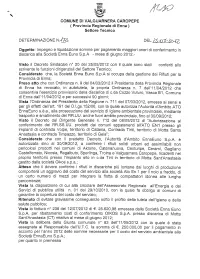
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE Settore Tecnico
vi V COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE ( Provincia Regionale di Enna ) Settore Tecnico DETERMINAZIONE N.Vg5> DEL Oggetto: Impegno e liquidazione somme per pagamento maggiori oneri di conferimento in discarica alla Società Enna Euno S.p.A - mese di giugno 201 2.- Visto il Decreto Sindacale n° 20 del 25/05/2012 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico; Considerato che, la Società Enna Euno S.p.A si occupa della gestione dei Rifiuti per la Provincia di Enna; Preso atto che con Ordinanza n. 9 del 04/03/2012 il Presidente della Provincia Regionale di Enna ha revocato, in autotutela, la propria Ordinanza n. 7 dell' 11/04/201 2 che consentiva l'esercizio provvisorio della discarica di c.da Cozzo Vuturo, Vasca B1, Comune di Enna dall1 11/04/20 12 e per successivi 90 giorni; Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 711 del 07/03/2012, emessa ai sensi e per gli effetti dell'ari. 191 del D.Lgs.152/06, con la quale autorizza l'Autorità d'Ambito ATO EnnaEuno s.è.a., alla prosecuzione del servizio di Igiene ambientale provinciale, mediante trasporto e smatimento dei RR.UU. anche fuori ambito provinciale, fino al 30/09/2012; Visto il Decreto del Dirigente Generale n. 712 del 08/05/2012 di "Autorizzazione al conferimento dei RR.SS.UU. prodotti dai comuni appatenenti all'ATO EN1 presso gli impianti di contrada Volpe, territorio di Catania, Contrada Tiriti, territorio di Motta Santa Anastasia e contrada Timpazzo, territorio di Gela"; Considerato che con il predetto Decreto, l'Autorità d'Ambito EnnaEuno S.p.A. -

Seventh Conference of Italian Archaeology! ! the Archaeology of Death! ! Programme! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! April 16-18, 2016! with Thanks To
Seventh Conference of Italian Archaeology! ! The Archaeology of Death! ! Programme! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! April 16-18, 2016! With thanks to College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies School of Languages, Literatures, and Cultures Discipline of Classics Discipline of Archaeology Accordia Research Institute Contents Introduction 1 Introduzione 2 General Information 3 Informazioni Generali 4 Events 7 Avvenimenti 8 Timetable 9 Programme 11 Abstracts 19 Saturday, 16 19 Sunday, 17 38 Monday, 18 61 A short guide to Galway 77 Una breve guida a Galway 78 Maps 81 List of Delegates 83 ! Introduction Welcome to the Seventh Conference of Italian Archaeology Many people and institutions have made this Conference possible. Firstly, we owe a debt of gratitude to those institutions and foundations that have assisted us with generous financial aid, these are: the Galway University Foundation; Fáilte Ireland; the College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies; the Moore Institute; the School of Languages, Literatures, and Cultures. The Accordia Research Institute provided financial support for travel bursaries to enable postgraduate and early career scholars to attend, and BAR kindly gave prizes for the best poster. Secondly, we are pleased to acknowledge the support and practical help of organisations, institutions, and colleagues who have made this Conference a reality. We thank the Italian Embassy to Ireland, the British School at Rome, and the Etruscan Foundation. Within NUI Galway, the discipline of Classics, the discipline of Archaeology, and the Conference Office have facilitated us in many ways; we salute too our student volunteers who have given so much of their time and support. We especially note the substantial efforts of Dr Kieran O’Connor, discipline of Archaeology, and to Dr Lucy Shipley, Moore Institute Visiting Fellow. -

Classe Di Concorso/Tipolo Gia Di Posto Di Destinazione
BOLLETTINO RISULTATI ELABORATI DAL SISTEMA (CON PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO : 2020/21 DATA: 29/06/2020 PROVINCIA: ENNA CLASSE DI PROVINCIA PROVINCIA DISTRETTO TIPOLOGIA DI CONCORSO/TIPOLO CODICE DATA DI DISTRETTO DI ORDINE SCUOLA DI CLASSI DI CONCORSO/TIPOLOGIA COGNOME NOME DI MOVIMENTO OTTENUTO SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE COMUNE DI DESTINAZIONE PRECEDENZA PUNTEGGIO TIPO DI MOVIMENTO DI SCUOLA/PROVINCIA DI TITOLARITA' COMUNE DI TITOLARITA' DI PERSONALE PRIMA GIA DI POSTO DI FISCALE NASCITA DESTINAZIONE TITOLARITA' DI POSTO DI TITOLARITA' NASCITA TITOLARITA' TITOLARITA' DELLA MOBILITA' DESTINAZIONE AN - COMUNE ********** AMORUSO ROSA 01/02/1970 CT TRASFERIMENTO NEL COMUNE ENEE81801X - G. VERGA C480 - CERAMI 026 187,00 MOVIMENTO A DOMANDA SCUOLA PRIMARIA EN EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI ENEE81801X - G. VERGA C480 - CERAMI 026 TITOLARE SU SCUOLA AN - COMUNE ********** COMITO ROSINA 02/12/1969 EN TRASFERIMENTO NEL COMUNE ENEE824017 - S. GIOVANNI BOSCO A676 - BARRAFRANCA 027 107,00 TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA SCUOLA PRIMARIA EN AN - COMUNE ENEE82301B - EUROPA A676 - BARRAFRANCA 027 TITOLARE SU SCUOLA AN - COMUNE ********** DI GIORGIO LUANA 16/08/1979 EN TRASFERIMENTO NEL COMUNE ENEE825013 - TEATINI G580 - PIAZZA ARMERINA 027 Prevista dal C.C.N.I. 137,00 MOVIMENTO A DOMANDA SCUOLA PRIMARIA EN EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI ENEE825013 - TEATINI G580 - PIAZZA ARMERINA 027 TITOLARE SU SCUOLA AN - COMUNE ********** GIANGRASSO MARIA 07/12/1958 EN TRASFERIMENTO NEL COMUNE ENEE062013 - S. DOMENICO F892 - NICOSIA 026 130,00 MOVIMENTO A DOMANDA SCUOLA PRIMARIA EN EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI ENEE062013 - S. DOMENICO F892 - NICOSIA 026 TITOLARE SU SCUOLA AN - COMUNE ********** PUGLISI SABRINA 04/04/1974 EN TRASFERIMENTO NEL COMUNE ENEE81501C - S. -

Farmacie Della Provincia Di Enna
FARMACIE DELLA PROVINCIA DI ENNA Ragione Sociale Indirizzo Località Telefono FARMACIA CAMPAGNA DR.SSA BUTTAFUOCO ANNA MARIA VIA VITTORO EMANUELE, 144 AGIRA 0935691117 FARMACIA DR. CASTRO DOMENICO PIAZZA F. FEDELE, 20 AGIRA 0935691085 FARMACIA DR.SSA VACCARO MARIA TERESA VIA DIODOREA, 7 AGIRA 0935960766 FARMACIA DR.SSA DRAGO ROSALIA VIA G. GARIBALDI, 78 AIDONE 093588153 FARMACIA DR.SSA MESSANA LIBORIA VIA F. CORDOVA, 30 AIDONE 093586074 FARMACIA PESCO & C. S.N.C. VIA CRISA, 309 ASSORO 0935667230 FARMACIA S. GIORGIO S.A.S. VIA BACHELET, 59 - SAN GIORGIO ASSORO 0935669603 FARMACIA DR.SSA AGOZZINO ROSA CORSO G. GARIBALDI, 443 BARRAFRANCA 0934465995 FARMACIA DR. CANNADA RENATO VIA UMBERTO, 36 BARRAFRANCA 0934464067 FARMACIA EREDI MATTINA STEFANO VIA VITT. EMANUELE, 276 BARRAFRANCA 0934465779 FARMACIA NUOVA S.R.L. V.LE GENERALE CANNADA, 480 BARRAFRANCA 09341994394 FARMACIA DR. DOLCIMASCOLO SALVATORE VIA NAZIONALE, 298/T CALASCIBETTA 093534770 FARMACIA FONTANAZZA DR.SSA RUSSO MARIA CRISTINA VIA CONTE RUGGERO, 5 CALASCIBETTA 093534720 FARMACIA CENTRALE S.R.L. VIA VITT. EMANUELE, 111 CATENANUOVA 093575124 FARMACIA CACIA DR. PROSPERO NICOTRA VIA G. GARIBALDI, 24 CENTURIPE 093573162 FARMACIA GRECO S.N.C. VIA UMBERTO, 109 CENTURIPE 093573185 FARMACIA DEL DUOMO DR. ZINNA GIUSEPPE PIAZZA DUOMO, 47 CENTURIPE 093573814 FARMACIA DR. OCCHIPINTI ANTONIO CORSO ROMA, 43 CERAMI 0935931582 FARMACIA SANT'ANNA DR.SSA E. ALERCI S.A.S. VIA DELL'UNITA' D'ITALIA, 13 ENNA BASSA 093529441 FARMACIA DEL CENTRO INGRASCIOTTA VIA ANGELO TRANCHIDA, 10 ENNA 0935500650 FARMACIA PERSICO G. S.N.C. VIA CLAUDIANO, 2 - PERGUSA ENNA 0935541359 FARMACIA DR. RINALDI LUCIO GERLANDO PIAZZA V. EMANUELE, 17 ENNA 09351823239 FARMACIA DR.