Relazione Geologica-Idrogeologica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Curriculum Gianfranco Aquaro.Pdf
CURRJCULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 468 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445 Il sottoscritto Arch. Gianfranco Aquaro nato a Martina Franca (TA) il 0610311957, c.f. QRAGFR57C06E986S, e residente a Martina Franca (TA) in Corso dei Mille n. 188/A, consapevole della responsabilità penale prevista, dall'art.76 del D.P.R. 44512000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazionì mendaci ivi indicate: DICHIARA che le informazioni sotto rìoortate sono veritiere. FonuATo EURoPEo CURRICULUM VITAE | ruroRnaRztolrl PERSoNALI Nome AncH. GrRrurRANco AQunno Indirizzo CORSODEIMILLE,lSS/A Telefono +39 3356296749 - 080 4807203 E-mail [email protected] Codice Fiscate eRAGFRS7C06E9865 Partita IVA 00937950731 AlbodegliarchitettidiTaranto n"185 Nazionalità ltaliana Data di nascita 06 - 03 - 1957 EsprrurruzR LAVORATIVA IN AMBITO PUBBLICO NEGLIULTIMI 20 NruruI '1996 (Verbale consiglio parrocchiale del31/01/1996, delibera G.M. diMartina tntervento su beni culturall FranCa n' 48 del 11211996) Committente: Parrocchia San Martino in Martina Franca - Mons. Franco Semeraro. Redattore, con altro professionista, del progetto di massima degli interventi per il restauro della Collegiata di San Martino nel Comune di Martina Franca per un importo complessivo di e. 4.850.000.000, finanziato con fondi P.O.P. comunitari per un importo die. 3.256.000.000. 1996 Committente: Comune di Martina Franca tntervento su beni cutturatl Redattore, in collaborazione con i professionisti incaricati Arch. Vito Carlo Fedele e Dott. Agr. Nicola Melucci, del progetto esecutivo per la sistemazione di strade rurali nell'agro del Comune di Martina Franca per un importo comolessivo di [. 2.1 17.000.000. non finanziato. -

ELENCO STRADE DELLA PROVINCIA DI TARANTO Lungh
Ex580 S.P. n° 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 18 16 15 14 12 23 22 21 20 19 17 13 11 10 8 7 6 5 1 9 4 3 2 Abbracciavento/ LAVORI DI TRINCIATURA DELL’ERBA, DEI ROVI E DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA VEGETAZIONE DEI ROVI E DELLA DELL’ERBA, LAVORI DI TRINCIATURA Massafra Massafra Massafra Massafra Palagiano - Massafra Palagiano - Massafra Mottola- Massafra Palagiano Mottola Mottola - Mottola Palagianello Mottola Palagianello Mottola Castelaneta Laterza Laterza - Castellaneta Laterza - Castellaneta Castelaneta Castelaneta - Ginosa Castellaneta Ginosa - Ginosa Laterza Ginosa Ginosa - Ginosa Laterza Castelaneta Laterza - Castellaneta Castelaneta Laterza laterza Laterza Castelaneta - Ginosa Castellaneta Ginosa Ginosa Ginosa Ginosa Ginosa Martina Martina Martina Martina Martina Martina Martina Martina Statte Statte Statte Crispiano Crispiano Massafra Massafra Statte- Massafra- Martina Massafra Massafra Palagiano - Elenco SS.PP.zona3.xls SU BANCHINE E PERTINENZE STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI STRADE DELLE STRADALI E PERTINENZE BANCHINE SU Agro - aggiornamento: - ELENCO STRADE DELLA PROVINCIA DITARANTO STRADEDELLAPROVINCIA ELENCO Zona Boscata (PUTT) Zona Boscata (PUTT) Zona Boscata (PUTT) Zona Boscata (PUTT) Zona Boscata (PUTT) Zona Boscata (PUTT) Zona Boscata (PUTT) Zona Boscata (PUTT) Zona Boscata (PUTT) Zona Boscata (PUTT) Zona Boscata (PUTT) Zona Boscata (PUTT) Zona Boscata Zona Boscata Zona Boscata (PUTT) Zona Boscata (PUTT) Zona interna Zona interna Zona interna Zona interna -
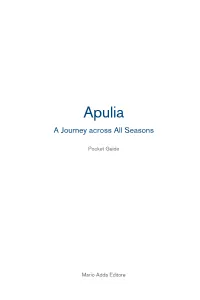
Apulia a Journey Across All Seasons
Apulia A Journey across All Seasons Pocket Guide Mario Adda Editore Regione Puglia AreA Politiche Per lA Promozione del territorio, dei sAPeri e dei tAlenti Servizio Turismo – Corso Sonnino, 177 – cap 70121 Bari Tel. +39 080.5404765 – Fax +39 080.5404721 e-mail: [email protected] www.viaggiareinpuglia.it Text: Stefania Mola Translation: Christina Jenkner Photographs: Nicola Amato and Sergio Leonardi Drawings: Saverio Romito Layout: Vincenzo Valerio ISBN 9788880829362 © Copyright 2011 Mario Adda Editore via Tanzi, 59 - Bari Tel. e fax +39 080 5539502 www.addaeditore.it [email protected] Contents A Journey across All Seasons ....................................................pag. 7 A History ............................................................................................ 9 Buried Treasures ....................................................................................... 11 Taranto’s Treasure ........................................................................ 12 Egnazia ....................................................................................... 12 The Bronzes of Brindisi ............................................................... 13 The Vases of Ruvo ....................................................................... 13 Between Legend and Reality on the Hill of Cannae ....................... 14 Ostuni – Pre-Classical Civilizations ............................................... 14 Caves and Prayers ....................................................................... -

Spizzico, M. and R. Tinelli
HYDROGEOLOGY OF GALESE SPRING. MAR PICCOLO OF TARANTO (SOUTH ITALY) M.Spizzico Istituto di Geologia Applicata e Geotecnica, Bari, Italy R. Tinelli Istituto di Geologia Applicata e Geotecnica, Bari, Italy Abstract The basin of the Mar Piccolo represents one of the areas of greatest hydrogeological interest in the region of Apulia. Situated between two large hydrogeological units (Murge and Salento), the basin is character~ zed by the presence of numerous submarine and subaerial springs (locally known as "citri"). This paper first outlines the structural features of the area examined and it is pointed out that tectonic phenomena have played a major role in the hydrogeological evolution of the zone and also in conditioning the flow-paths of the underground waters into the sea. The second part of the paper is particularly concerned with the Galese spring which, with a discharge of 500 1/s, represents the largest sub aerial spring in the Mar piccolo basin. The surveys carried out, as well as defining the hydrogeological and chemical parameters of the spring, have highlighted the hydrodynamic and hydrochemical influence exerted by the sea on the karstic groundwater and also its influence on the evolution of phenomena of marine intrusion. Lastly, the connections that have emerged between the Galese spring and the Galese "citro" have proved to be of particular interest. 35 1 Introduction The present work is part of a wider programme of research that has been carried out by our Institute over the past few years on one of the most interesting hydrogeological areas in Apulia: the basin of the Mar Picco lo of Taranto ( Cotecchia 1955-56, 1977 ; Tadolini and Zanframundo, 1975; Tadolini et al. -

Organico Docenti A.S
Diocesi di Castellaneta UFFICIO EDUCAZIONE SCUOLA UNIVERSITÀ Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica ORGANICO DOCENTI A.S. 2020-2021 N. INSEGNANTE ISTITUTO ORDINE COMUNE DI SCOLASTICO GRADO INSEGNAMENTO 1 CASAMASSIMA RODARI SECONDARIA I PALAGIANO SALVATORE 2 MARANGI EINSTEIN SECONDARIA II MOTTOLA ORAZIO 3 D’ELIA FLACCO SECONDARIA II CASTELLANETA FILIPPO 4 PAVONE GIOVANNI XXIII PRIMARIA PALAGIANO ROBERTO 5 CAMPOBASSO DELEDDA SECONDARIA I GINOSA CELESTE BOSCO 6 CLEMENTE G.B. VICO SECONDARIA II LATERZA PIETRO 7 RESTA DE AMICIS PRIMARIA MASSAFRA ANITA MANZONI 8 LENGE SURICO PRIMARIA CASTELLANETA CHIARA 9 LIPPOLIS MANZONI PRIMARIA MOTTOLA MARIA LIVIA GIOVANNI XXIII PALAGIANO 10 CATUCCI LEONE PRIMARIA MARINA DI GINOSA MARIA LUIGIA 11 MERCANTE CALO’ PRIMARIA GINOSA FLAVIA 12 PERRONE MARCONI PRIMARIA LATERZA LUCIANA MICHELANGELO 13 PANICO DELEDDA PRIMARIA GINOSA MARIA DIAZ PRIMARIA LATERZA 14 POLIGNANO CALO’ PRIMARIA GINOSA VINCENZO 15 MASTROMARINO S. G. BOSCO INFANZIA MOTTOLA CARMELA MANZONI 16 TURI MARIA PASCOLI PRIMARIA MASSAFRA ROSARIA ANDRIA 17 PIZZULLI RODARI PRIMARIA PALAGIANO NICOLA 18 DE FLORIO PASCOLI INFANZIA MASSAFRA ANTONIA ANDRIA 19 PIZZULLI CALO’ INFANZIA GINOSA ANNA DELEDDA 20 MARINUZZI DE AMICIS PRIMARIA MASSAFRA MARIA MANZONI 21 ABRUSCI PASCOLI PRIMARIA CASTELLANETA ANNAMARIA 20 LAMOLA RODARI INFANZIA PALAGIANO VITO GIOVANNI XXIII 21 ANTONICELLI MARCONI INFANZIA PALAGIANELLO GRAZIA 22 PARISI CALO’ INFANZIA GINOSA CONCETTA 23 FORTI S. G. BOSCO INFANZIA MASSAFRA GUERRINO 24 SURDO SURICO SECONDARIA I – II CASTELLANETA ROSANNA EINSTEIN MOTTOLA 25 PACENTE LEONE INFANZIA MARINA G. GIULIA 26 MIANULLI DE AMICIS INFANZIA MASSAFRA ALESSANDRA MANZONI 27 BONELLI CALÒ SECONDARIA I – II GINOSA MARIA CARMELA DE RUGGIERI MASSAFRA 28 BUFANO DIAZ SECONDARIA I LATERZA GIUSEPPE MARC. -

Mottola – Palagiano – Statte Avviso Pubblico Per
AMBITO TERRITORIALE N.2 ASL TA COMUNI DI: MASSAFRA – MOTTOLA – PALAGIANO – STATTE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO Allegato 2) LOTTO N. 1: MASSAFRA UTENTI CENTRO ALZHEIMER ART. 60 TER, ubicato a Massafra, Via Nocera n. 3 Nr.utenti INDIRIZZO 1 Via Settembrini,113 A 2 Via Scuro,16 3 Via Napoli, 7b 4 Via Trieste, 1l 5 Via V.Veneto, 86 6 Via Trieste,75 7 Via Follerio,9 8 Corso Regina Margherita, 45 9 Via Lamarmora UTENTI CENTRO DIURNO ART. 60 ubicato a Massafra, Viale Marconi 158 1 Via Imbriani 40 2 Via Bolzano 36 3 Via MATTEO PAGLIARI 181 4 Via Cialdini 29 5 Via Livatino 12 6 Via Commenda 12 7 Via Tagliamento 5 8 Via Gianlorenzo Bernini 81/A 9 Via G. Pascoli 35 10 Burrone San Marco 9 11 Via G.Enzo D'erasmo 6 12 Vico Ii Fumarola 2 13 Via Anita Garibaldi 11 14 Via Gualtiero Da Massafra 8 15 Via Colonnello Scarano 77 16 Via Trieste 1l 17 Via Mons.Iacopo Micheli 78 18 Via Confalonieri 90 19 Via Aosta, 8 LOTTO N. 2: MOTTOLA UTENTI CENTRO ALZHEIMER ART. 60 TER ubicato a Massafra, Via Nocera n. 3 1 Via Matucci, 22 UTENTI CENTRO DIURNO ART. 60 ubicato a Mottola Piazza XX Settembre sn.c. 1 Contrada Catanese 5/A 2 C.Da Matine Sn 3 Via Scudello 24 4 Arc. Catucci 41 5 Via Albania 38 6 Via A. De Gasperi 22 7 Via Sicilia 22 8 Via C. Battisti 16 9 Via Goldoni\ 15 10 Via Palagianello 159 11 Via Lucania 4 12 Contrada Difesa Vigne S.N. -

European Commission
C 356/10 EN Offi cial Jour nal of the European Union 21.10.2019 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an application for registration of a name pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2019/C 356/09) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1) within three months from the date of this publication. SINGLE DOCUMENT ‘MOZZARELLA DI GIOIA DEL COLLE’ EU No: PDO-IT-02384 — 29.12.2017 PDO ( X ) PGI ( ) 1. Name(s) ‘Mozzarella di Gioia del Colle’ 2. Member State or Third Country Italy 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.3. Cheeses 3.2. Description of the product to which the name in (1) applies ‘Mozzarella di Gioia del Colle’ is a fresh stretched-curd cheese made with whole cow’s milk only and a whey starter culture. It is characterised by: a) The following chemical composition (values for fresh cheese): lactose ≤ 0,6 %, lactic acid ≥ 0,20 %, moisture 58-65 %, fat 15-21 % on a wet basis. b) A taste reminiscent of slightly soured milk, with a pleasant after-taste of fermentation or sour whey (stronger in freshly made cheese) and a sour milky aroma, sometimes accompanied by a slight hint of butter. c) The absence of preservatives, additives and processing aids. ‘Mozzarella di Gioia del Colle’ has a smooth or slightly fibrous surface. -

Verbale N. 13 Del 30/01/2013 OGGETTO: Verbale Di Nomina Degli Scrutatori Elezioni Politiche Del 24 E 25 Febbraio 2013
Città di Martina Franca Provincia di Taranto Commissione Elettorale Comunale Verbale n. 13 del 30/01/2013 OGGETTO: Verbale di nomina degli scrutatori elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013.- (art. 6 legge 8 marzo 1989, n. 95 come sostituto dal punto 4, dell’art. 9 della legge 21/12/2005, n. 270) Nell’Ufficio Elettorale Comunale, stanze del consiglio Comunale,il giorno trenta del mese di gennaio, dell’anno duemilatredici, alle ore 16,00, regolarmente convocata, si è riunita in prima convocazione la Commissione Elettorale Comunale, nelle persone dei signori: 1. Dott. Francesco Ancona Sindaco Presidente 2. Sig. Antonio Martucci Consigliere Componente effettivo 3. Sig. Vittorio Donnici Consigliere Componente effettivo 4. Sig. Giuseppe Pulito Consigliere Componente effettivo assistita, con funzione di Segretario dal Dott. Pietro Mastrovito, delegato dal Segretario Comunale. Il Presidente , riconosciuta legale l’adunanza, ai sensi dell’art. 14 del T.U. 20 marzo 1967, n.223, invita a procedere al sorteggio per la individuazione dei soggetti da nominare scrutatori. La Commissione elettorale in pubblica adunanza Visto l’art.6, comma 1 delle lege 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal punto 4, dell’art. 9, della legge 21/12/2005, n. 270; Preso atto che in data 28 gennaio 2013 è stato affisso all’albo pretorio elettronico il manifesto preannunziante la presente pubblica adunanza; Considerato che il Comune è ripartito in n. 44 sezioni elettorali e di n. 1 seggio speciale; Preso atto che ai sensi delle vigenti disposizioni, la composizione di ogni seggio deve essere di n. 4 scrutatori, fermo restando la composizione del seggio speciale di n. -

Download the Guide
Bicycle touring This guide is dedicated to those who wish to discover Puglia slowly, throgh places and emotions that are hidden from the senses when speeding by. Ride after ride, in the shadows of age-old oaks, monu- mental olive trees, and the dense Mediterranean maquis, what is re- vealed to the eyes of a cycling tourist is a marvelous and unexpected Puglia. In twelve different itineraries, from Gargano to Salento, Puglia is recounted in a grand tour totaling two thousand kilometers, to be traveled by bicycle, but also on foot or horseback, via ancient paths and on untrafficked country roads. This guide can be used to put together itineraries for everyone’s tastes and preferences. There is no need to be experienced cyclists. Each itinerary can be subdivided into a number of stages for week-long journeys, daily excursions, or long weekends. Between one stage and the next, you can discover culinary specialties and explore museums, villages, and e cities of art, for a journey in pursuit of culture and well-being. Puglia is unique, but there is not just one Puglia. It changes its face with every season. The invitation is to discover it all - slowly. Happy trails! Tremiti Islands “It is difficult to express what one feels when San Nicola Peschici he feels as if he is running on map. We are in Rodi Garganico Vieste equilibrium on a line. And that line meant Sannicandro Foresta Garganico Cagnano Umbra Varano Pugnochiuso south and east– fabulous points of Italy – at Apricena Monte San Giovanni Sant’Angelo Rotondo the same time. -

Liste Dei Candidati Per L'elezione Diretta Alla Carica Di Sindaco E Di N. 16 Consiglieri Comunali Che Avrà Luogo Domenica 26
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE Liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di sindaco e di n. 16 consiglieri comunali che avrà luogo domenica 26 maggio 2019 (Articolo 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e articolo 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570) CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 1) DONATO PARADISO 2) GIOVANNI MASTRANGELO 3) ROBERTO CARDILLI 4) DONATO MASSIMO COLACICCO nato a Gioia del Colle (BA) il 22-07-1952 nato a Gioia del Colle (BA) l'11-06-1977 nato a Gioia del Colle l'11-08-1977 nato a Gioia del Colle (BA) il 21-04-1970 LISTE COLLEGATE LISTE COLLEGATE LISTA COLLEGATA LISTA COLLEGATA Lista N. 1 Lista N. 2 Lista N. 3 Lista N. 4 Lista N. 5 Lista N. 6 Lista N. 7 Lista N. 8 Lista N. 9 Lista N. 10 Lista N. 11 ANNA ANGELILLO FILOMENA PAVONE detta MILENA ALESSANDRO NICOLA DE ROSA GIUSEPPE GALLO CARMELA NICEFORO PAMELA CHIELLI FILIPPO SPERANZA VITO ETNA PASQUALE ROBERTO BARILE detto LILLO UBALDO BELLINO DONATO LUCILLA nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 10-10-1987 nata a Gioia del Colle (BA) il 26-01-1969 nato a Gioia del Colle (BA) il 18-03-1981 nato a Gioia del Colle (BA) il 07-12-1968 nata a Gioia del Colle (BA) il 31-08-1990 nata a Castellaneta (TA) il 20-04-1977 nato a Gioia del Colle (BA) il 08-07-1972 nato a Gioia del Colle (BA) il 30-10-1977 nato a Gioia del Colle (BA) il 20-09-1976 nato a Santeramo in Colle (BA) il 12-01-1975 nato a Gioia del -

Graduatoria Definitiva Delle Assegnazioni Provinciali - 1° Grado - Provincia Di Taranto - A.S
GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI - 1° GRADO - PROVINCIA DI TARANTO - A.S. 2019/2020 Punt. Punt. Comune di Punt Punt. Classe di Data di Precedenze ricongi altro Dati anagrafici ricongiungiment . Total Sede di titolarità Richieste Sedi assegnate Note Concorso nascita CCNI ungim Comu o figli e ento ne AD00 G. PASCOLI AD00 CAVALLO ANTONELLA 14/11/1970 *** SAVA 6 6 0 Sostegno SAN GIORGIO IONICO G. VIGESIMO III° AD00 AMATULLI FRANCESCO 19/04/1971 ** MOTTOLA 6 6 0 Sostegno PALAGIANO MICHELANGELO AD00 PRENCIPE MARIA 18/12/1978 * GINOSA 6 12 18 12 Sostegno LATERZA MARTELLOTTA AD00 INGROSSO SERENA 16/11/1979 * MANDURIA 6 8 14 8 Sostegno TARANTO LEONARDO DA VINCI AD00 SEMERARO MARGHERITA 10/07/1972 MOTTOLA 6 6 12 6 AD00 STATTE G. VIGESIMO III° AD00 GIANNINI DORITA 09/04/1976 MOTTOLA 6 6 12 6 AD00 PALAGIANO G. D'ANNUNZIO AD00 MENDACE MARGHERITA 14/04/1976 MOTTOLA 6 6 12 6 AD00 PALAGIANELLO SEVERI AD00 BRUNETTI MARIA LUISA 16/07/1970 MANDURIA 6 6 0 AD00 CRISPIANO D. ALIGHIERI AD00 CAPODIFERRO LUCIANA 06/05/1972 LATERZA 6 6 0 AD00 TARANTO MICHELANGELO AD00 DE CARLO FILOMENA 25/08/1976 MOTTOLA 6 6 0 AD00 LATERZA CASALINI AD00 MARTINA GIUSEPPE 06/06/1978 MANDURIA 6 6 0 AD00 SAN MARZANO GIOVINAZZI AD00 SANTANTONIO CRISTINA 08/04/1980 LATERZA 6 6 0 AD00 CASTELLANETA E. DE AMICIS AA25 SOLAZZO MARIA PIA 17/12/1975 * MARUGGIO 6 7 13 7 AD00 FRAGAGNANO GALILEI A022 BELLINI MARIA BEATRICE 12/01/1966 LATERZA 6 3 9 3 AD00 TARANTO PIRANDELLO A030 LACARBONARA ANGELA 07/10/1965 MARTINA FRANCA 6 6 0 AD00 TARANTO O. -

Graduatoria Provinciale Provvisoria Degli Assistenti Amministrativi a Tempo Indeterminato Per Eventuali Utilizzazioni Sui Posti Di D.S.G.A
GRADUATORIA PROVINCIALE PROVVISORIA DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO INDETERMINATO PER EVENTUALI UTILIZZAZIONI SUI POSTI DI D.S.G.A. PER L'A.S. 2020/2021 Prot. e data (fa fede il protocollo apposto in intestazione sulla comunicazione) DATA COGNOME NOME COMUNI RICHIESTI NASCITA CCNL POSTO AMM.VO AMM.VO ITI PRECEDENZE RESP. AMM.VO (CCNL 27/01/04) (CCNL ALTRE LAUREE ALTRE FUNZIONE RESPFUNZIONE ASS. AMM.VO ITI FUNZIONE DSGA FUNZIONE ANZIANITA SERVIZIOANZIANITA TOTALE PUNTEGGIO TITOLARE TITOLARE SEC. POS. SERVIZIO PRESTATO SERVIZIO PRESTATO ASPIRANTE INCLUSO INCLUSO ASPIRANTE GRAD SECONDA POS SECONDA GRAD IDONEITA' CONCORSI IDONEITA' CONCORSI SERVIZIO PRE RUOLO TITOLI TABELLA DSGA ANZIANITA SERV RESPANZIANITA MASSAFRA, PALAGIANO, MOTTOLA, MARTINA FRANCA, 1 A SEMERARO GIOVANNA 08/01/1956 10,00 0,00 0,00 156,00 41,50 0,00 30,00 0,00 146,00 0,00 383,50 CRISPIANO, CASTELLANETA, PALAGIANELLO, LATERZA, GINOSA, TARANTO 2 ARGENTINA GIOVANNI 01/08/1965 10,00 0,00 0,00 264,00 34,50 0,00 0,00 6,00 148,00 0,00 462,50 PROVINCIA TUTTA GINOSA- LATERZA- CASTELLANETA- MOTTOLA- 3 CASSANO GIACOMO 15/10/1969 0,00 0,00 0,00 228,00 33,50 0,00 0,00 0,00 80,00 32,00 373,50 PALAGIANO-PALAGIANELLO-MASSAFRA 4 TOCCI MASSIMILIANO 06/09/1972 10,00 0,00 0,00 252,00 30,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 364,00 PROVINCIA TUTTA 5 BENVENUTO CATALDO 14/06/1961 10,00 0,00 0,00 276,00 23,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 357,00 PROVINCIA TUTTA 6 TANGORRA PAOLA GRAZIA 07/09/1967 10,00 0,00 0,00 264,00 43,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 339,00 MOTTOLA 7 D'ORONZO GIUSEPPE 03/06/1965 10,00