Download (1MB)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Beni Immobili Disponibili Cat- Pd
BENI IMMOBILI DISPONIBILI CAT- PD - 1 - FABBRICATI - N. Pr. Comune Descrizione Uso principale Reddito eventuale 1 Ar Arezzo Battifolle n.122 NCEU F. 42-47-48/b M. 276-76-31 Casa cantoniera n. 6 2.908,25 2 Ar Arezzo La Lama n.49 - Loc. Marcena NCEU F. 3/a M. 80-180 Casa cantoniera n. 8 2.576,62 3 Ar Arezzo San Giuliano n..15 NCEU F. 42/b M. 6 Casa cantoniera n. 5 2.257,73 4 Ar Badia Tedalda SRT 258 - KM. 27,00 NCEU F. 58 M. 309 Casa cantoniera 5 Ar Badia Tedalda SRT 258 - KM. 27,00 NCEU F. 58 M. 309 Autorimessa 6 Ar Badia Tedalda SRT 258 - KM. 27,00 NCEU F. 58 M. 309 Magazzino 7 Ar Bibbiena Casamicciola NCEU F. 79 M. 14 Casa cantoniera n. 29 8 Ar Bibbiena Corsalone n.26 NCEU F. 88 M. 125/3 Casa cantoniera n. 26 2.973,22 9 Ar Bibbiena Corsalone n..26 NCEU F. 88 M. 125/4 Casa cantoniera n. 26 10 Ar Capolona Via Dante n.301 NCEU F. 17 M. 118 Casa Cantoniera n. 11 2.232,22 11 Ar Castel Focognano Farneto n.51 - Loc. Rassina NCEU F. 14 M. 329 Casa Cantoniera n. 22 1.760,27 12 Ar Cavriglia Loc. Castelnuovo Sabbioni NCEU F. 22 M. 153 Rudere colonia campestre 13 Ar Cavriglia Loc. Molinaccio NCEU F. 19 M. 12/1 Alloggio rurale 14 Ar Cavriglia Loc. Molinaccio NCEU F. 19 M. 12/2 Alloggio rurale 15 Ar Cavriglia Loc. Molinaccio NCEU F. -

Passion for Cycling Tourism
TUSCANY if not HERE, where? PASSION FOR CYCLING TOURISM Tuscany offers you • Unique landscapes and climate • A journey into history and art: from Etruscans to Renaissance down to the present day • An extensive network of cycle paths, unpaved and paved roads with hardly any traffic • Unforgettable cuisine, superb wines and much more ... if not HERE, where? Tuscany is the ideal place for a relaxing cycling holiday: the routes are endless, from the paved roads of Chianti to trails through the forests of the Apennines and the Apuan Alps, from the coast to the historic routes and the eco-paths in nature photo: Enrico Borgogni reserves and through the Val d’Orcia. This guide has been designed to be an excellent travel companion as you ride from one valley, bike trail or cultural site to another, sometimes using the train, all according to the experiences reported by other cyclists. But that’s not all: in the guide you will find tips on where to eat and suggestions for exploring the various areas without overlooking small gems or important sites, with the added benefit of taking advantage of special conditions reserved for the owners of this guide. Therefore, this book is suitable not only for families and those who like easy routes, but can also be helpful to those who want to plan multiple-day excursions with higher levels of difficulty or across uscanyT for longer tours The suggested itineraries are only a part of the rich cycling opportunities that make Tuscany one of the paradises for this kind of activity, and have been selected giving priority to low-traffic roads, white roads or paths always in close contact with nature, trying to reach and show some of our region’s most interesting destinations. -

Arezzo-Patovecchio-Stia.Pdf
IN CASO DI SCIOPERO O TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.p.A. TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.p.A. DI VARIAZIONI IN CASO DI SCIOPERO O DI PROGRAMMATE AL VARIAZIONI PROGRAMMATE SERVIZIO, SARANNO AL SERVIZIO, SARANNO AFFISSI OPPORTUNI AFFISSI OPPORTUNI AVVISI AI AVVISI AI VIAGGIATORI VIAGGIATORI NELLE NELLE STAZIONI E STAZIONI E FERMATE. FERMATE. ORARIO DAL 11 GIUGNO 2019 AL 14 DICEMBRE 2019 ORARIO DAL 11 GIUGNO 2019 AL 14 DICEMBRE 2019 INFORMAZIONI AL N. VERDE: INFORMAZIONI AL N. LE CORRISPONDENZE CON I TRENI DI ALTRE IMPRESE DOVRANNO VERDE: Riduzione Servizio: dal 11/6 al 15/9 LE CORRISPONDENZE CON I TRENI DI ALTRE IMPRESE Riduzione Servizio: dal 11/6 al 15/9 ESSERE VERIFICATE DAI VIAGGIATORI CONSULTANDO AL DOVRANNO ESSERE VERIFICATE DAI VIAGGIATORI MOMENTO IL RELATIVO ORARIO PUBBLICO. 800.922.984 Festivi: domenica e 15/8 - 1/11 - 8/12 CONSULTANDO AL MOMENTO IL RELATIVO ORARIO PUBBLICO. 800.922.984 Festivi: domenica e 15/8 - 1/11 - 8/12 TRENI AREZZO PRATOVECCHIO STIA TRENI PRATOVECCHIO STIA AREZZO TRENO n° 1156 1160 1162 1164 b168 1168 1170 b172 1672 6172 6174 b178 6178 1180 6182 b184 1184 b186 1186 1190 b192 1192 1194 TRENO n° 1151 1153 1155 6157 6159 b159 1159 1161 1163 b167 6167 6171 6173 b175 6175 b179 1179 6181 1183 b185 1185 b187 1187 categoria (v. note) RL RL RL RL BUS RL RL BUS RL RL RL BUS RL RL RL BUS RL BUS RL RL BUS RL RL categoria (v. note) RL RL RL RL RL BUS RL RL RL BUS RL RL RL BUS RL BUS RL RL RL BUS RL BUS RL LIMITAZIONI (v. -

Get App Autumn in Casentino
Autumn in Casentino, Tuscany To admire the more photogenic colors, savor the most authentic flavors and discover the lesser-known villages and monuments, come with us to the Casentino, the higher ground and upper valley of the Arno river. Autumn is a second spring, when every leaf is a flower (Albert Camus) CONSUMA PASS CASTEL SAN NICCOLO’ The Casentino covers a valley running roughly Castel San Niccolò is a superb example of between Florence and Siena and belongs to medieval architecture. It is scattered in numerous the province of Arezzo. For convenience, our ancient hamlets. Of particular interest is the 1 journey starts in Florence, but you can decide to 4 parish of San Martino in Vado, an start in Arezzo or in other places in Tuscany and 11th-century Romanesque church that is re-arrange the itinerary as you prefer. perfectly preserved and whose creation is owed Arriving from Florence you'll cross the Consuma to the famous Countess Matilde di Canossa. In Pass (1050 m elevation): a perfect spot for a Castel San Niccolò stop at one of the traditional autumn snack: schiacciata flat bread Prosciutto del Casentino producers and stuffed with mushrooms. taste one of the famous local cold cuts made with pigs raised outdoor. STIA In Stia, often called the "source of the Arno", POPPI although the real source is in “Capo d’Arno” Because it is strategically placed with trade routes admire Porciano Castle, the Church of St. Mary passing through it, Casentino has been a much 2 delle Grazie and the Florentine Palagio. disputed area in the past; today’s legacy includes North of Stia (at 1380 m on Monte Falterona) 5 some really outstanding castles and fortifications. -

ENOICA ROAD FRANCESCANA (5 Days – 4 Stages – Km 400 – M
“It is by riding a bicycle that you learn the contours of a country best, since you have to sweat up the hills and coast down them.” (Ernest Hemingway) “Credo che abbattendovi a uno vino che fosse secondo vostra natura, non vi bisognarebbe altro medico a ritornarvi le forze.” (Ser Lapo Mazzei, 1404) ENOICA ROAD FRANCESCANA (5 days – 4 stages – Km 400 – m. 6,800 elevation) Day 1st: arrival at Fonterutoli Participants arrive by their own means by 7:00 pm (pick-up services may be arranged, ask us for a quote) at Castello di Fonterutoli, next to Castellina in Chianti. At 8:00 pm there will be a welcome dinner prepared by the chef of Osteria di Fonterutoli paired with the world-renowned Castello di Fonterutoli wines (www.mazzei.it ). Accommodation at the Locanda di Fonterutoli in the hamlet. Airport: Florence Vespucci 80 km; Pisa Galilei 100 km; Bologna Marconi 140 km; Roma Da Vinci 280 km Day 2: stage Fonterutoli – Poppi (110 km e 2.000 m. elevation) A stage from the Chianti Classico to the Casentino by climbing the Crocina pass on the Pratomagno, from where it’s enjoyable an incomparable view of Tuscany. A long climb with the last 10 km of gravel road, as in the heroic 1950s. We will descend to the medieval village of Poppi to stay by the castle that dominates the valley where the Arno river rise. Dinner at a typical restaurant paired with Casentino wines. Day 3: stage Poppi – Città di Castello (94 km e 1,400 m. elevation) A stage that will take us to the northern Val Tiberina passing through La Verna, the site where St. -
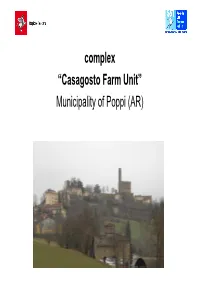
Complex “Casagosto Farm Unit” Municipality of Poppi (AR) Map of Tuscany with Location of Poppi (Arezzo)
complex “Casagosto Farm Unit” Municipality of Poppi (AR) Map of Tuscany with location of Poppi (Arezzo) MAIN DISTANCES: AIRPORT Rome 220 km DISTANCES: Milan 375 km Florence 89 Km Florence 79 km Pisa 156 km Bologna 176Km THE REGION’S MAIN ATTRACTIONS LOCATION FLORENCE SIENA AREZZO ORTHOPHOTOGRAOH “CASAGOSTO FARM UNIT” GENERAL DESCRIPTION OF INVESTMENT OPPORTUNITIES IN POPPI (AREZZO) MAIN FEATURES: z PROPERTY: ASL Toscana SUD EST (Ex ASL 8 Arezzo) z PROPERTY INTENDED FOR SALE: by public auction z BUILDING: in good condition z TOTAL GROSS AREA : 2,116 sqm z APPURTENANT UNCOVERED AREA: 205.564 sqm z N. FLOORS: 4 floors above the ground and a basement floor z INTENDED USE: residential, typical artisinal and service area, neighbourhood trade, private managerial, tourism and hospitality, public or of public interest z COMPLEX: the property falls within an area subject to landscape protection (Italian Law.1497/1939 and Italian Law.431/1985); the property is bound under Italian Legislative Decree 490/99 CADASTRAL IDENTIFICATION SUMMARY DESCRIPTION Property “Casagosto Farm Unit” Poppi, Via dei ciliegi, Arezzo • The Casagosto property consists of an agricultural area immediately adjacent to the residential area of the village of Poppi. The property has easy access to municipal services and is well linked by local roads. The historic centre of Poppi is a valuable historic village. The centre is served by buses and the train station (Ponte a Poppi). In 1990 the Casentino Forests National Park was founded. We point out the 9-hole golf course nearby. • The complex consists of a main historic building in stone, an historic warehouse and a series of more recent buildings for agriculture use (stables, shed, barn, warehouse) that are partially disused and could provide an appreciable volume index in case of conversion. -

Casentino E Val Tiberina
piano paesaggistico proposta d’ambito logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito ambito 12 casentino e val tiberina Comuni di: Stia (AR), Pratovecchio (AR), Badia Tedalda (AR), Bibbiena (AR), Chiusi della Verna (AR), Castel San Niccolo (AR) Montemignaio (AR), Sestino (AR), Pieve Santo Stefano (AR), Ortignano Raggiolo ( AR), Caprese Michelangelo (AR), Chitignano (AR), Poppi (AR), Castel Focognano (AR), Sansepolcro (AR), Talla (AR), Anghiari (AR), Monterchi (AR), Subbiano (AR), Capolona (AR) profilo dell’ambito 1. descrizione interpretativa 2. invarianti strutturali 3. interpretazione di sintesi 4. disciplina d’uso 5. informazioni relative al piano piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito casentino e val tiberina Poppi Stia Bibbiena Lago Montedoglio Pieve Santo Stefano Anghiari San Sepolcro Profilo dell’ambito 1 p. 3 casentino e val tiberina Profilo dell’ambito p. 4 piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito casentino e val tiberina L’ambito Casentino e Val Tiberina, interessa gli alti bacini del fiume Arno e del fiume Tevere, comprende i paesaggi agroforestali del Casentino e della Valtiberina, si estende a est-nord-est sul versante adriatico con le Valli del Marecchia e del Foglia. Il Casentino si distingue per una dominanza di vasti complessi forestali - particolarmente con- tinui nei versanti del Pratomagno e all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il territorio di fondovalle è tuttora caratterizzato da una matrice agricola tradizionale in parte erosa da processi di urbanizzazione residenziale (particolarmente marcati tra Stia e Pratovecchio, tra Ponte a Poppi e Castel San Niccolò, tra Bibbiena e Soci) e industriale/artigianale (Pratovecchio, Campaldino, Bibbiena, Corsalone, tra Rassina e Capolona, ecc.). -

Tabelle Viciniorità
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HA-XXO25 27/02/16 TABELLA DI VICINIORITA' PAG. 1 PROVINCIA DI: AREZZO IDENTIFICATIVO ZONALE A291 030 DESCRIZIONE ANGHIARI PRG DENOMINAZIONE IDZ CAP PRG DENOMINAZIONE IDZ CAP 1 SANSEPOLCRO I155 030 52037 2 MONTERCHI F594 030 52035 3 CAPRESE MICHELANGELO B693 030 52033 4 PIEVE SANTO STEFANO G653 030 52036 5 AREZZO A390 031 52100 6 CAPOLONA B670 031 52010 7 SUBBIANO I991 031 52010 8 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA C774 031 52040 9 BADIA TEDALDA A541 030 52032 10 CASTIGLION FIORENTINO C319 032 52043 11 MONTE SAN SAVINO F628 031 52048 12 CASTIGLION FIBOCCHI C318 031 52029 13 MARCIANO DELLA CHIANA E933 032 52047 14 FOIANO DELLA CHIANA D649 032 52045 15 LUCIGNANO E718 032 52046 16 CORTONA D077 032 52044 17 LATERINA E468 028 52020 18 PERGINE VALDARNO G451 028 52020 19 CHIUSI DELLA VERNA C663 029 52010 20 BUCINE B243 028 52021 21 MONTEVARCHI F656 028 52025 22 SAN GIOVANNI VALDARNO H901 028 52027 23 CASTEL FOCOGNANO C102 029 52016 24 BIBBIENA A851 029 52011 25 CHITIGNANO C648 029 52010 26 POPPI G879 029 52014 27 SESTINO I681 030 52038 28 PRATOVECCHIO STIA M329 029 52017 29 TALLA L038 029 52010 30 ORTIGNANO RAGGIOLO G139 029 52010 31 LORO CIUFFENNA E693 028 52024 32 TERRANUOVA BRACCIOLINI L123 028 52028 33 CAVRIGLIA C407 028 52022 34 CASTELFRANCO PIANDISCO M322 028 52020 35 CASTEL SAN NICCOLO' C263 029 52018 36 MONTEMIGNAIO F565 029 52010 SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HA-XXO25 27/02/16 TABELLA DI VICINIORITA' PAG. -

Casentino Endurance
CASENTINO ENDURANCE il TEAM CASENTINO ENDURANCE con il patrocinio dei Comuni di BIBBIENA, POPPI e CHIUSI Della VERNA, della Comunità Montana del Casentino e della Provincia di Arezzo, con l'autorizzazione della F.I.S.E. e della F.E.I. ORGANIZZA IN DATA 5 E 6 GIUGNO 2010 IN LOCALITA' “LA FERRANTINA” (BIBBIENA – AR) LE GARE DI ENDURANCE: • CEI2* 120 km Internazionale e Tappa Coppa Italia • CEI1* 90 km Internazionale • 3° tappa del Campionato Regionale Toscano CEN2*/B 90 km, CEN1*/R 60 km, 30 Km agonisti e debuttanti valide anche per il “Ranking Endurance 2010” A.S.D. Team Casentino Endurance – Via Del Tessitore n. 14A – 52011 Bibbiena (AR) PRESENTAZIONE L’associazione Casentino Endurance vi invita a partecipare alla gara Internazionale valevole per la Coppa Italia che si svolgerà nella splendida valle del Casentino, terra di castelli, pievi romaniche e luoghi danteschi. IL CAMPO GARA Sarà allestito nel comune di Bibbiena (Arezzo), in una area dotata di: • ampi spazi per il parcheggio dei trailers • ricovero per i cavalli • area per ristorazione curata dalla Confraternita di Misericordia di Soci (il ricavato contribuirà all'acquisto della nuova ambulanza) • stand prodotti tipici PERCORSO ANELLI Il percorso della gara si svolgerà su 2 anelli (anello blu di 30Km e anello rosso 31Km) a ridosso del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Si attraverseranno luoghi storici come la piana di Campaldino (un tempo teatro dello scontro tra Guelfi e Ghibellini e oggi campo di battaglia tra i cavalieri dell’Endurance), si cavalcherà a ridosso del Castello dei Conti Guidi (dove ancora oggi appare il fantasma della contessa Matelda) e attraverso luoghi di interesse ambientale come l’alta Valle dell’Arno. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2017
Ufficio del territorio di AREZZO Data: 16/03/2017 Ora: 14.41.13 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.1 del 28/02/2017 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 CASENTINO ALTO TEVERE Comuni di: BIBBIENA, CASTEL FOCOGNANO, CASTEL SAN NICCOLO, Comuni di: BADIA TEDALDA, CAPRESE MICHELANGELO, PIEVE CHITIGNANO, CHIUSI DELLA VERNA, MONTEMIGNAIO, SANTO STEFANO, SESTINO ORTIGNANO RAGGIOLO, POPPI, PRATOVECCHIO, STIA, SUBBIANO, TALLA, PRATOVECCHIO STIA COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO E MISTO 4000,00 SI SI 4000,00 SI SI BOSCO D`ALTO FUSTO 4600,00 4400,00 CASTAGNETO DA FRUTTO 5000,00 5800,00 COLTURE IN SERRA 50000,00 11-DA VALUTARE A PARTE 50000,00 11-DA VALUTARE A PARTE GLI IMPIANTI E GLI IMPIANTI E ATTREZZATURE FISSE) ATTREZZATURE FISSE) COLTURE ORTIVE A PIENO CAMPO 50000,00 50000,00 FRUTTETO SPECIALIZZATO 18000,00 11-DA VALUTARE A PARTE 13000,00 7-TRATTASI DI IMPIANTI DI GLI IMPIANTI E ETA MEDIA A PARTIRE ATTREZZATURE FISSE) DALLA MESSA IN DIMORA) 7-TRATTASI DI IMPIANTI DI 11-DA VALUTARE A PARTE ETA MEDIA A PARTIRE GLI IMPIANTI E DALLA MESSA IN DIMORA) ATTREZZATURE FISSE) Pagina: 1 di 12 Ufficio del territorio di AREZZO Data: 16/03/2017 Ora: 14.41.13 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.1 del 28/02/2017 n.- del - INCOLTO PRODUTTIVO E STERILE 1500,00 9-TERRENO NON IDONEO 1500,00 6-TERRENO NON IDONEO ALLA COLTIVAZIONE CHE, ALLA COLTIVAZIONE CHE SENZA INTERVENTO DELLA DIA SPONTANEAMENTE UN MANO DELL UOMO, DIA UN PRODOTTO VALUTABILE PRODOTTO VALUTABILE ANCHE MINIMO) ANCHE MINIMO. -

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE E CONI Di AREZZO UFFICIO EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA Giochi Sportivi Studenteschi Di 1° Grado - Fase Provinciale A
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE e CONI di AREZZO UFFICIO EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA e SPORTIVA Giochi Sportivi Studenteschi di 1° grado - Fase Provinciale a. s. 2009 - 2010 GARE DI ATLETICA LEGGERA Arezzo, 20 aprile 2010 CLASSIFICHE INDIVIDUALI CATEGORIA CADETTI FEMMINILE - Salto in alto Arrivo Cognome e Nome Scuola Ind. Mis. 1 FAILLI EMMA I.C. Montevarchi "Petrarca" 1,40 2 TISKAIA MARGARITA I.C."Cesalpino" Arezzo 1,34 3 POLVANI MARZIA I.C."Severi" Arezzo 1,34 4 VARIGNANI GIULIA I.C. Foiano "Marcelli" 1,31 5 BADALOTTI ILARIA I.C. Castel Focognano I 1,31 6 MOLINARO GIULIA I.C."Cesalpino" Arezzo 1,28 7 FIORDELLI DILETTA S.M. Un. Sansepolcro 1,28 8 ALARI RACHELE I.C. "Margaritone" Arezzo 1,28 9 VALENTINI GIULIA I.C. Bucine 1,28 10 SANDHU RAMANDEEP KAUR I.C. Terranuova Bracciolini 1,25 11 COSI CHIARA I.C."Severi" Arezzo 1,25 12 GIRONI VANESSA I.C. Bucine 1,25 13 MANCIANTI ELENA I.C. Bibbiena 1,20 14 ROSSI SARA I.C. Terranuova Bracciolini 1,20 15 BARNESCHI ELENA I.C. "Margaritone" Arezzo 1,20 16 LIPPI ARIANNA I.C. Bibbiena 1,15 17 BRUNETTI AGNESE I.C. Poppi 1,15 18 TOMMASINI NOEMI I.C. Pieve S. Stefano 1,15 19 FRANCIONI GIULIA I.C. Poppi 1,10 20 GINETTI MARIA CHIARA I.C. Foiano "Marcelli" 1,00 CATEGORIA CADETTI FEMMINILE - 1000 m piani Arrivo Cognome e Nome Scuola Ind. Min. Sec. Cent. 1 ZANOBINI GIULIA I.C. Terranuova Bracciolini 3 19 30 2 NOCENTINI SOFIA I.C."Severi" Arezzo 3 37 80 3 BENEDETTI FRANCESCA I.C."Severi" Arezzo 3 45 20 4 MARINANGELI GIADA S.M. -

Carta Dei Servizi Azienda Usl Toscana Sud
Presentazione La Carta dei Servizi è uno dei principali strumenti di tutela dei diritti dei cittadini che fruiscono delle attività sanitarie: essa costituisce un patto tra le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e gli utenti. Il suo contenuto rappresenta un impegno che l'Azienda USL Toscana sud est prende nei confronti della comunità di riferimento, finalizzato a rispettare i principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, continuità delle cure, diritto di scelta del cittadino , partecipazione e tutela e di efficienza ed efficacia delle cure La Carta dei Servizi è organizzata in due parti. La prima contiene i dati strutturali dell'Azienda: • ambito territoriale; • bacino di utenza; • principi fondamentali ai quali si ispira la sua attività; • tutela; • rispetto della privacy e del diritto alla riservatezza. La seconda parte descrive invece nel dettaglio le diverse attività che sono svolte e, soprattutto, le modalità di accesso ai servizi e alle prestazioni. La Carta è parte di un sistema sempre più differenziato di informazione al cittadino che comprende carte tematiche, opuscoli di settore e che si avvale di una pluralità di canali di informazione tra i quali il sito web aziendale e il numero telefonico dedicato. La Carta dei Servizi è disponibile in versione on line, per essere sempre aggiornata e per facilitare la consultazione delle singole parti di interesse. Nella stessa sono stati inseriti collegamenti (link) al sito aziendale: informare in tempo reale sulle prestazioni offerte e sulle modalità di erogazione, garantendo un modo di ricerca semplice e rapido, è uno degli impegni che l'Azienda si impegna a rispettare verso i suoi utenti. 2 Per una semplificazione della lettura della Carta si precisa che il riferimento agli ambiti territoriale ricompresi nel territorio della USL Toscana sud est sono i seguenti: Arezzo.