07 Grasso.Pmd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Monumental Olive Trees As Biocultural Heritage of Mediterranean Landscapes: the Case Study of Sicily
sustainability Article The Monumental Olive Trees as Biocultural Heritage of Mediterranean Landscapes: The Case Study of Sicily Rosario Schicchi 1, Claudia Speciale 2,*, Filippo Amato 1, Giuseppe Bazan 3 , Giuseppe Di Noto 1, Pasquale Marino 4 , Pippo Ricciardo 5 and Anna Geraci 3 1 Department of Agricultural, Food and Forest Sciences (SAAF), University of Palermo, 90128 Palermo, Italy; [email protected] (R.S.); fi[email protected] (F.A.); [email protected] (G.D.N.) 2 Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 35004 Las Palmas de Gran Canaria, Spain 3 Department of Biological, Chemical and Pharmaceutical Sciences and Technologies (STEBICEF), University of Palermo, 90123 Palermo, Italy; [email protected] (G.B.); [email protected] (A.G.) 4 Bona Furtuna LLC, Los Gatos, CA 95030, USA; [email protected] 5 Regional Department of Agriculture, Sicilian Region, 90145 Palermo, Italy; [email protected] * Correspondence: [email protected] Abstract: Monumental olive trees, with their longevity and their remarkable size, represent an important information source for the comprehension of the territory where they grow and the human societies that have kept them through time. Across the centuries, olive trees are the only cultivated plants that tell the story of Mediterranean landscapes. The same as stone monuments, these green monuments represent a real Mediterranean natural and cultural heritage. The aim of this paper is to discuss the value of monumental trees as “biocultural heritage” elements and the role they play in Citation: Schicchi, R.; Speciale, C.; the interpretation of the historical stratification of the landscape. -

First Evidence of an Egg-Laying Attempt of Feral Trachemys Scripta (Schoepff, 1792) in Sicily (Lake Pergusa, Italy)
Herpetology Notes, volume 13: 365-368 (2020) (published online on 14 May 2020) First evidence of an egg-laying attempt of feral Trachemys scripta (Schoepff, 1792) in Sicily (Lake Pergusa, Italy) Mirko Liuzzo1,*, Rosa Termine2, and Federico Marrone3 The pond slider Trachemys scripta (Schoepff, 1792) is is a lack of data regarding the reproductive biology of currently the world’s most widespread freshwater turtle this invader under natural conditions. (Ernst and Lovich, 2009). The natural distribution of T. In Sicily the first record of the alien red-eared slider scripta ranges from southern Virginia south to northern Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied, 1839) Florida and west to Kansas, Oklahoma, New Mexico dates back to 1993 (Lo Valvo, 1998). Despite this and north-eastern Mexico (Bringsøe, 2006; Ernst and species is frequently reported in the Sicilian lacustrine Lovich, 2009). To date, as a result of their massive environments (i.e. in the outskirts of Catania, the import as pets (Arvey and Servan, 1998; Bonin, 2004), Catania plain, the Pergusina basin and the mouth of the this turtle has been introduced outside its natural range river Irminio) (Bella and Turrisi, 2005) very limited data throughout all continents except Antarctica and on some are available. To date, no evidence of the presence of oceanic island (Ernst and Lovich, 2009). Recently, reproducing populations of the locally abundant pond an increase in the incautious releases of American slider, T. scripta, are confirmed in Sicily (Marrone pond sliders in the water bodies of Europe drove the and Naselli-Flores, 2015; Naselli-Flores and Marrone, European Union (EU) to adopt restrictive measures on 2019), although the subspecies T. -

The Last 7 Millennia of Vegetation and Climate Changes at Lago Di Pergusa
EGU Journal Logos (RGB) Open Access Open Access Open Access Advances in Annales Nonlinear Processes Geosciences Geophysicae in Geophysics Open Access Open Access Natural Hazards Natural Hazards and Earth System and Earth System Sciences Sciences Discussions Open Access Open Access Atmospheric Atmospheric Chemistry Chemistry and Physics and Physics Discussions Open Access Open Access Atmospheric Atmospheric Measurement Measurement Techniques Techniques Discussions Open Access Open Access Biogeosciences Biogeosciences Discussions Open Access Open Access Clim. Past, 9, 1969–1984, 2013 Climate www.clim-past.net/9/1969/2013/ Climate doi:10.5194/cp-9-1969-2013 of the Past of the Past © Author(s) 2013. CC Attribution 3.0 License. Discussions Open Access Open Access Earth System Earth System Dynamics Dynamics Discussions The last 7 millennia of vegetation and climate changes at Lago di Open Access Open Access Pergusa (central Sicily, Italy) Geoscientific Geoscientific Instrumentation Instrumentation L. Sadori1, E. Ortu2, O. Peyron2,3, G. Zanchetta4, B. Vanniere` 2, M. Desmet5, and M. MagnyMethods2 and Methods and 1Dipartimento di Biologia Ambientale, Universita` di Roma “La Sapienza”, Piazzale Aldo MoroData 5, 00185Systems Roma, Italy Data Systems 2CNRS, UMR6249, Laboratoire Chrono-Environnement, 16 route de Gray, 25030 Besanc¸on cedex, France Discussions Open Access 3CBAE, UMR5059, CNRS, Universite´ Montpellier 2, Montpellier, France Open Access 4 Geoscientific Dipartimento di Scienze della Terra, Universita` di Pisa, Via S. Maria 53, 56126 Pisa, Italy Geoscientific 5EA 6293 GeHCO,´ Universite´ de Tours, 37000 Tours, France Model Development Model Development Discussions Correspondence to: L. Sadori ([email protected]) Open Access Received: 23 March 2013 – Published in Clim. Past Discuss.: 8 April 2013 Open Access Revised: 10 July 2013 – Accepted: 12 July 2013 – Published: 19 August 2013 Hydrology and Hydrology and Earth System Earth System Abstract. -
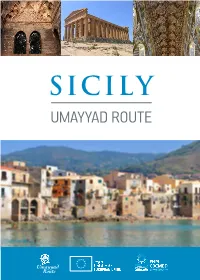
Sicily UMAYYAD ROUTE
SICILY UMAYYAD ROUTE Umayyad Route SICILY UMAYYAD ROUTE SICILY UMAYYAD ROUTE Umayyad Route Index Sicily. Umayyad Route 1st Edition, 2016 Edition Introduction Andalusian Public Foundation El legado andalusí Texts Maria Concetta Cimo’. Circuito Castelli e Borghi Medioevali in collaboration with local authorities. Graphic Design, layout and maps Umayyad Project (ENPI) 5 José Manuel Vargas Diosayuda. Diseño Editorial Free distribution Sicily 7 Legal Deposit Number: Gr-1518-2016 Umayyad Route 18 ISBN: 978-84-96395-87-9 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, nor transmitted or recorded by any information retrieval system in any form or by any means, either mechanical, photochemical, electronic, photocopying or otherwise without written permission of the editors. Itinerary 24 © of the edition: Andalusian Public Foundation El legado andalusí © of texts: their authors © of pictures: their authors Palermo 26 The Umayyad Route is a project funded by the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) and led by the Cefalù 48 Andalusian Public Foundation El legado andalusí. It gathers a network of partners in seven countries in the Mediterranean region: Spain, Portugal, Italy, Tunisia, Egypt, Lebanon and Jordan. Calatafimi 66 This publication has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of the beneficiary (Fundación Pública Castellammare del Golfo 84 Andaluza El legado andalusí) and their Sicilian partner (Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali) and can under no Erice 100 circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or of the Programme’s management structures. -

Breeding of Black-Necked Grebe Podiceps Nigricollis CL Brehm, 1831
Biodiversity Journal, 2017, 8 (1): 113–118 MONOGRAPH Breeding of Black-necked Grebe Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831 (Aves Podicipedidae) in the SCI and SPA ITA060002 “Lago di Pergusa” (Sicily, Italy) Rosa Termine “Kore” University of Enna, Laboratory of Sanitary Environmental Engineering - Section of Biology, Cittadella Universitaria - 94100 Enna, Italy; e-mail: [email protected] ABSTRACT On 2015 breeding season, we censused a high number of Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831 (Aves Podicipedidae), breeding in the SCI and SPA ITA060002 “Lago di Pergusa”, including the Nature Reserve “Lago di Pergusa”. After 1950 the breeding records of the P. nigricollis in Italy were of approximately twenty and relative to a few pairs. Since 2010, in the Lake Pergusa, the P. nigricollis has changed its status from “migratory, overwintering and irregular breeder” to “regular breeder”. In 2010, and more regularly in 2012–2015, there are in fact documented breeding attempts with relative offspring. This Lake has so far counted the largest number of breeding pairs for Sicily and Italy. We point therefore to the importance of this protected natural area as a breeding site for the P. nigricollis. KEY WORDS Black-necked Grebe; nesting; Pergusa Lake; Podiceps nigricollis; Sicily. Received 08.04.2016; accepted 21.06.2016; printed 30.03.2017 Proceedings of the 3rd International Congress “Biodiversity, Mediterranean, Society”, September 4th-6th 2015, Noto- Vendicari (Italy) INTRODUCTION From 2000 to 2011 there were a few cases of breeding attempts: in 2000 and 2005 in Caltanis- After 1950 the breeding records of the Podiceps setta province (Mascara, 2007); in 2004, in 2006 nigricollis C.L. -

(Verts/ALE) to the Commission
14.2.2002 EN Official Journal of the European Communities C 40 E/137 (2002/C 40 E/146) WRITTEN QUESTION E-1907/01 by Giorgio Celli (Verts/ALE) to the Commission (28 June 2001) Subject: Action to protect Lake Pergusa (Sicily), an area of Community interest Lake Pergusa (Enna) is a wetland included on the list of ITA060002 special protection areas (SPAs) selected by the Italian Government. The lake is also a nature reserve, which was set up under Regional Law (LR) 71/95 No 8220 in order to protect the basin together with its flora and fauna. The Province of Enna, which manages the nature reserve on behalf of the Region of Sicily, but which is also a member of the motor racing circuit consortium of Pergusa (Consorzio Ente Autodromo Pergusa) and as such is both supervisor and supervisee (!), has authorised the construction of a bypass to channel water from an artificial dam Lake Ancipa, in the Nebrodi mountains to Lake Pergusa. The project, already under way, has not undergone an EIA (environmental impact assessment), despite the fact that it will alter a delicate ecosystem, and has failed to obtain documentation relating to the constraints which apply to the area. Moreover, the project fails to take account of the filling time required, the magnitude of which, in terms of biological regeneration, must in any case be measured in years, given that the ecosystems in question are extremely delicate. Neither does it offer sufficient assurances that the rapid and alarming filling of the lake will not cause irreparable damage to the hydrobiological ecosystem. -

01 July-21 July 2019 We Are Taking the Applications for the 9Th Season of Archaeological Excavation at the Prehistoric Village of Case Bastione (Villarosa, Sicily)
2019 CASE BASTIONE FIELD SCHOOL - CENTRAL SICILY 9TH CAMPAIGN OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION 01 JULY-21 JULY 2019 We are taking the applications for the 9th season of archaeological excavation at the prehistoric village of Case Bastione (Villarosa, Sicily). Populated from the Neolithic to the Bronze Age (5th-2nd millenium BC), the site is placed along the Morello valley, in the very hearth of the island. Researches carried out here in the last decade have revealed important evidences for domestic architecture, every-day life, crafts and productive activities, together with a rich material culture dating to the Late Copper and Early Bronze Ages (mid-3rd to mid-2nd millennium BC). The aim of Case Bastione Field School is to offer a better understanding of how archaeology is practiced in the field. This will be achieved with specific classroom-based introduction to field methods, as well as specific and practical working experience: - Field activities: stratigraphic excavation, field-walking, surveying; - Lab activities: finds and data processing, cataloguing and documentation; - Lectures & seminars on methodology and the archaeology of Sicily; - Visits to major Sicilian archaeological sites and museums on request. No fees are required: technical equipment, lodging, local transport are offered; participants will pay for their own travel and meals. Accident insurance is required. Certificate of attendance will be provided on request. Scientific direction of the Superintendence of Cultural Heritage of Enna, in collaboration with the Villarosa -

Soils and Land Use at Ancient Greek Colonial Temples of Southern Italy T G.J
Journal of Archaeological Science: Reports 24 (2019) 946–954 Contents lists available at ScienceDirect Journal of Archaeological Science: Reports journal homepage: www.elsevier.com/locate/jasrep Soils and land use at ancient Greek colonial temples of southern Italy T G.J. Retallack Department of Earth Sciences, University of Oregon, Eugene, OR 97403, United States of America ABSTRACT Soils at ancient Greek temples in Greece are distinct for each deity, reflecting an economic basis for their cults, but did this pattern also extend to classical Greek colonies? This study of 24 temples in southern Italy reveals little assimilation by Greek colonists of indigenous cults at first, because their temples are on the same kinds of soils, reflecting similar cults for each of the Olympian deities as in Greece. Worship of Hera was more widespread in Italy than in Greece and the Aegean, and also on Alfisol soils suitable for pastoralism. Temples of Demeter in contrast were on Mollisols best for grain cultivation. Rocks and grottos sacred to Persephone are comparable with those in Greece, but were popular with hellenized Sikels for an indigenous hybrid cult of Demeter and Kore. 1. Introduction Pithecoussae, but there is little comparable evidence for intermarriage in later Sicilian burials (Hodos, 1999). Sikels before colonization had The nature of western Greek colonialism has been controversial, sophisticated metal utensils and weapons, fortified villages, chamber with one extreme interpretation emphasizing the superiority of Greek tombs, longhouses, and Sant'Angelo Muxaro and Siculo-Geometric over indigenous culture, as has been assumed for British colonization of pottery (de Angelis, 1998; Antonaccio, 2001; Attema et al., 2010). -

Atlas of Italian Irrigation Systems
Atlas of Italian Irrigation systems Edited by Raffaella Zucaro Atlas of Italian Irrigation systems Edited by Raffaella Zucaro April 2014 “Not everything that counts can be counted and not everything than can be counted, counts” (Albert Einstein) ATLAS OF ITALiaN IRRIGATION SYSTEMS 2014. A traslated version of the “Atlante Nazionale dell’irrigazione” Roma, INEA 2011 Editor: Raffaella Zucaro Editorial staff: Antonella Pontrandolfi (Coordinator), Gian Marco Dodaro, Cristina Gallinoni, Ciro Luca Pacicco and Michele Vollaro. Technical team supporting editorial staff: Antonio Gerardo Pepe (Coordinator), Simona Capone and Fabrizio Mirra. Graphic Design and Layout: Fabio Lapiana Publishing Coordination: Benedetto Venuto Publishing Secretary: Roberta Capretti English Translation: Laura Maurano Introduction of the President of INEA The agricultural development of different areas in to support decision making. In fact, since the nineties Italy has been closely associated with access to water. INEA, on the base of precise guidelines received from Crop Irrigation systems have always been an asset in the European Commission and the Italian Ministry of terms of revenue and employment. These are the main Agriculture, has resumed its research on these issues reasons why in 1961, on the occasion of the 100th an- through specific surveys. The surveys, starting from niversary of the Italian Unification, the Italian Ministry portraying the need for general knowledge updating re- of Agriculture started up a specific survey entrusted lated to water use in agriculture (irrigated crops, ir- to INEA on Italian irrigation and the possible develop- rigation schemes, economic and managerial aspects ments of the sector in the different Italian regions, which etc.), delve into new research issues, such as public sec- led to the publication of the ‘Map of Irrigation in Italy’. -
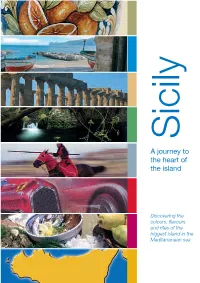
A Journey to the Heart of the Island
Sicily A journey to the heart of the island Discovering the colours, flavours and rites of the biggest island in the Mediterranean sea Regione Siciliana POR Sicilia UNIONE EUROPEA Assessorato Turismo, 2000-2006 Fondo Europeo Trasporti e Comunicazioni Misura 4.18 a/b Sviluppo Regionale www.regione.sicilia.it/turismo A journeySicily to the heart of the island Discovering the colours, flavours and rites of the biggest island in the Mediterranean sea index Knowing Sicily A paradise made of sea and sun island Treasure oasi Green pag 04 pag 12 pag 22 pag 54 Language ......................... 6 Among shores, The early settlements ..... 24 Regional parks ............... 56 cliffs and beaches .......... 14 Documents and Exchange . 6 The Greek domination .... 26 Reserves and The fishing villages, the protected areas .............. 58 The weather and what The Roman civilization ... 32 fishing tourism and wearing ............................ 6 The Arab-Norman period .. 34 Outdoor sports................ 60 the sea cooking .............. 16 Festivities ......................... 7 Frederick II and the Country tourism Minor Islands and marine Swabians ....................... 38 and baths ...................... 62 Trasportation .................... 7 protected areas: a paradise Medieval Sicily ............... 42 Roads ............................... 8 for diving and snorkelling .. 18 The explosion of Emergency numbers ........ 8 Marina Charters, tourist 02 harbours and the Baroque..................... 45 Geography ........................ 8 aquatic sports ................. 20 Bourbon’s age ................ 48 History ............................ 10 The Florio’s splendour .... 50 The museums ................ 52 The memory of the Island An island opened all the year Master in hosting Maps of the provinces pag 64 pag 76 pag 86 pag 100 The non-material Religious celebrations .... 78 The routes of wine ......... 88 Palermo ........................ 102 heritage register ............. 66 Theatre and Gastronomy ................... -
The Last 7 Millennia of Vegetation and Climate Changes at Lago Di Pergusa
EGU Journal Logos (RGB) Open Access Open Access Open Access Advances in Annales Nonlinear Processes Geosciences Geophysicae in Geophysics Open Access Open Access Natural Hazards Natural Hazards and Earth System and Earth System Sciences Sciences Discussions Open Access Open Access Atmospheric Atmospheric Chemistry Chemistry and Physics and Physics Discussions Open Access Open Access Atmospheric Atmospheric Measurement Measurement Techniques Techniques Discussions Open Access Open Access Biogeosciences Biogeosciences Discussions Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Open Access Open Access Clim. Past Discuss., 9, 2059–2094, 2013 Climate www.clim-past-discuss.net/9/2059/2013/ Climate doi:10.5194/cpd-9-2059-2013 of the Past of the Past © Author(s) 2013. CC Attribution 3.0 License. Discussions Open Access Open Access This discussion paper is/hasEarth been System under review for the journal ClimateEarth of the System Past (CP). Please refer to the correspondingDynamics final paper in CP if available. Dynamics Discussions Open Access The last 7 millenniaGeoscientific of vegetationGeoscientific and Open Access Instrumentation Instrumentation climate changesMethods and at Lago di PergusaMethods and Data Systems Data Systems Discussions Open Access (central Sicily, Italy)Open Access Geoscientific Geoscientific 1 2 2,3 4 Model Development2 5 L. Sadori , E. OrtuModel, O. Development Peyron , G. Zanchetta , B. Vanniere` , M. Desmet , and M. Magny2 Discussions Open Access 1 Open Access Dipartimento di BiologiaHydrology Ambientale, and Universit a` di Roma “La Sapienza”,Hydrology and Piazzale Aldo Moro 5, 00185Earth Roma, System Italy Earth System 2UMR CNRS 6249 Laboratoire Chrono-Environnement, 16 route de Gray, Sciences Sciences 25030 Besanc¸on cedex, France 3 Discussions Open Access CBAE, UMR 5059 CNRS, Univ. -

And Late-Holocene Vegetation and Fire History at Biviere Di Gela, A
Veget Hist Archaeobot (2009) 18:371–387 DOI 10.1007/s00334-009-0211-0 ORIGINAL ARTICLE Mid- and late-Holocene vegetation and fire history at Biviere di Gela, a coastal lake in southern Sicily, Italy Roland Noti Æ Jacqueline F. N. van Leeuwen Æ Daniele Colombaroli Æ Elisa Vescovi Æ Salvatore Pasta Æ Tommaso La Mantia Æ Willy Tinner Received: 6 May 2008 / Accepted: 18 December 2008 / Published online: 31 January 2009 Ó Springer-Verlag 2009 Abstract The vegetation and fire history of few coastal declined again 6600 cal B.P. (4650 B.C.). Afterwards, ever- sites has been investigated in the Mediterranean region so green trees (Q. ilex-type and Olea) became dominant in the far. We present the first paleoecological reconstruction from forest and Pistacia shrublands were established. Forest and coastal Sicily, the largest island in the Mediterranean Sea. shrubland reached a maximum ca. 7000–5000 cal B.P. We analysed pollen and charcoal in the sediments of (5050–3050 B.C.); subsequently forest declined in response Biviere di Gela, a lake (lagoon) on the south coast of Sicily. to human impact, which was probably exacerbated by a Our data suggest that the area became afforested after a general trend towards a more arid climate. During the Neo- marine transgression at ca. 7200 cal B.P. (5250 B.C.). Build- lithic, fire was used to open the landscape, significantly up of forest and shrublands took ca. 200–300 years, mainly reducing several arboreal taxa (Q. ilex, Fraxinus, Juniperus) with the deciduous trees Quercus, Ostrya and Fraxinus. and promoting herbs and shrubs (Achillea, Cichorioideae, Juniperus expanded ca.