La Laguna Nascosta
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

ITALY – SLOVENIA – CROATIA SELF-GUIDED CYCLE TOUR, VENICE to POREC 8 DAYS / 7 NIGHTS 255 – 430 Km
THREE COUNTRY BIKE TOUR 2020 ITALY – SLOVENIA – CROATIA SELF-GUIDED CYCLE TOUR, VENICE TO POREC 8 DAYS / 7 NIGHTS 255 – 430 km The starting point of this cycle tour begins with “la Serenissima”, Venice, the lagoon city on the shores of the Adriatic Sea. Cycling past the beaches of the classical holiday resorts of Jesolo and Caorle on the Italian Adriatic, an opportunity to take a refreshing swim. The inland regions of the Friuli-Venezia-Giulia offers countless sites with very special charm waiting to be discovered; Medieval fortress towns; Roman archaeological excavations; typical Italian piazzas and buildings embossed with Venetian influences. While on the one side the Adriatic stretches calmly and silently, the Julian Alps rise majestically to the north. The tour ends on the beautiful Croatian peninsula of Istria. Return journey to Venice can be done by boat. TERRAIN / GRADE The cycle trip is flat until just before Trieste, then it begins to climb slightly until Porec. Electric bikes are available for this tour (limited number - on request). Highlights and places of interest along the route Venice and the surrounding offshore islands The Italian seaside towns of Cavallino, Caorle, Jesolo and Grado The beaches of the Adriatic The important river port of Portogruaro for the maritime power of Venice Aquileia, a big city at the time of the Roman Empire The castles of Miramare and Duino Piran – a former Venetian town on the Slovenian coast ITINERARY Please note that on Day 3, 4 & 6, you need to give your 1st choice of town when booking, as there are options. -

Scuole Medie
VEMM000VB6 PROVINCIA DI VENEZIA VEMM000XB4 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO) VEMML736N9 COMUNE DI VENEZIA VEMM036YH1 DISTRETTO 036 VECT70000L CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA VENEZIA - S. CROCE 1882 (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VENEZIA : VEMM12600T DISTRETTI DI COMPETENZA : 036 CON SEDI CARCERARIE : VEEE700011 - VENEZIA, VEEE700022 - VENEZIA, VEMM70001X - VENEZIA VEMM81401P B. E A. VIVARINI - AGGR. I.C. (AS.IST.COM.VEIC81400N/PAR.T.PROL.) FONDAMENTA RADI 9/A LOC. MURANO VEMM812013 B.GALUPPI (IST.COMPRENSIVO) (AS.IST.COM.VEIC812002/TOT.T.PROL.) VIA S. MAURO, 107 BURANO VEMM70001X CASA CIRCONDARIALE S.MARIA MAGGIORE (SEDE CARCERARIA) S.CROCE 324 VENEZIA VEMM13400R D.ALIGHIERI (PARZ. TEMPO PROLUNGATO) S.MARCO, 3042 (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) VEMM03600G M. FOSCARINI (ANN.CONVITTO) CANNAREGIO, 4941 VENEZIA VEMM12600T MOROSINI (PARZ. TEMPO PROLUNGATO) S. CROCE, 1882 VENEZIA (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) VEMM81301V P.LOREDAN (IST.COMPRENSIVO) (AS.IST.COM.VEIC81300T/TOT.T.PROL.) SESTIERE SCARPA PELLESTRINA VEIC812002 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VE-BURANO "GALUPPI" BURANO - VIA S. MAURO, 107 (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) CON SEZIONI ASSOCIATE : VEEE812014 - VENEZIA, VEMM812013 - VENEZIA VEIC81400N ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VE-MURANO "U.FOSCOLO" MURANO - VIA COLLEONI 15 (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) CON SEZIONI ASSOCIATE : VEEE81401Q -
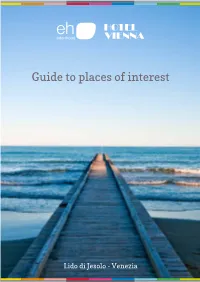
Guide to Places of Interest
Guide to places of interest Lido di Jesolo - Venezia Cortina Oderzo Portogruaro Noventa di Piave Treviso San Donà di Piave Caorle Altino Eraclea Vicenza Jesolo Eraclea Mare Burano Cortellazzo Lido di Jesolo Dolo Venezia Verona Padova Cavallino Mira Cà Savio Chioggia Jesolo and the hinterland. 3 Cathedrals and Roman Abbeys . 10 Visits to markets Concordia Sagittaria, Summaga and San Donà di Piave Venice . 4 From the sea to Venice’s Lagoon . 11 St Mark’s Square, the Palazzo Ducale (Doge’s Palace) and the Caorle, Cortellazzo, Treporti and Lio Piccolo Rialto Bridge The Marchland of Treviso The Islands of the Lagoon . 5 and the city of Treviso . 12 Murano, Burano and Torcello Oderzo, Piazza dei Signori and the Shrine of the Madonna of Motta Verona and Lake Garda. 6 Padua . 13 Sirmione and the Grottoes of Catullo Scrovegni Chapel and Piazza delle Erbe (Square of Herbs) The Arena of Verona and Opera . 7 Vicenza . 14 Operatic music The Olympic Theatre and the Ponte Vecchio (Old Bridge) of Bas- sano del Grappa Cortina and the Dolomites . 8 The three peaks of Lavaredo and Lake Misurina Riviera del Brenta . 15 Villas and gardens The Coastlines . 9 Malamocco, Pellestrina, Chioggia 2 Noventa di Piave Treviso San Donà di Piave Eraclea Caorle Jesolo Eraclea Mare Lido di Jesolo Cortellazzo Cavallino Jesolo and the hinterland The lagoon with its northern appendage wends its way into the area of Jesolo between the river and the cultivated countryside. The large fishing valleys of the northern lagoon extend over an area that is waiting to be explored. Whatever your requirements, please discuss these with our staff who will be more than happy to help. -

(SCIENTIFIC DESCRIPTION) Deliverable 3.2.2 – Italian Version
ANALISI DEL CONTESTO – DESCRIZIONE SCIENTIFICA (SCIENTIFIC DESCRIPTION) Deliverable 3.2.2 – Italian version 1. AREA PILOTA DEL PROGETTO ................................................................................................................................. 4 1.1 Identificazione generale ....................................................................................................................................... 4 1.2 Il Comune di Caorle ............................................................................................................................................. 4 1.3 Il Comune di Concordia Sagittaria ....................................................................................................................... 4 1.4 Il Comune di San Michele al Tagliamento ........................................................................................................... 5 2. GEOMORFOLOGIA E IDROLOGIA ............................................................................................................................. 6 2.1 Geomorfologia ..................................................................................................................................................... 6 2.2 Idrografia ........................................................................................................................................................... 10 2.3 Fonti di pressione ............................................................................................................................................. -

Piano Regolatore Delle Acque 01 Relazione Illustrativa
CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE Portogruaro - San Donà di Piave (VE) PROVINCIA DI VENEZIA Comune di Concordia Sagittaria PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE 01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA Redattori Dott. Ing. Sergio Grego Dott. Ing. Giulio Pianon Dott. Agr. Graziano Paulon Collaboratori Dott. Ing. Ornella Oliva Dott. Ing. Erika Grigoletto Dott. for. Marco Cavallaro Piano delle Acque - Concordia Sagittaria Relazione Illustrativa 1 PREMESSA ............................................................................................................................................................... 5 2 INQUADRAMENTO NORMATIVO ............................................................................................................................. 8 2.1 Normativa Comunitaria ...................................................................................................................................... 8 2.2 Normativa naziona e .......................................................................................................................................... 8 2.3 Normativa Regiona e ......................................................................................................................................... 9 3 STRUMENTI SOVRAORDINATI .............................................................................................................................. 10 3.1 P.T.R.C. .......................................................................................................................................................... -

Comune Di Jesolo PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2020/97 DEL 18/09/2020 ASSEGNATA AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E UFFICIO ESPROPRIAZIONI OGGETTO: DGR N. 373 DEL 31 MARZO 2020. CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 6, C.7 BIS DELLA L.R. 22 GIUGNO 1993, N. 16 "INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL VENETO ORIENTALE". ANNO 2020. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI PROGETTI: N. 1 "MOBILITÀ SOSTENIBILE " E N. 2 "PAESC". IL SINDACO PREMESSO che: - il comune di Jesolo è dotato di piano regolatore generale (PRG), approvato dalla giunta regionale veneta in data 04/08/1977 con delibera n. 3425, mentre la strumentazione urbanistica ora vigente per l’intero territorio risulta quella successivamente approvata con provvedimenti della giunta regionale del 04/08/2000 n. 2652, del 19/07/2002 n. 1979, del 18/04/2003 n. 1145, dell’08/04/2008 n. 812 e con provvedimento di consiglio comunale del 10/04/2007 n. 56 e con gli ulteriori provvedimenti della giunta regionale del 03/11/2009 n. 3313 e dell’11/05/2010 n. 1334; - il Piano di Assetto del Territorio approvato in Conferenza dei Servizi del 4 marzo 2020, ratificato con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 368 del 24 marzo 2020 pubblicata sul B.U.R. n. 49 del 10 aprile 2020; - il Piano Regolatore, ai sensi dell’art. 48 comma 5 bis della L.R. 23/04/2004, n. 11, per le parti compatibili con il piano di assetto del territorio, è diventato Piano degli Interventi; - in data 10/07/2014 il Comune di Jesolo ha aderito all’iniziativa europea “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) con la successiva redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato con delibera di consiglio comunale n. -

“Prodotti E Produttori Del Parco Alimentare Della Venezia Orientale”
“TIPI-NET RETE DI INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI TRA LE ALPI E L’ADRIATICO” Fase 3: Attività di studio “Prodotti e produttori del Parco Alimentare della Venezia Orientale” PROGETTO TIPI-NET (Cod.AAVEN223507) Reti di iniziative per la promozione dei prodotti tipici tra le Alpi e l’Adriatico Programma di iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia/Slovenia 2000-2006 Progetto cofinanziato dall’Unione Europea mediante il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Il presente documento fa parte dei materiali prodotti nell’ambito del progetto INTERREG Italia-Slovenia 2000-2006 “TIPI-NET - Rete di iniziative per la promozione dei prodotti tipici tra le Alpi e l’Adriatico” ed è stato realizzato con il contributo finanziario del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR). www.parcoalimentare.ve.it Il testo è stato completato nel dicembre 2006 Soggetto promotore: Società Cooperativa Agricola Primo Maggio – Concordia Sagittaria VE Autori del testo: - Dott.ssa Melania Buset - Dott.ssa Chiara Da Giau - Dott.ssa Silvia Guala - Dott.ssa Laura Tizianel - Dott. Giulio Volpi Il volume è stato curato da: Starter S.r.l. – Porcia PN Grafica a cura di: META Comunicatori S.r.l. – Treviso Le foto del testo sono state fornite da: - Provincia di Venezia – Assessorato agricoltura e attività produttive - Consorzio del Lingual Ringraziamenti Si ringraziano quanti, a vario titolo hanno collaborato alla messa a disposizione delle informazioni necessarie alla predisposizione del catasto e delle altre parti del documento. In particolare si ringraziano il dott. agr. G. Babbo di San Donà di Piave, il sig. G. Basei della Cooperativa agricola Bibione, il sig. Tiziano Battocchio dell’Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto Friulana, la sig.ra C. -

Veee000vy8 Provincia Di Venezia - Scuola Primaria
VEEE000VY8 PROVINCIA DI VENEZIA - SCUOLA PRIMARIA VEEE019ZH2 DISTRETTO 019 VEEEA302Z1 COMUNE DI ANNONE VENETO VEEE862015 PAOLA E ANGELA RAMPULLA (ASSOC. I. C. VEIC862003) VIA MARCONI, 1 ANNONE VENETO (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) VEIC862003 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ANNONE VENETO ANNONE VENETO - VIA G. MARCONI, 12 (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) CON SEZIONI ASSOCIATE : VEAA86200V - ANNONE VENETO, VEAA86201X - ANNONE VENETO, VEEE862015 - ANNONE VENETO, VEMM862014 - ANNONE VENETO VEEEB642A1 COMUNE DI CAORLE VEEE81901V A. PALLADIO-CAP. (ASSOC. I. C. VEIC81900R) VIALE BUONARROTI (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) VEEE819031 S. GIORGIO DI LIVENZA (ASSOC. I. C. VEIC81900R) PIAZZA LIBERTA' - N. 4 LOC. S. GIORGIO DI LIV. VEIC81900R ISTITUTO COMPRENSIVO ANDREA PALLADIO CAORLE - VIALE BUONARROTI N. 6 (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) CON SEZIONI ASSOCIATE : VEAA81900L - CAORLE, VEAA81901N - CAORLE, VEAA81902P - CAORLE, VEEE81901V - CAORLE, VEEE819031 - CAORLE, VEMM81901T - CAORLE VEEEC714B9 COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE VEEE82505A GIOVANNI PASCOLI-CAP. (ASSOC. I. C. VEIC825004) VIA TORINO 2 CINTO CAOMAGGIORE (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) VEIC825004 ISTITUTO COMPRENSIVO IPPOLITO NIEVO CINTO CAOMAGGIORE - VIA TORINO N. 4 (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) CON SEZIONI ASSOCIATE : VEAA82500X - CINTO CAOMAGGIORE, VEAA825011 - CINTO CAOMAGGIORE, VEAA825022 - GRUARO, VEAA825033 - PRAMAGGIORE, VEEE825016 - GRUARO, VEEE825049 - PRAMAGGIORE, VEEE82505A - CINTO CAOMAGGIORE, VEMM825015 - CINTO CAOMAGGIORE, VEMM825026 - PRAMAGGIORE, VEMM825037 - GRUARO VEEEC950B0 COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA VEEE818035 GIOSUE' CARDUCCI - LEVADA (ASSOC. I. C. VEIC818001) VIA CESARE BATTISTI LOC. LEVADA VEEE818013 OTTAVIANO AUGUSTO-CAP. (ASSOC. I. C. VEIC818001) VIA CANDIANI 3/5 CONCORDIA SAGITTARIA (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) VEEE818046 SCUOLA NUOVA- SINISTRA LEMENE (ASSOC. -

Page 1 EUROPEAN AGRICULTURAL FUND for RURAL
ÿüùúïëø &ñüóíÿöþÿüëö ÿøî ðùü ÿüëö ïĀïöùú÷ïøþU ÿüùúï óøĀïýþý óø üÿüëö ëüïëý øíòëøþóøñøíòëøþóøñ ëøîýíëúïý ëøîýíëúïý Caorle øíòëøþóøñøíòëøþóøñ ëøîýíëúïý ëøîýíëúïý 0N ,N (+N ()N ((N /N (N -N (-N +N (,N )N .N (1N *N ïĂ $ N. (N& N(1 )N$& N() *N$&& À N(/ +N $ & N)1 ,N$ $& & N)) (*N -N$$ && & & N)- .N&$ & N*1 /N& & & N*) úN, 0N& N*- (1N N*/ ((N& N+) ()N& & N+/ (*N& $ & & & N,1 (+N N,+ (,N N,- (-N& & N,/ õïă Short distance Possible walking itinerary Medium distance Possible cycling itinerary Long distance Driving itinerary òïïëýþïüø úüùĀóøíïùðïøóíï KalmYl]\ Z]lo]]f l`] kYf\q k`gj]k g^ l`] dY_ggf g^ N]fa[] Yf\ l`] Zgj\]j Z]lo]]f l`] N]f]lg Yf\ >jamda l`] Yj]Y l`Yl [gmd\ Z] \]Òf]\ Yk N]f]raY Gja % ]flYd] =YklN]f]lg! ]f[gehYkk]k).emfa[ahYdala]kk[Yll]j]\Ydgf_l`]Fgjl`% ]jf 9\jaYla[ [gYkldaf]2 9ffgf] N]f]lg ;Ygjd] ;YnYddafg%Lj]hgjla ;]__aY ;aflg ;YgeY__agj] ;gf[gj\aY KY_allYjaY =jY[d]Y >gkkYdlY \a Hgjlg_jmYjg ?jmYjg B]kgdg Hgjlg_jmYjg HjYeY__agj] KYf Klafg KYf Ea[`]d]YdLY_daYe]flg L]_dag N]f]lgYf\Lgjj]\aEgklg& 9l`gm_` l`] Yj]Y ak kl]]h]\ af `aklgjq Yf\ ak gf] g^ l`] n]jq Òjkl dg[Ylagfk lg Z] k]lld]\ Zq l`] Yf[a]fl N]f]la kge]g^ l`]k]lgofk g^^]j l`]n]jqdYl]kl afl]jek g^ lgmjakl^Y[adala]k& ;gf[gj\aYoYk l`]egklaehgjlYfl []flj] g^ l`] j]_agf l`jgm_`gml ]Yjdq lae]k ÒjklYkYN]f]la[ k]lld]e]fl l`]fYk Y JgeYf úN. -

Andrea De Götzen Via Dei Paleoveneti 66, 30023 Concordia Sagittaria
F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome Andrea de Götzen Indirizzo Via dei Paleoveneti 66, 30023 Concordia Sagittaria (VE) Telefono (+39) 336 277419 E-mail [email protected] - [email protected] pec [email protected] Codice fiscale e P.IVA DGTNDR71H08L483X - 03816290278 Nazionalità Italiana Luogo e data di nascita Udine, 8 giugno 1971 ESPERIENZA LAVORATIVA LIBERA PROFESSIONE dal 18.10.1999 al 31.12.2011 • Data dal 01.01.2016 • Indirizzo Via dei Paleoveneti 66, 30023 Concordia Sagittaria (VE) • Attività MiCapo occupo Settore di Lavoriopere idraulichePubblici. Coordino e di riqualificazione un gruppo di ambientale, lavoro volto fognature, prevalentemente acquedotti, alla Pianiprogettazione comunali ed delleesecuzione Acque, di interventirelazioni didi difesa compatibilità del suolo, idraulica, tutela del verterritorio,ifiche irrigazionedi invarianza e di idraulicariqualificazione, opere ambientale di difesa (Allegatodel suolo 1). e di irrigazione, energie rinnovabili, collaudi statici e tecnico-amministrativiØ Funzione. diPosseggo Progettista i requisiti per il Coordinamento della sicurezza nell’ambito dei cantieri ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. Ho assunto incarichi come Ø Funzione di Direttore dei Lavori CTU dal Tribunale di Pordenone e in qualità di CTP. Ø Funzione di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione Svolgo il servizio di supporto al RUP, curando tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici dallaØ faseFunzione di pianificazione di Coordinatore e progettazioneper la sicurezza degli in fase interventi di esecuzione alla fase di Direzione dei lavori, curando anche la predisposizione dei documenti di assegnazione dei servizi professionali di architettura e Ingegneria e dei lavori e l’eventuale gestione della fase di contenzioso (Allegato 1). -

07-Esterna-Casier4d'altino B
REGIONE VENETO Come arrivare a Come arrivare a ASSESSORATO AI PARCHI Il Parco del Sile può essere Casale sul Sile: Quarto d’Altino: E AREE NATURALI PROTETTE raggiunto tramite: www.parchiveneto.it Autostrada: A27 VE-BL, uscite da Treviso SP67 fino a Casale da Treviso SP67 fino a Assessore Mogliano Veneto, Treviso Sud Quarto d’Altino Flavio Silvestrin sul Sile, oppure SS13 in Milano Padova Aeroporti: Antonio Canova (TV) direzione Venezia; DOV’È Venezia Marco Polo (VE) a Preganziol SP63 Parco Naturale Viabilità ordinaria: da Treviso PARCO NATURALE Bologna (via Schiavonia) IL PARCO SP17 in direzione Quinto, da Padova REGIONALE DEL Venezia IL PARCO FIUME SILE Regionale del Fiume Sile Venezia SS13 in direzione Treviso. E I SUOI COMUNI GIA’ CHE CI SIETE www.parks.it/parco.fiume.sile/ DEL SILE Presidente ENTE PARCO VISITATE IL PARCO Alberto Magaton 7. The GiraSile between Casale sul Sile, Roncade and Quarto d’Altino NATURALE E LE SUE OASI! 7. Il GiraSile tra Casale sul Sile, Roncade e Quarto d’Altino REGIONALE DEL per visite guidate a piedi, PROVINCIA DI TREVISO After Casale sul Sile You enter in the municipality of Quarto d'Altino, town grown from the ancient S. FIUME SILE in bicicletta, in canoa, www.provincia.treviso.it Oltrepassato Casale sul Sile si entra nel comune di Quarto d’Altino, borgo sviluppatosi dall’antico S. Michele del Quarto, a Longobard centre that controlled the river navigation and was located in the Villa Letizia in barca, in ‘pantana’ : Presidente Michele al Quarto, insediamento longobardo che controllava il traffico fluviale, collocabile presso Oasi Cervara curve of S. -

Delibera C.C. 21 Del 5 Giugno 2019
Per l’approvazione e conferma del COPIA presente verbale, si sottoscrivono: IL PRESIDENTE F.to CAPPELLETTO MATTEO IL SEGRETARIO COMUNALE COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA F.to NAPOLITANO MARIARITA _______________________ VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. N. 21 del 05-06-2019 Ore 20:00 267/2000, la regolarità tecnica della OGGETTO: presente deliberazione. Approvazione del regolamento per il servizio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO di mensa scolastica nel Comune di San Stino F.to DEL BELLO ROBERTO di Livenza. _______________________ Sessione Straordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione. Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi CAPPELLETTO MATTEO Presente dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. FANTON RITA ELISA Presente 267/2000, la regolarità contabile della TEZZOT GIORGIA Presente presente deliberazione. PELLIZZON STEFANO Presente MARCHIORI MAURO Presente BORTOLUZZO TIZIANO Presente IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Antoniazzi Renza Presente F.to PASQUON STEFANIA SIMONELLA DAVIDE Assente TUIS MARFA Assente _______________________ PARPINEL FLAVIO Presente TOLLARDO FRANCESCA Presente Si attesta la conformità della presente TERRIBILE ELISA Presente deliberazione alle leggi, allo Statuto e CANALI GIUSEPPE Presente ai regolamenti. RICATTO LUCA ETTORE Presente DE STEFANI GIANLUCA Presente IL SEGRETARIO COMUNALE CIBIN CRISTINA Presente F.to NAPOLITANO MARIARITA SUTTO DINO Assente Totale Presenti 14 Totale Assenti 3 Assessori esterni: La presente copia in carta libera, ad uso amministrativo, è conforme Presiede il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua qualità di SINDACO. all’originale agli atti del Comune.