TESI DI LAUREA Universi Transmediali Mondi Interattivi E
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

October 26-28, 2012 Marriott Ann Arbor Ypsilanti at Eagle Crest Info Info 2012 U•CON GAMING CONVENTION
October 26-28, 2012 Marriott Ann Arbor Ypsilanti at Eagle Crest Info Info 2012 U•CON GAMING CONVENTION Map Location Marriott Ann Arbor Ypsilanti Eagle Crest, 1275 S Huron Street, Ypsilanti, MI 48197. Phone: Special (734) 487-0600. Registration is located in the lobby of Eagle Crest (not the hotel lobby). Open Gaming is on the second floor. Schedule Board/Card Friday, October 26 8 pm ...................Exhibitor Hall Closes 12 pm ................... Registration Opens 11 pm ................... Registration Closes 12 pm ............................ Events Begin Sunday, October 28 5 pm ...................Exhibitor Hall Opens 8:30 am ................ Registration Opens 8 pm ...................Exhibitor Hall Closes 9 am .............................. Events Begin CCGs 11 pm ................... Registration Closes 10 am .................Exhibitor Hall Opens Saturday, October 27 3 pm ...................Exhibitor Hall Closes Minis 8 am ..................... Registration Opens 5 pm ..................... Registration Closes 9 am .............................. Events Begin 7 pm ................................. Events End 10 am .................Exhibitor Hall Opens Roleplaying Prices On-Site Weekend Badge ............... $25 Seminars ......................................free On-Site 1-Day Badge (Fri, Sun) ...... $10 U-Con 6-sided dice (set of 4) ........... $1 On-Site 1-Day Badge (Sat) ............ $15 U-Con Logo bags ......................... $15 Event Tickets ................ priced by event Kid U-Con Badge (Ages 5-10): ...... $10 Living Campaign Living Generic Tickets ......................... $1.50 Shirt (M, L, XL) ............................. $22 Play Games All Weekend Ribbons ...$15 Shirt (2X, 3X, 4X) ......................... $25 Some events have higher entry fees. These events typically run for more than a standard time block or include the cost of event materials like sealed decks that participants get to keep. Please note that a badge is required to play in events. -
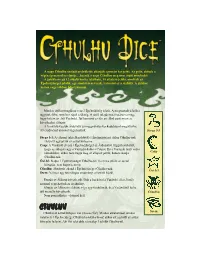
Cthulhu Dice Rules.Qxd:Layout 1
A nagy Cthulhu szolgái az őrületbe akarják egymást kergetni. Az győz, akinek a végén ép marad az elméje....hacsak a nagy Cthulhu meg nem őrjíti mindenkit. A játékban egy 12 oldalú kocka található, 18 átlátszó jelölő, amelyek az Épelméjűséget jelölik, egy simítózáras tasak, valamint ez a szabály. A játékot ketten vagy többen lehet játszani. Minden játékos magához vesz 3 Épelméjűség jelzőt. A megmaradt jelzőket tegyétek félre, nem lesz rájuk szükség. A játék tulajdonosa határozza meg, hogy ki lesz az első Varázsló. Játéksorozat esetén az előző parti nyertese következhet először. A Varázsló kijelöli Áldozatát és megpróbálja kockadobással megátkozni. Az eredményt azonnal végrehajtjuk. Sárga Jel Sárga Jel: A célpont (aki ellen dobtál) 1 Épelméjűséget áldoz Cthulhu-nak. Helyezz egy jelzőt az asztal közepére. Csáp: A Varázsló elvesz 1 Épelméjűséget az Áldozattól, függetlenül attól, hogy az áldozat vagy a Varázsló dobta a Csápot. Ha a Varázsló őrült volt a Csáp támadáskor, akkor nem kapja meg az ellopott jelzőt, hanem átadja Cthulhu-nak. Ősi Jel: Kapsz 1 Épelméjűséget Cthulhu-tól. Ha nincs jelölő az asztal közepén, nem kapsz semmit. Cthulhu: Mindenki odaad 1 Épelméjűséget Cthulhu-nak. Ősi Jel Szem: Válassz egy tetszőleges eredményt a fentiek közül. Ezután az Áldozat következik. Dob a kockával a Varázsló ellen. Ismét azonnal végrehajtjuk az eredményt. Miután az Áldozat is dobott, vége egy fordulónak, és a Varázslótól balra ülő személy következik. Cthulhu Nem passzolhatsz - dobnod kell. CCCTTTHHHUUULLLHHHUUU Szem Cthulhu az asztal közepén van (Aieeee! Ia!). Minden alkalommal, amikor valakinek 1 Épelméjűsége Cthulhu birtokába kerül, akkor azt a jelölőt az asztal közepére helyezi. Aki Ősi jelet dob, visszakap 1 jelölőt Cthulhu-tól. -

Gamestorm 13-A.Pub
www.GameStorm.org 1 Table Of Contents Information Information Welcome to GameStorm 13 2 Free Wi-Fi 2 GameStorm Needs You 2 GameStorm Policies 3 Registration 4 Info Desk 4 Check out the Game Library 4 How To Sign-Up To Play 5 Orange Cones and Open Gaming 5 People Hospitality 5 Game Master and Volunteer Rewards 6 T-Shirts, Lanyards and Dice 6 People Guest Of Honor - Lisa Steenson 8 Special Guest - Mike Stackpole 9 Game Lab 10 Video Console Gaming 10 Hotel Indie Hurricane! 11 Steve Jackson Games 11 Dealers 12 Hotel Hotel Location Maps 16 Schedule Schedule Thursday, March 24th 18 Friday, March 25th 20 Saturday, March 26th 26 Sunday, March 27th 31 Events Board and Card Games 33 Collectible Games 58 Console Gaming 61 Events Game Lab 61 Indie Hurricane! 65 Live Action Role-Playing (LARP) 68 Miniatures 70 Ongoing Role-Playing Campaigns 73 Role-Playing Games (RPG) 75 Panels 79 Committee Committee Committee Members 82 What Is OSFCI? 84 Cover art: Where can I get that game?! By: Louis Gaty and Kyle Rhône (Tinderbox Entertainment) 2 GameStorm 13 Welcome From the Chair I will assume that as you are reading this, you are recovering from a weekend of gaming and visiting friends (If you are reading the boring blurb from the chair during the con, then you should go and enjoy the con; much more fun.). I hope you enjoyed the variety of gaming opportunities represented by Indie Hurricane, Live Action Role-playing, our extensive game library, the special events centered around our Guest of Honor, Lisa Steenson, and Special Guest Mike Stackpole, as well as the wide variety of scheduled gaming. -

Steve Jackson Games
LONG BEACH COMIC CON LOGO 2014 TABLE TOP GAMING SCHEDULE STEVE JACKSON GAMES LOONEY LABS Saturday, September 12, 2015 Saturday, September 12, 2015 9:30 am – 11 am All Day Players Choice – open demos Fluxx, Loonacy, Just Desserts demos 11 am – 7 pm Pyramid games demos One More Roll!!! Players Choice, Dice Games: Mars Attacks!: The Dice Game, Mars Attacks Ten Second Take Down, Zombie Dice, Dino Hunt Sunday, September 13, 2015 Dice, Trophy Buck Dice, Chupacabra Dice, Cthulhu Dice All Day 11 am – 7 pm Fluxx, Loonacy, Just Desserts demos Munchkin (Players choice) Pyramid games demos Sunday, September 13, 2015 BROTHERWISE GAMES 9:30 am – 11 am Players Choice – open demos Saturday, September 12, 2015 11 am – 5 pm All Day One More Roll!!! Players Choice, Dice Games: Mars Attacks!: The Dice Boss Monster demos Game, Mars Attacks Ten Second Take Down, Zombie Dice, Dino Hunt Dice, Trophy Buck Dice, Chupacabra Dice, Cthulhu Dice Sunday, September 13, 2015 11 am – 5 pm All Day Munchkin (Players choice) Boss Monster demos COOL MINI OR NOT OSPREY GAMES Saturday, September 12, 2015 Saturday, September 12, 2015 10 am – 2 pm, 6 pm - 7 pm 4 pm – 6 pm Zombicide 101 – Continuous 15 minute demos In Her Majesty’s Name demos 9:30 am – 11 am, 1 pm – 2 pm Players Choice: Guilds of Cadwallon or Xenoshyft: Onslaught Sunday, September 13, 2015 11 am – 1 pm 11 am – 12 pm Xenoshyft: Onslaught game In Her Majesty’s Name demos 2 pm – 6 pm Zombicide game, Arcadia Quest game SLUGFEST GAMES Sunday, September 13, 2015 Saturday, September 12, 2015 10 am - 12 pm, 4 pm - 5 pm -
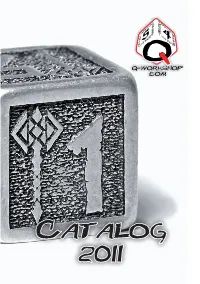
Catalog 2011 Custom Dice
Catalog 2011 Custom Dice Were You wondering what our dice would look like in other colours? Are You creating a game of your own and need somesome-- thing special and unusual for it? Ever thought abort your own personalized dice bag? Would You like to create your own dice? Q-workshop offers it’s experience and skills giving You a chance to create your very own dice and accessories, be it leather cups or bags. From the idea to the project Catching that glimpse of an idea is the most important thing when creating something new. That’s why we try to focus on the idea what You want and need – so we can provide You exactly that! From that general idea there comes the time of getting into details – creating graphic projects, choosing the ri-ri- ght patterns for dice or cups. If You already have a project – that’s great! – if not - we can help You to create one! From the project to a ready made product Our products are high quality ones – dice and cups or bags will be given our stan-stan- dard treatment giving You the guarantee of receiving a realy unusual product! The dice will be carved with high-precision machines that will truly allow your dice to achieve the amiazing level of detail! The dice are painted when the carvings are about 1mm deep so that the colours don’t wear off after even years of rolling. When it comes to price – it depends mainly on the number of dice needed, altho-altho- ugh we don’t have a minimum quantity number to create! Even creating one die is something special – and at least You and we know, that it is truly unique! And the complexicity of the design and the number of customized faces is not an issue here! We estimate the price and the time needed to complete the project individually taking into account your needs. -

Magazines V17N9.Qxd
GAMES ALLIANCE GAME DISTRIBUTORS ASMODEE EDITIONS GAMES NIGHTFALL: BLOOD COUNTRY Cities have fallen, cities have stood, but outside of those protections, humans must face the creatures of darkness on their own terms. In the lawless countryside of Nightfall, the beast within can wreak GAME TRADE MAGAZINE #141 havoc like never before! A stand-alone GTM contains articles on gameplay, expansion to the competitive deck-build- previews and reviews, game related ing game Nightfall, Blood Country brings fiction, and self contained games and you a complete, all-new set of cards with game modules, along with solicitation special powers, and features new vam- information on upcoming game releases. pires, werewolves, hunters, and ghouls. EVO GTM 141..................................$3.99 Blood Country also introduces innovative Created by Philippe Keyaerts (Small abilities for your wounds, creating new World), Evo is a game of conquest in a effects beyond those just on the card! hostile environment. To win, you will Scheduled to ship in October 2011. have to acquire genes that allow your NOT ACTUAL ART AEG 5303 ..............................$39.99 dinosaurs to evolve (survive enemy attacks, face various climates or even lay more eggs). But, be careful! Don’t 4 WINDS FANTASY GAMING ALLIANCE spend too many mutation points in the SPORTS GROUP auctions, because the winner of the US ARMY COT (78”x29”x17”) game will be the player with the most of them at the end! Scheduled to ship in Scheduled to ship in October 2011. October 2011. ASG 5582........................................PI PATHFINDER: PATHS OF ASM EVO02 ..........................$49.99 POWER 2 - PATHS OF BLOOD Compatible with the Pathfinder US ARMY TAC-110Z FLASHLIGHT Roleplaying Game, Paths of Power 2: Scheduled to ship in October 2011. -

Welcome to the Origins Pre-Registration Program Book Origins 2008 Looks to Be Another Great Year for Ori- Gins--With a Few Big Changes!
Welcome To the Origins Pre-Registration Program Book Origins 2008 looks to be another great year for Ori- gins--with a few big changes! We’ve introduced a new concept to Origins--and changed the name of the show. We at the Game Manufacturers Association (GAMA), the non-profi t trade association that looks after the interests of the game industry, started working in 2001 to really make Origins the gamer’s game convention. With the help of many GMs, clubs, volunteers, and publishers, we have accomplished this goal. No matter your type of social or hobby, non-electronic game, Origins is the place for you. Now we need to work on something else, while main- taining Origins as *the* gamer’s game con. The thing that we need in the game industry is more custom- ers--and therefore more gamers. GAMA has a num- ber of programs to help the industry with this, from our Games in Education and Games to Troops, to our partnerships with the American Library Association and with hobby and toy associations. We’re getting Origins into the act as well by inviting “the public” to enjoy our Exhibit Hall on Saturday and Sunday for only $3 a person or $10 a family. These folks will be attending Origins like it’s another of the summer fairs here in Columbus. They’ll come to learn and buy new games. Some of these folks will discover our hobby and become gamers. most of them will just discover a new world of games to enjoy and will become casual costomers of our publishers. -

Connotations Volume 21 Issue 1.Indd
Volume 21, Issue 1 February / March 2011 FREE ConNotationsThe Bi-Monthly Science Fiction, Fantasy & Convention Newszine of the Central Arizona Speculative Fiction Society A Chat with Featured Inside Regular Features Adamby ChrisNiswander Paige Special Features Not all who SF Tube Talk A Chat with wander All the latest news about Adam niswander are lost. Scienc Fiction TV shows by Chris Paige (Tolkien). by Lee Whiteside Adam Farewell Niswander, 24 Frames It’s the very nearly 50th a Phoenix- All the lastest genre movie news Anniversary of based writer, by Jeffrey Lu is the author Rocky the Flying Squirrel and of the Bullwinkle J. Moose - Part 11 supernatural Pro Notes By Shane Shellenbarger thrillers News about The Charm, An Amercan on the The Serpent genre authors and fans Slayers, Iberian Peninsula The Hound by Jeffrey Lu Hunters, Costume Closet The Sand © Michael Contos Articles Covering Topics of Plus Dwellers, interest in the constuming field The Repository, The Cost of the Tempe, AZ. FYI Cure, and most recently, The NonGenre By Genre News and tidbits of interest to fans War of the Whisperers. Some CP: So, we’re at MythosCon. Is it years ago, Adam had an Idea: what you dreamed? Non SF/F books by SF/F Authors he wished to revive the tradition AN: Yes, it is. (Laughs) Three CASFS Business Report years of getting to this point; on of a convention dedicated to the ConClusion heritage of H.P. Lovecraft. Health Thursday afternoon when it opened Club Listings issues and accompanying financial up was a really exciting day. News and Reviews Convention List & setbacks kept the Idea a ghost of SF/F conventions Generic Registration Form of a dream; nevertheless, at any CP: Did most of the invited Arizona convention you attended, authors arrive on Wednesday? MangaZone CHECK OUR WEB SITE AT there was Adam, in a wheelchair AN: The two main people, Ramsey now, still happily and eruditely Campbell and Robert Price, Reviews of Manga, Comics & Graphic For current movie reviews on socializing, the Idea alive in his came in on Tuesday, actually. -
2015 Carnage Booklet.Pub
How to Get There Killington Grand Hotel 1 -800 -621 -MTNS 4763 Killington Road, Killington, VT 05751 http://www.killington.com Driving Directions from Major Cities: Killington Resort is located in central Vermont at the junction of US 4 and VT 100 North in Killington, 11 miles east of Rutland. BOSTON MA : 3 hours driving time. Take Interstate 93 to just south of Concord, NH Exit onto Interstate 89 north and follow to US 4 Rutland, Exit 1 in Vermont. Follow US 4 west to Killington. HARTFORD CT : 3 1/4 hours driving time. Follow Interstate 91 to north of Bellows Falls, VT. Take Exit 6 (Rutland) onto VT 103 and follow to VT 100. Take VT 100 north to US 4 and follow US 4 west to Killington. 4 3/4 hrs. from NY CITY (via Connecticut Turnpike): Connecticut Turnpike (Int. 95) to Int. 91 and then follow directions given under "Hartford." NY AND NJ AREAS (via NY Thruway): 5 hours driving time. NY Thruway to Exit 24 Albany. Take Northway (Int. 87) north to Fort Ann/Rutland Exit 20. Pick up NY 149 and follow east to US 4. Turn left on US 4 and follow east to Killington. MONTREAL: 3 1/2 hours driving time. Take Highway 10 east to Highway 35 south. Exit at Route 133 south and follow to Interstate 89 south. Exit Interstate 89 at Exit 3 in Bethel, VT and follow VT 107 west to VT 100 south to Killington. Killington Grand Resort Killington, VT November 6-8 2015 2 www.carnagecon.com Welcome Join us in Killington, Vermont for the 18th annual Carnage convention, a celebration of tabletop gaming. -
Gtm193games.Pdf
GAMES ALLIANCE GAME 4 WINDS ARES GAMES DISTRIBUTORS FANTASY GAMING PATHFINDER RPG: WARRIOR PRESTIGE ARCHETYPES Scheduled to ship in April 2016. S2P 4WF209 ..............................$34.99 GAMES QUICKPICK: ISLAND OF MONSTER MASKS ARCANE WONDERS When we arrived at the Island of Monster Masks, we were welcomed by strange creatures who laughed whenever they saw us. We have begun to fit in by wearing big masks ourselves, but we can no longer discern one another among the inhabitants of this absurd island. Be the first to recognize the monster your friends are acting out in Quickpick: Island ART FROM PREVIOUS ISSUE of Monster Masks. Scheduled GAME TRADE MAGAZINE #195 to ship in January 2016. GTM contains articles on gameplay, AGS PLPL001 ........................................................................... $14.90 previews and reviews, game related fiction, and self contained games and game modules, along with solicitation ASMODEE EDITIONS information on upcoming game releases. GTM 195 .................................$3.99 MAGE WARS ACADEMY: PRIESTESS EXPANSION Summon virtuous allies, smite the wicked, ADVANCED GRAPHICS and compete to prove the way of light is absolute with the 72 spell cards featured in the Priestess Expansion, compatible with both Mage Wars Academy and Arena. Scheduled to ship in April 2016. PSI AWGMWAX01PS ..................$19.99 HISTRIO ZANY PENGUINS Come one, come all! Gather at the Faced with global warming, THEY have kingdom’s court for the Munificent only one solution: to become THE RULERS TO RESERVE IT FOR YOU! ASK YOUR LOCAL RETAILER YOU SEE ON THESE PAGES, IF YOU ARE INTERESTED IN WHAT Theatrical Festival, where cting troupes OF THE WORLD… and beyond! THEY from all over the land perform plays are equipped, trained, and intelligent of either light-hearted comedy or soul- (relatively), but the thirst for power is wrenching tragedy. -
Magazines V17N9.Qxd
GAMES ALLIANCE GAME ARES GAMES SRL BANDAI AMERICA DISTRIBUTORS GAMES NOT ACTUAL ART LORD OF THE RINGS: WAR OF THE RING 2ND EDITION GAME TRADE MAGAZINE #143 The War of the Ring has begun! The War of the Ring is a grand strategy NARUTO CCG: INVASION GTM contains articles on gameplay, board game that allows players to immerse themselves in the world of J.R.R. Featuring highly sought after cards like previews and reviews, game related Tolkien’s The Lord of the Rings and experience its epic action, dramatic con- Pain in both his Animal and Asura fiction, and self contained games and Paths, Heredical Icon “Outer Path,” flict, and memorable characters. Face the evil minions of Sauron on the field game modules, along with solicitation Almighty Push, and the first appearance information on upcoming game releases. of battle in a desperate attempt to delay their onslaught, while you lead the of Sakumo Hatake, this 100+ expansion GTM 143..................................$3.99 Fellowship of the Ring in the Quest for Mount Doom. Or, lead the hordes of to the Naruto CCG chronicles the inva- the Dark Lord and his most powerful minions as they try to bring darkness sion of the Leaf Village by Pain. Invasion 4 WINDS to Middle-earth. Hunt the Ring-bearer and bring the precious Ring to his is introduced in 50-card Theme Decks Master, or crush your enemies with your unstoppable armies! Scheduled to and 10-card boosters. Scheduled to ship FANTASY GAMING in November 2011. NOTE: This item is ship in December 2011. -

Magazines V17N9.Qxd
GAMES ALLIANCE GAME ARCANE WONDERS BANDAI AMERICA DISTRIBUTORS GAMES NARUTO CCG: SAGE’S LEGACY Introducing over 100 new cards to the Naruto CCG, Sage’s Legacy chronicles the battle between Naruto (Sage Mode) vs. Pain (Deva Path) after Pain has destroyed most of the Leaf Village. Will Pain succeed in destroying the last remnants of the Leaf Village and will Naruto CCG players master these cards to destroy their opponents? Sage’s Legacy features first appearances of Team Samui of the Cloud Village (Karui, NOT ACTUAL ART Omoi, and Samui), as well as other GAME TRADE MAGAZINE #147 highly sought after cards including the GTM contains articles on gameplay, 6th Hokage, a Super Rare Hinata previews and reviews, game related MAGE WARS Hyuga, and Pain’s Catastophe Planetary fiction, and self contained games and Hurl Lightning Bolts! Summon Mythical Creatures! Cast Sinister Curses! In Construction Jutsu! Scheduled to ship in game modules, along with solicitation Mage Wars, players take on the role of powerful mages, stepping into an February 2012. NOTE: This item is sold information on upcoming game releases. arena to battle for supremacy. Choose between a Wizard, Warlock, to retailers in full displays. Please contact your retailer for availability. GTM 147..................................$3.99 Beastmaster, or Priestess, each with their own unique strategies and style of BOOSTER DISPLAY (24) play; conjure your custom spellbook from over 300 spells; and let the BAI 23632-D ..........................$95.76 ALDERAC battle ignite! Scheduled to ship in May 2012. BOOSTER PACK ENTERTAINMENT GROUP ELF AWG1010 ..........................................................................$75.00 BAI 23632-S ............................$3.99 BATTLEFRONT THE ARMY PAINTER MINIATURES WARGAMES ILLUSTRATED #296 Scheduled to ship in May 2012.