Enzo Bona, Alberto Bonacina, Giancarlo Donadelli, Germano
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Statuto Comunale
Delibere nn. 13 e 23 del 11/9/1191 e del 14/12/1991. Fuipiano Valle Imagna (BG) STATUTO Art. 40 – Consorzi ——— • ——— Art. 41 – Unione dei comuni Art. 42 – Accordi di programma INDICE ELEMENTI COSTITUTIVI Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE Art. 1 – Principi fondamentali Art. 2 – Finalita` Art. 43 – Partecipazione Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione Art. 4 – Territorio e sede comunale Capo I Art. 5 – Albo pretorio Iniziativa politica e amministrativa Art. 6 – Stemma e gonfalone Art. 44 – Interventi nel procedimento amministrativo PARTE I Art. 45 – Diritto d’istanza ORDINAMENTO STRUTTURALE Art. 46 – Diritto di petizione Art. 47 – Diritto di iniziativa Titolo I ORGANI ELETTIVI Capo II Art. 7 – Organi Associazionismo e partecipazione Art. 8 – Il Consiglio comunale Art. 48 – Principi generali Art. 9 – Funzioni di indirizzo politico-amministrativo Art. 49 – Associazioni Art. 10 – Funzioni di controllo politico-amministrativo Art. 50 – Organismi di partecipazione Art. 11 – Gli atti fondamentali Art. 51 – Incentivazioni Art. 12 – Le nomine dei rappresentanti Art. 52 – Partecipazione alle commissioni Art. 13 – Prerogative e compiti dei consiglieri c.li Art. 14 – I gruppi consiliari e la conferenza dei capo- gruppo Capo III Art. 15 – Commissioni consiliari permanenti Referendum-Diritti di accesso Art. 16 – Iniziativa delle proposte Art. 53 – Referendum consultivo Art. 17 – Norme generali di funzionamento Art. 54 – Diritti di accesso Art. 18 – Commissioni speciali Art. 55 – Diritto di informazione La giunta comunale Titolo III Art. 19 – Funzioni FUNZIONE NORMATIVA Art. 20 – Elezioni e prerogative Art. 21 – Composizione Art. 56 – Statuto Art. 22 – Funzionamento della Giunta Art. 57 – Regolamenti Art. 23 – Attribuzioni Art. 58 – Adeguamento delle fonti normative comunali Art. -

A Hydrographic Approach to the Alps
• • 330 A HYDROGRAPHIC APPROACH TO THE ALPS A HYDROGRAPHIC APPROACH TO THE ALPS • • • PART III BY E. CODDINGTON SUB-SYSTEMS OF (ADRIATIC .W. NORTH SEA] BASIC SYSTEM ' • HIS is the only Basic System whose watershed does not penetrate beyond the Alps, so it is immaterial whether it be traced·from W. to E. as [Adriatic .w. North Sea], or from E. toW. as [North Sea . w. Adriatic]. The Basic Watershed, which also answers to the title [Po ~ w. Rhine], is short arid for purposes of practical convenience scarcely requires subdivision, but the distinction between the Aar basin (actually Reuss, and Limmat) and that of the Rhine itself, is of too great significance to be overlooked, to say nothing of the magnitude and importance of the Major Branch System involved. This gives two Basic Sections of very unequal dimensions, but the ., Alps being of natural origin cannot be expected to fall into more or less equal com partments. Two rather less unbalanced sections could be obtained by differentiating Ticino.- and Adda-drainage on the Po-side, but this would exhibit both hydrographic and Alpine inferiority. (1) BASIC SECTION SYSTEM (Po .W. AAR]. This System happens to be synonymous with (Po .w. Reuss] and with [Ticino .w. Reuss]. · The Watershed From .Wyttenwasserstock (E) the Basic Watershed runs generally E.N.E. to the Hiihnerstock, Passo Cavanna, Pizzo Luceridro, St. Gotthard Pass, and Pizzo Centrale; thence S.E. to the Giubing and Unteralp Pass, and finally E.N.E., to end in the otherwise not very notable Piz Alv .1 Offshoot in the Po ( Ticino) basin A spur runs W.S.W. -

L'alpeggio Nelle Alpi Lombarde Tra Passato E Presente
L’ alpeggio nelle Alpi lombarde tra passato e presente di Michele Corti* Sommario 1. Introduzione: tra presente e passato 2. Il dualismo delle voci “alpe” e “malga” in Lombardia (alcuni aspetti linguistici) 3. Tipologie insediative e strutture edilizie d’alpeggio 4. La migrazione alpina (spostamenti tra una valle e l’altra) 5. Proprietà delle alpi: aspetti storici 6. I conflitti sui diritti d’alpeggio 7. Forme di gestione e modalità di fruizione dei diritti di pascolo nel medioevo e nell’età moderna (statuti) 8. Tra XIX e XX secolo: le conseguenze sul sistema d’alpeggio della rottura di equilibri economici e demografici e dei cambiamenti politici 9. Spirito individualistico e spirito associativo nella gestione degli alpeggi sino alla metà del XX secolo 10. Credenze, leggende, riti 11. Gli sviluppi dalla seconda metà del XX secolo ad oggi: passato e presente Bibliografia * una versione del presente saggio è stata pubblicata in: SM Annali di San Michele, vol. 17, 2004, pp. 31- 155 1. Introduzione: tra presente e passato Nell’immaginario turistico le alpi pascolive sono maggiormente associate ad altre regioni dell’Arco Alpino piuttosto che alla Lombardia; eppure, secondo stime dei servizi veterinari regionali, riferite al 20011, ben il 46% di esse si trovavano in Lombardia, che ne conta ben 612, contro 409 di Piemonte e Valle d’Aosta e 306 del Triveneto. Secondo le stesse fonti, in Lombardia si trasforma il 30% di tutto il latte prodotto e lavorato nelle alpi pascolive dell’Arco Alpino, ma è caricato solo il 13% di tutti i capi bovini alpeggiati. -

Quaderni Brembani 19 28/10/20 09.34 Pagina 1
Quaderni Brembani 19 28/10/20 09.34 Pagina 1 QUADERNI BREMBANI19 CORPONOVE Quaderni Brembani 19 28/10/20 09.34 Pagina 2 QUADERNI BREMBANI Bollettino del Centro Storico Culturale Valle Brembana “Felice Riceputi” Viale della Vittoria, 49, San Pellegrino Terme (BG) Tel. Presidente: 366-4532151; Segreteria: 366-4532152 www.culturabrembana.com [email protected] [email protected] [email protected] Cultura Brembana Coordinamento editoriale: Arrigo Arrigoni, Tarcisio Bottani IN COPERTINA: Boscaioli dell’Alta Valle Brembana con attrezzo tirafili (fine XIX - inizio XX sec). Dalla mostra “Il fotografo ritrovato, la Valle Brembana, e non solo, nelle fotografie di Andrea Milesi di Ornica (1867-1938)” Corponove BG - novembre 2020 Quaderni Brembani 19 28/10/20 09.34 Pagina 3 CENTRO STORICO CULTURALE VALLE BREMBANA “Felice Riceputi” QUADERNI BREMBANI19 Anno 2021 Quaderni Brembani 19 28/10/20 09.34 Pagina 4 CENTRO STORICO CULTURALE VALLE BREMBANA “FELICE RICEPUTI” Consiglio Direttivo Presidente: Tarcisio Bottani Vice Presidente: Simona Gentili Consiglieri: Giacomo Calvi Erika Locatelli Mara Milesi Marco Mosca Antonella Pesenti Comitato dei Garanti: Lorenzo Cherubelli Carletto Forchini Giuseppe Gentili Collegio dei Revisori dei Conti: Raffaella Del Ponte Pier Luigi Ghisalberti Vincenzo Rombolà Segretario: GianMario Arizzi Quaderni Brembani 19 28/10/20 09.34 Pagina 5 Quaderni Brembani 19 Sommario Le finalità del CENTRO STORICO CULTURALE 9 VALLE BREMBANA “FELICE RICEPUTI” (dall’atto costitutivo) Sostenitori, collaboratori e referenti 10 Presentazione 11 Attività dell’anno 2020 12 Il fotografo ritrovato 18 La Valle Brembana, e non solo, nelle fotografie di Andrea Milesi di Ornica (1867-1938), scattate tra il 1890 e il 1910 a cura del Direttivo Bortolo Belotti. -

Skitouren Am Comer See Freudenschwünge Über Dem Lario
Skitouren am Comer See FREUDENSCHWÜNGE ÜBER DEM LARIO Der Comer See – oder „Lario“ – bietet Besuchern nicht nur malerische Dörfer und exzellente italienische Gastronomie in den Restaurants und Bars an seinem Ufer. Er ist von Bergen umrahmt, die zu Skitouren mit prächtigen Ausblicken einladen. Wenn genug Schnee liegt ... Text und Fotos von Christine Kopp ller Anfang ist schwer. Das gilt gebot an Literatur ist spärlich. Immerhin Dörfer und Berge oder wegen des einzig- auch, wenn man sich den Ski- ist rechtzeitig zur Saison ein neuer Skitou- artigen Gefühls, das sich durch die Ver- touren am Comer See annähert: ren-Führer erschienen (siehe Infokasten). bindung einer Skitour mit Cappuccino Nicht jeder Winter hier ist Wer die Hürden überwindet – auch dank und Brioche am Seeufer davor und italie- Aschneesicher, die Schneelage kann sich der stets hilfsbereiten Einheimischen –, nischer Kulinarik danach einstellt. Rich- schnell verändern und ist oft stark vom wird allerdings begeistert sein: etwa we- tig mediterran, und das hier, im Norden Nordwind beeinflusst, die Anfahrten sind gen der herrlichen Aussicht von einem der Lombardei. Und was den vielseitigen nicht ganz einfach zu finden, und das An- Gipfel wie dem Monte Bregagno auf See, Bergsportler freuen dürfte: Hier kann 84 DAV 1/2014 Comer See REPORTAGE FREUDENSCHWÜNGE ÜBER DEM LARIO man in guten Wintern durchaus einen kenwald hinter sich, geht es in offenem gang aufsteigen: Der Blick schweift von Skitouren-Urlaub mit einem Tag Klettern Gelände entlang des Dosso di Naro hoch. dem Rücken über die Schneekuppen, die im ärmellosen Shirt verbinden, etwa am Man möchte am liebsten im Rückwärts- hier oft vom Nordwind gewellt sind, hin- sonnenverwöhnten Sasso di Pelo in der unter zum See mit seinen eng verschach- Gemeinde von Gravedona oder an der telten Dörfern. -

L'italie Et Ses Dialectes
L’Italie et ses dialectes Franck Floricic, Lucia Molinu To cite this version: Franck Floricic, Lucia Molinu. L’Italie et ses dialectes. Lalies (Paris), Paris: Presses de l’Ecole normale supérieure, 2008, 28, pp.5-107. halshs-00756839 HAL Id: halshs-00756839 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00756839 Submitted on 26 Nov 2012 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. LALIES 28 L’ITALIE ET SES DIALECTES1 FRANCK FLORICIC ET LUCIA MOLINU 0. INTRODUCTION GÉNÉRALE En dépit du fait que les langues romanes soient particulièrement bien étudiées et, généralement, bien connues dans leurs structures fondamentales, le domaine linguistique italien reste pour une grande part à défricher. Rohlfs observait que peu de domaines linguistiques offrent une fragmentation et une hétérogénéité analogues à celles que présente le domaine italo-roman. Inutile de dire dans ces conditions qu’il est impossible de rendre compte – même en ayant à sa disposition plus d’espace qu’à l’accoutumée – d’une telle diversité et d’une telle variété ; il va sans dire aussi qu’un article de synthèse ne peut que décevoir le lecteur désireux d’y trouver une description exhaustive des caractéristiques de tel ou tel dialecte. -

Alchemilla Sulle Alpi Italiane: Alpi Retiche Meridionali, Prealpi Lombarde Centrali E Orientali
InFORMAtORE BOtAnICO ItALIAnO, 44 (1) 3-73, 2012 3 Contributo alla conoscenza del gen. Alchemilla sulle Alpi Italiane: Alpi Retiche Meridionali, Prealpi Lombarde Centrali e Orientali S.E. FRöhnER, E. BOnA, G. FEdERICI e F. MARtInI ABStRACt - Contribution to the knowledge of Genus Alchemilla in the Italian Alps: Southern Rhaetian Alps, Central and Eastern Lombard Pre-Alps -.this paper endeavours to improve the knowledge of the genus Alchemilla in the flora of Eastern Lombardy. thanks to intensive collection over the last 20 years, the number of verified species is now 50, as theoretically expected for the territory investigated (11 other species quoted for the same area are awaiting confirmation). 3 species are new for the flora of Italy: Alchemilla croatica, A. rhododendrophila and A. lucida. 3 other species, endemic, have been recently described as new: A. bonae, A. federiciana and A. martinii. Ecological as well as phyto-historical issues (chorology and speciation centres) concerning local Alchemilla-flora are also discussed. Synoptic tables, schemes of the main mor- phological characters and pictures regarding the basal leaves of 16 particularly interesting species, may make the often dif- ficult identification of the species easier. ZuSAMMEnFASSunG - Beitrag zur Kenntnis der Gattung Alchemilla in den Italienischen Alpen: Südliche Rhätische Alpen, Zentral und Östliche Lombardische Voralpen - die Arbeit bemüht sich um eine verbesserte Kenntnis der Alchemilla- Flora der Ost-Lombardei. durch intensive Sammeltätigkeit konnte die Anzahl der im Gebiet angegebene Arten auf 50 erhöht werden (Allerdings konnten 11 weitere für das Gebiet angegebene Arten weder durch herbarbelege noch durch Funde im Gelände bestätigt werden). damit ist eine Größenordnung erreicht, die man für d as Gebiet erwarten kann. -

(323) Topografie, Morfologie, Onderzoekingen
BIJDRAGE TOT DE GEOLOGIE DEB BEBGAMASKEE ALPEN. No. 7*). De geologie van den Cimone di Margno en den Monte di Muggio DOOR W.L. Buning Met plaat 23 en 24. Inhoud. pag. I. Algemeene inleiding 3 (323) Topografie, morfologie, onderzoekingen, enz. 3 vroegere . (323) II. Stratigrafie en petrografie 10 (330) 1. Het kristallyne grondgebergte 10 (330) la. De metamorfe gesteenten 10 (330) A. Gneiss-chiari 11 (331) B. Paragesteenten 14 (334) 16. De stollingsgesteenten 17 (337) A. de Stroomgebied van Marcia 17 (337) B. Stroomgebied van den Biagio 20 (340) C. de Stroomgebied van Rossiga 22 (342) 2. Het Perm 29 (349) 3. Het Werfenien 30 (350) 4. Het Kwartair 34 (354) A. Diluvium 34 (354) Vergletscheringen 35 (355) B. Alluvium 36 (356) Aanhangsel: Nuttige delfstoffen 37 (357) III. overzicht Historisch-geologisch 41 (361) IV. tektoniek Geologie en 43 (363) A. het Beschouwing van gebied aan de hand van kaart en profielen 43 (363) B. Aard der verschuivingen en schubben 58 (378) V. Tektonisch overzicht 61 (381) A. De bouw den der van ondergrond Bergamasker Alpen 61 (381) B. Verschuivingen en schubben in de Bergamas-ker Alpen 62 (382) C. Omliggende gebieden 66 (386) Résumé en français 72 (392) Litteratuurlijst 77 (397) verschenen: No. *) Kccds 1: J. Cosijn, „De Geologie van de Valli di Olmo al Brembo" (lat. 7). No. 2: W. J. Jong, „Zur Geologie der Bcrgamasker Alpen, des Val No. 3: nördlich Stabina" (Lit. 26). Th. H. F. Klompô, „Die Geologie des Val Mora und Val des Brembo di Mczzoldo" (Lit. 27). No. 4: J. H. L. Wennekeks, het Val Brembo di „De geologie van Foppolo en de Valle di Carisole" (Lit. -
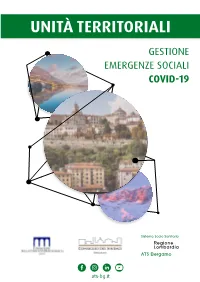
Unità Territoriali
UNITÀ TERRITORIALI GESTIONE EMERGENZE SOCIALI COVID-19 ats-bg.it UNITÀ TERRITORIALI PER L’EMERGENZA SOCIALE COVID-19 CHE COSA SONO Le UTES sono realtà sovra comunali nate nella provincia di Bergamo per supportare i servizi sociali comunali nella gestione dell’attuale situazione di emergenza sociale correlata al Covid-19. Nella bergamasca sono attive 14 UTES, la cui gestione è affidata alle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti distrettuali/Territoriali e ai loro Uffici di Piano, strutture istituzionali e tecniche già da vent’anni strutturate in dimensione sovra comunale per la programmazione sociale in forma associata nei Piani di Zona, in virtù della Legge 328/00 e della Legge regionale 3/2008. Le UTES sono coordinate da Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e da ATS Bergamo, per il tramite dell’Ufficio Sindaci. ll progetto è finanziato con risorse pubbliche e private raccolte grazie all’impegno della Fondazione della Comunità Bergamasca, tra cui il Fondo corrente della Conferenza dei Sindaci. CHE COSA FANNO Attività di informazione Attraverso l’attivazione di un call center e la messa in rete dei contatti dei singoli Comuni, viene attivato un servizio telefonico di ascolto e informazione ai cittadini, per le esigenze sociali (anche in lingua straniera e durante il week end); Sostegno alla fragilità Presa in carico e gestione dei bisogni sociali delle persone Covid-19 dimesse dagli ospedali e gestione di un servizio domiciliare sociale di supporto per la persona e la sua famiglia, in particolare per le situazioni di estrema fragilità (assistenza domiciliare, consegna pasti, spesa e farmaci a domicilio, acquisto di generi alimentari per le persone in difficoltà economica, trasporto sociale…); Supporto alla Logistica Distribuzione dei Dispositivi di Protezione individuale (DPI) alle persone in isolamento domiciliare obbligatorio, agli operatori sociali e di volontariato impegnati nell’assistenza sociale alle persone. -

Dgr 11 Luglio 2014
– 2 – Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 16 luglio 2014 • alla determinazione di un livello di classificazione sismica C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI maggiormente cautelativo rispetto a quello vigente; D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 • all’aggiornamento della classificazione del territorio lom- Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. bardo, anche in funzione del riordino delle disposizioni 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d) della normativa regionale in materia di vigilanza e con- trollo sulle costruzione in Zona sismica; LA GIUNTA REGIONALE Preso atto che il Gruppo di Lavoro interdirezionale «Coordina- Richiamati: mento azioni sul rischio sismico», costituito con decreto n. 8448 • il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento del 23 settembre 2013 del Direttore Generale della D.G. Sicu- di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni rezza, Protezione Civile e Immigrazione, ha elaborato, come da ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 verbale del 9 aprile 2014, una proposta di aggiornamento della marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 54 comma 1 lett. classificazione sismica regionale approvata dalla richiamata c), ai sensi del quale sono mantenute in capo allo Stato le d.g.r. 14964/2003; funzioni relative alla predisposizione della normativa tecni- Preso atto che le competenti Direzioni Generali: ca nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche nonché i criteri generali • hanno valutato la nuova classificazione coerente con le per l’individuazione delle zone sismiche, delegando altre- specificità del territorio lombardo, anche in considerazio- sì alle Regioni le funzioni relative all’individuazione delle ne della presenza di aree fortemente antropizzate e del zone sismiche, alla formazione e all’aggiornamento degli patrimonio storico esistente, nonché con la classificazione elenchi delle medesime; delle Regioni confinanti; • la legge regionale 5 gennaio 2000 n. -

Administrative Units of the Alpine Convention Alpine the of Units Administrative Alpine Signals 1 Signals Alpine 21
Administrative Units of the Alpine Convention Administrative Units Alpine signals 1 21 Scope of application of the Alpine Convention Administrative Units LIST OF ADMINistrative UNITS OF THE ALPINE CONVENTION IN 1) According to the Federal Official Journal (of the Republic of Austria) THE REPUBLIC OF AUSTRIA III vol. 18/1999 from 01.28.1999. Federal state of Strobl Weißpriach VORARLBERG Thalgau Zederhaus all municipalities Wals-Siezenheim District of Zell am See F e d e r a l s t a t e o f T Y R O L District of Sankt Johann im Pongau Bramberg am Wildkogel all municipalities Altenmarkt im Pongau Bruck an der Großglockner- straße Bad Hofgastein Federal state of Dienten am Hochkönig CARINTHIA Badgastein Bischofshofen Fusch an der Großglockner- all municipalities straße Dorfgastein Hollersbach im Pinzgau Eben im Pongau Federal state of Kaprun SALZBURG Filzmoos Flachau Krimml Lend Salzburg (town area) Forstau Goldegg Leogang District of Hallein Großarl Lofer Hüttau Maishofen Abtenau Maria Alm am Steinernen Adnet Hüttschlag Kleinarl Meer Annaberg im Lammertal Mittersill Golling an der Salzach Mühlbach am Hochkönig Pfarrwerfen Neukirchen am Großvene- Hallein diger Krispl Radstadt Sankt Johann im Pongau Niedernsill Kuchl Piesendorf Oberalm Sankt Martin am Tennen- gebirge Rauris Puch bei Hallein Saalbach-Hinterglemm Rußbach am Paß Gschütt Sankt Veit im Pongau Schwarzach im Pongau Saalfelden am Steinernen Sankt Koloman Meer Scheffau am Tennengebirge Untertauern Sankt Martin bei Lofer Vigaun Wagrain Stuhlfelden District Werfen Taxenbach Salzburg/Surrounding -

Indirizzi Delle Sedi Distrettuali Dell'asl Di
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo Via Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo - C.F. e P.I. 02584740167 INDIRIZZI DELLE SEDI DISTRETTUALI DELL’ASL DI BERGAMO E ELENCO COMUNI DEL TERRITORIO CON RELATIVI AMBITI DI ZONA E DISTRETTUALI Asl della Provincia di Bergamo Indirizzi Sedi DISTRETTO SOCIO SANITARIO Distrettuali DELLA VALSERIANA E VAL DI SCALVE SEDE DI ALBINO Viale Stazione, 26/a DISTRETTO SOCIO SANITARIO Tel. 035/759704 DI BERGAMO Fax 035/774304 SEDE DI BORGO PALAZZO Via Borgo Palazzo, 130 SEDE DI CLUSONE Tel. 035/2270317 – 351 Via Matteotti, 11 Fax 035/2270637 TEL. 0346/89042 Fax 0346/89027 DISTRETTO SOCIO SANITARIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI DALMINE SEDE DI DALMINE DELLA VALBREMBANA E Viale Betelli,1 VALLE IMAGNA Tel. 035/378119-131 SEDE DI ZOGNO Fax 035/562117 Via Paolo Polli Tel. 0345/59119 DISTRETTO SOCIO SANITARIO Fax 0345/94478 DELL’ EST-PROVINCIA SEDE DI VILLA D’ALMÈ SEDE DI SERIATE Via Roma, 16 Via Paderno, 40 Tel. 035/634611-612 Tel. 035/3235054/055 Fax 035/544509 Fax 035/3235059 SEDE DI GRUMELLO DISTRETTO SOCIO SANITARIO Via Nembrini, 1 DELL’ ISOLA BERGAMASCA Tel. 035/8356330-320 SEDE DI PONTE SAN PIETRO Fax 035/4420339 Via Caironi, 7 Tel. 035/603247 - 603312 SEDE DI TRESCORE Fax 035/603343 Via Mazzini, 13 Tel. 035/955423 DISTRETTO SOCIO SANITARIO Fax 035/944552 DELLA BASSA BERGAMASCA SEDE DI SARNICO SEDE DI TREVIGLIO Via Libertà, 37 Via Matteotti, 4 TEL. 035/911038 Tel. 0363/424228 Fax 035/910638 Fax 0363/305423 SEDE DI LOVERE SEDE DI ROMANO Piazzale Bonomelli Via Balilla, 25 Tel.