I Luoghi Dell'acqua
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sondrioand VALMALENCO a UNIQUE VALLEY for YOUR HOLIDAYS
SONDRIOand A UNIQUE VALLEYVALMALENCO FOR YOUR HOLIDAYS SONDRIOand VALMALENCO A UNIQUE VALLEY FOR YOUR HOLIDAYS From the river Adda to according to the altitude and the exposure. and raw material for the processing of the To the left for those travelling from Lake grapes. 4000 m of Bernina Peak Como, the sunny rhaetic slope, where ancient Further up the dark band of fir-woods, Thank to its morphology and its geographical terraces supported by characteristic drystone refuge of a rich wildlife, gradually fading in position, the valley around Sondrio offers a walls get back on top to 700 metres: 25 miles vast stretches of alpine meadows and nival huge range of views where human activities of vineyards now clung on rocky crags to amphitheatres. and ecosystem are perfectly mixed. exploit even the smallest indentations now From cultivated fodder plants that serve as lying on the more docile slope in relaxing A charming Alpine Valley. frame to the river Adda, from the apple- parallel sequences of terracing, testimony orchards in orderly rows on the cones of the of stubborn willingness of peasant. In valley bottom You climb up to the castings front, facing north, the shaded side orobico of the glaciers and to the rocks of the characterized by thick mantle of chestnut uncontaminated crests. In the middle, the rich trees that for centuries have accompanied the variety of diversified vegetable environments lives of villagers, ensuring their sustenance TRADITIONS AND ANCIENT TYPICAL TASTES SONDRIOAt the Centre of Valtellina, wedged between "Palazzo Sertoli" with the beautiful frescoed the Rhaetic Alps and the Orobiche, lies the saloon or "Palazzo Martinengo" built in the city of Sondrio. -

Elenco Alpeggi Aderenti
Gli Alpeggi coinvolti Alpeggio Comune Nominativo Azienda Agricola Alpe Mastabbia Com. Spriana Soc. Agricola “Tre Effe” di Faldrini Mirko e Faldrini Giulia Alpe Airale Com. Spriana Soc. Agricola “Tre Effe” di Faldrini Mirko e Faldrini Giulia Alpe Oro Com. Chiesa Val. Soc. Agricola F.lli Lenatti Alberto e Claudio Alpe Sentieri Com. Chiesa Val. Soc. Agricola Lenatti Lorenzo e Dario Alpe Fora Com. Chiesa Val. Azienda Agricola Lenatti Rodolfo Alpe Entova Com. Chiesa Val Azienda Agricola Stella Alpina di Sem Manuela Alpe Palù Com. Chiesa Val. Azienda Agricola Sem Alberto Alpe Arcoglio Com. Torre S.M. Azienda Agricola Vanotti Antonietta Alpe Arcoglio Com. Torre S.M. Azienda Agricola “Libera” di Marchesini Silvia 1 Alpe Campagneda Com. Lanzada Soc. Agricola “Pizzo Scalino” di Nani Leonardo Alpe Campagneda Com. Lanzada Soc. Agricola “Il Cornetto” di Nani Mariapia Alpe Campagneda Com. Lanzada Azienda Agricola Bergomi Simone Alpe Campagneda Com. Lanzada Azienda Agricola Bergomi Giuseppe Alpe Campagneda Com. Lanzada Azienda Agricola Lenatti Giulia Alpe Valposchiavina Com. Lanzada Soc.Agricola “La Selvaggia Poschiavina”di Nana Antonio e Mario Alpe Gembrè Com. Lanzada Azienda Agricola Gianoli Rosa Alpe Fellaria Com. Lanzada Azienda Agricola Rossi Stefano Alpe Prabello Com. Caspoggio Azienda Agricola Negrini Maurizio Alpe Stabello 1-2 Com. Cedrasco Società Agricola Capanno di Eredi Capelloni e C Snc Alpe Caprarezza 1-2 Com. Cedrasco Alpe Valcervia Com. Colorina Soc. Agricola F.lli Codega Michele e Sergio Piana dx/sx-Sasso Chiaro Com. Caiolo Azienda Agricola Bianchini Plinio Alpe Meriggio Com. Albosaggia Azienda Agricola Menghi Moreno Lago della Casera Com.Albosaggia Azienda Agricola “Stella Orobica” di Murada Alpe Campo Cervè Com. -
LANZADA, Sabato 28 Agosto 2021
Con il patrocinio: CAI Club Alpino Italiano Sezione Valtellinese di Sondrio Fondazione Bombardieri In collaborazione con: Comune di Lanzada CAI Club Alpino Italiano Sede Centrale La Fondazione Luigi Bombardieri e la Sezione Valtellinese del CAI di Sondrio ORGANIZZANO LA PICA DE CRAP IL MOSCHETTONE DELLA SOLIDARIETÀ LANZADA,& Sabato 28 Agosto 2021 IN LOCALITÀ PRADASC DI LANZADA PROGRAMMA: SABATO 28 AGOSTO 2021 ORE 16:30: 9a Edizione 7a Edizione de “LA PICA DE CRAP” de “IL MOSCHETTONE DELLA SOLIDARIETÀ” consegna del premio a Anna Torretta consegna del premio alla (una delle più forti alpiniste italiane VII delegazione Valtellina e Valchiavenna del momento, prima donna Guida Alpina del Soccorso Alpino Italiano, di Courmayeur) sarà presente Incontro con Anna Torretta Valerio Rebai, capo delegazione. ALBO D’ORO PICA DE CRAP: ALBO D’ORO MOSCHETTONE Hanno garantito a 1 Ed. Kurt Diemberger DELLA SOLIDARIETÀ: la loro presenza 2a Ed. Silvio Mondinelli (Gnaro) 1a Ed. Mario Corradini alcuni dei vincitori 3a Ed. Sergio Martini 2a Ed. Associazione Bianco delle passate edizioni. 4a Ed. Elio Orlandi 3a Ed. Maurizio Folini 5a Ed. Simone Moro 4a Ed. Soccorso Alpino Deleg. Abruzzo Presentano: 6a Ed. Mario Conti 5a Ed. Marco Confortola FILIPPO ZOLEZZI, 7a Ed. Krzysztof Wielicki a ANGELO SCHENA 6 Ed. Associazione Mato Grosso E LUCA CALVI 8a Ed. Hervè Barmasse In caso di emergenze dovute al Covid, l’organizzazione si riserva OFFICINA • GOMMISTA • TAXI T. 0342 453041 di spostare l’evento in altro luogo o di annullarlo. M. 347 8820941 - 339 2819731 In caso di pioggia la manifestazione si terrà presso la “Sala Maria Via Pizzo Scalino, 144 23020 Lanzada (SO) [email protected] Ausiliatrice” di Lanzada. -

Assobike Junior Circuit 2017
ASSOBIKE JUNIOR CIRCUIT 2017 G 1 - MASCHILE Tovo S.Agata Mantello Robbiate Albiolo Casatenovo Barni Lanzada Bosisio Par. Valdidentro Grosio Cantu' Talamona TOTALE SCARTI TOTALE 1-mag-17 7-mag-17 28-mag-17 4-giu-17 11-giu-17 18-giu-17 2-lug-17 9-lug-17 16-lug-17 3-set-17 17-set-17 24-set-17 1 PIROVANO MATTIA U.S. CASSINA DE' BRACCHI A.S.D. 20 20 40 0 40 2 PRINA ALESSANDRO S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 12 17 29 0 29 3 RINALDI SAMUELE MELAVI' FOCUS BIKE A.S.D. 17 11 28 0 28 3 ROCCA MATTEO VALDIDENTRO BIKE TEAM 14 14 28 0 28 5 GIACOMELLI LORENZO VALDIDENTRO BIKE TEAM 11 10 21 0 21 6 PINI SIMONE ANTONIO MELAVI' FOCUS BIKE A.S.D. 8 12 20 0 20 7 FERRIOLO PAOLO TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 9 7 16 0 16 8 BRACCHI MATTIA VALDIDENTRO BIKE TEAM 5 8 13 0 13 9 LANFRANCHI MATTEO VALDIDENTRO BIKE TEAM 5 6 11 0 11 10 ANTICO VINCENZO MELAVI' FOCUS BIKE A.S.D. 10 10 0 10 10 TRAMERI LUCA VALDIDENTRO BIKE TEAM 5 5 10 0 10 10 SARTORI VITTORIO PAOLO MELAVI' FOCUS BIKE A.S.D. 5 5 10 0 10 13 PIN GABRIELE TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD 9 9 0 9 14 MAROTTA GIUSEPPE VALDIDENTRO BIKE TEAM 7 7 0 7 15 ARRIGONI LORENZO U.C. COSTAMASNAGA A.S.D. 6 6 0 6 16 LANFRANCHI NATAN VALDIDENTRO BIKE TEAM 5 5 0 5 16 VALGOI SIMONE VALDIDENTRO BIKE TEAM 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 G 1 - FEMMINILE Tovo S.Agata Mantello Robbiate Albiolo Casatenovo Barni Lanzada Bosisio Par. -

Inverno 2019-2020
...e non solo inverno 2019-2020 www.sondrioevalmalenco.it Ufficio di Sondrio Ufficio della Valmalenco [email protected] Consorzio Turistico Via Tonale 13 Loc. Vassalini tel. +39 0342 451150 Sondrio e Valmalenco 23100 Sondrio 23023 Chiesa V. fax +39 0342 573472 La casa di Babbo Natale La casa di Babbo Natale domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 sabato dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Presso la casetta in legno al centro sportivo Presso la casetta in legno al centro sportivo 7/12 Zenith di Caspoggio - Info 346 9692689 8/12 Zenith di Caspoggio - Info 346 9692689 Caspoggio Caspoggio giovedì Invecchiare con gustoTECA Mercatini di Natale ore 21.00 - TECA spettacolo per bambini, cioccolata, vin brulé, 12/12 Chiesa in Valmalenco sabato caldarroste e pasticcini dalle ore 15.00 alle ore 20.00 7/12 Piazza della Chiesa Concerto “Legami vocali” E20Lanzada venerdì Coro lirico Valtellina - Coro CAI Valmalenco Lanzada e Coro Armonie in voce 13/12 ore 21.00 - Santuario di Primolo Chiesa in Valmalenco Winter Opening Aperitivo d’inaugurazione “Viaggio sul tappeto sabato della stagione invernale delle storie” 7/12 ore 17.00 - Via Roma martedì Lettura ad alta voce Pro Loco ore 16.00-17.00: bambini dai 3 ai 6 anni Chiesa in Valmalenco 17/12 ore 17.00-18.00: bambini dai 7 agli 11 anni Piazza della Chiesa Biblioteca - 0342 453243 Lanzada “Vietato morire” sabato Spettacolo teatrale contro la violenza sulle donne. Tratto da due storie realmente accadute “Il mio viaggio in Valtellina” 7/12 ore 21.00 venerdì ThomAS RUberto -

LANZADA (SO) 15-16 Marzo 2014 37° Campionato Nazionale ANA Sci Alpinismo LANZADA 15-16 Marzo 2014
Associazione Nazionale Alpini SEZIONE VALTELLINESE DI SONDRIO www.alpinisondrio.it GRUPPO DI LANZADA LANZADA www.sportivalanzada.it 37° CAMPIONATO NAZIONALE ANA SCI ALPINISMO LANZADA (SO) 15-16 MARZO 2014 37° CAMPIONATO NAZIONALE ANA SCI ALPINISMO LANZADA 15-16 MARZO 2014 Comunità Montana Provincia Valtellina di Sondrio di Sondrio Unione dei Comuni Lombarda Unione dei Comuni Comune della Valmalenco di Spriana e di Torre di Santa Maria di Lanzada Parolini Gino CASALINGHI FERRAMENTA VERNICI LAVECC (Pentole in Sasso) CUCINE, STUFE E CAMINI A LEGNA E A PELLETS LANZADA - Via Pizzo Scalino, 212 - Tel. e Fax 0342.45.31.56 - www.parolinigino.com PUNTI VENDITA: LANZADA: Via Palù 207 - CHIURO: Via IV Novembre, 22-24 MARMVia Bernina,I 1270M - Loc. Le AUPrese - 23020 LanzadaR (SO) - IItaly Tel.: +39 0342 451866 Fax: +39 0342452121 - www.marmimauri.com - [email protected] ARREDAMENTI - RIVestiMENTI STUFE in SERPentino PietRE PER CottuRA 37° CAMPIONATO NAZIONALE ANA SCI ALPINISMO LANZADA 15-16 MARZO 2014 COMITATO D’ONORE dr. Carmelo Casabona Sebastiano Favero Prefetto di Sondrio Presidente Associazione Nazionale Alpini dr. Girolamo Fabiano Onorio Miotto Questore di Sondrio Presidente Commissione Sportiva ANA Massimo Sertori Alberto Del Martino Presidente Provincia di Sondrio Presidente Sezione ANA Valtellinese Carla Cioccarelli Daniele Peli Presidente BIM Sondrio Coordinatore Commissione Sportiva ANA Col. Salvatore Paladini Fernando Bardea Comandante Provinciale Guardia di Finanza Capogruppo Alpini Lanzada Ten. Col. Luigi Turco Maurizio Masa Comandante Provinciale Corpo Forestale dello Stato Presidente Sportiva Lanzada Marasciallo Alessandro Di Roio Guido Melè Comandante Stazione Carabinieri della Valmalenco Presidente del consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco Tiziano Maffezzini Roberto Pinna Presidente Comunità Montana Valtellina di Sondrio Direttore del consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco Miriam Longhini Floriano Lenatti Presidente Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco Resposnsabile C.N.S.A. -

Elezioni U.P.S. 2020
ELEZIONI U.P.S. 2020 ELENCO ALFABETICO PESCATORI RESIDENTI IN PROVINCIA DI SONDRIO - VOTANTI/ELEGGIBILI Abela Sebastiano Sondrio Acquistapace Abele Piantedo Acquistapace Adriano Morbegno Acquistapace Andrea Piantedo Acquistapace Armando Piantedo Acquistapace Elia Samolaco Acquistapace Eraldo Piantedo Acquistapace Ezio Piantedo Acquistapace Marco Morbegno Acquistapace Marino Cosio Valtellino Acquistapace Maurizio Campodolcino Acquistapace Maurizio Piantedo Acquistapace Paolo Delebio Acquistapace Stefano Cosio Valtellino Acquistapace Stefano Delebio Acquistapace Thomas Cosio Valtellino Agnelli Andrea Caspoggio Agosti Gabriele Samolaco Agostinelli Franco Villa Di Tirano Aili Maurizio Berbenno Di Valtellina Aili Stefano Sondrio Albareda Ivan Chiesa In Valmalenco Albareda Mattia Chiesa In Valmalenco Albertazzi Rino Postalesio Alberti Edoardo Rasura Alberti Ottavio Ardenno ALBINI NICOLA Delebio ALBINIANO Luca Campodolcino Alessi Giuseppe Aprica Aloisio Paolo Samolaco Ambrosetti Remo Morbegno Ambrosetti Rocco Cosio Valtellino Ambrosini Attilio Aprica AMBROSINI CRISTIAN Dubino ambrosini daniele Cercino Ambrosini Fabio Ardenno Ambrosini Filippo Dubino Ambrosini Giuliano Delebio Ambrosini Lina Sondrio Ambrosini Valerio Dubino Ambrosini Valter Cercino Ambrosioni Luca Tresivio Amonini Antonello Castello Dell'acqua Amorini G.carlo Talamona Ancona Samuele Livigno Andreola Mattia Sondrio ANDREOLI ANDREA Mese Andreoli Giuliano Samolaco Andreoli Luca Tresivio ANDREOLI STEFANO Samolaco Andreotta Arnaldo Villa Di Tirano andreu caparros tamara Grosio Angelini -

Modello Domanda Disabili
REGIONE LOMBARDIA (Regolamento regionale n. 4 del 04/08/2017 e s.m.i.) Comune di: Sondrio capofila dell’ambito territoriale di: Sondrio AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale di Sondrio localizzate nel/i Comune/i di: Castione Andevenno ‐Colorina ‐ Fusine – Poggiridenti ‐ Sondrio – Spriana ‐ Torre di Santa Maria e di proprietà dei Comuni di: Castione Andevenno – Fusine – Poggiridenti e di ALER Bg‐Lc‐So PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO Dalle ore 9:00 del 15 ottobre alle ore 12:00 del 29 novembre 2019 1. INDIZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO 1.1. Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento regionale 4/2017 è indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative disponibili destinate ai servizi abitativi pubblici. 1.2. Le unità abitative di cui al presente avviso pubblico si distinguono in: a) Numero 29 unità abitative immediatamente assegnabili; b) Numero 0 unità abitative che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione; c) Numero 0 unità abitative nello stato di fatto non immediatamente assegnabili per carenze di manutenzione, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento regionale 4/2017 e s.m.i. 1.3. Le unità abitative di cui al presente avviso sono pubblicate nella piattaforma informatica regionale con l’indicazione, per ciascuna di esse, dei seguenti elementi: a) ente proprietario; b) zona o frazione o municipio; 1 c) superficie utile residenziale; d) numero dei vani e fotografie dell’unità abitativa e, ove possibile, dello stabile; e) piano; f) presenza di ascensore; g) presenza di barriere architettoniche; h) tipologia di riscaldamento; i) stima delle spese per i servizi; j) numero di domande presentate 1.4. -

Elezioni U.P.S. 2020
ELEZIONI U.P.S. 2020 ELENCO ALFABETICO PESCATORI RESIDENTI IN PROVINCIA DI SONDRIO - VOTANTI/ELEGGIBILI Abela Sebastiano Sondrio Acquistapace Abele Piantedo Acquistapace Adriano Morbegno Acquistapace Andrea Piantedo Acquistapace Armando Piantedo Acquistapace Elia Samolaco Acquistapace Eraldo Piantedo Acquistapace Ezio Piantedo Acquistapace Marco Morbegno Acquistapace Marino Cosio Valtellino Acquistapace Maurizio Campodolcino Acquistapace Maurizio Piantedo Acquistapace Paolo Delebio Acquistapace Stefano Cosio Valtellino Acquistapace Stefano Delebio Acquistapace Thomas Cosio Valtellino Agnelli Andrea Caspoggio Agosti Gabriele Samolaco Agostinelli Franco Villa Di Tirano Aili Maurizio Berbenno Di Valtellina Aili Stefano Sondrio Albareda Ivan Chiesa In Valmalenco Albareda Mattia Chiesa In Valmalenco Albertazzi Rino Postalesio Alberti Edoardo Rasura Alberti Ottavio Ardenno ALBINI NICOLA Delebio ALBINIANO Luca Campodolcino Alessi Giuseppe Aprica Aloisio Paolo Samolaco Ambrosetti Remo Morbegno Ambrosetti Rocco Cosio Valtellino Ambrosini Attilio Aprica AMBROSINI CRISTIAN Dubino ambrosini daniele Cercino Ambrosini Fabio Ardenno Ambrosini Filippo Dubino Ambrosini Giuliano Delebio Ambrosini Lina Sondrio Ambrosini Valerio Dubino Ambrosini Valter Cercino Ambrosioni Luca Tresivio Amonini Antonello Castello Dell'acqua Amorini G.carlo Talamona Ancona Samuele Livigno Andreola Mattia Sondrio ANDREOLI ANDREA Mese Andreoli Giuliano Samolaco Andreoli Luca Tresivio ANDREOLI STEFANO Samolaco Andreotta Arnaldo Villa Di Tirano andreu caparros tamara Grosio Angelini -

COMUNE DI LANZADA E-Mail [email protected] Pec [email protected]
Responsabile del servizio archivistico Telefono 0342 453243 COMUNE DI LANZADA E-mail [email protected] Pec [email protected] CONSISTENZA DELLA DOCUMENTAZIONE IL LOCALE ADIBITO AD ARCHIVIO La documentazione conservata all’interno dell’archivio storico del comune è pari a 402 buste, La documentazione dell’archivio storico del comune è 1 mappa e 100 registri con estremi cronologici compresi fra il 1544 e il 1960 con seguiti al conservata nell’edificio municipale in via San Giovanni 432, 1976. nel locale adibito ad archivio nello scantinato dello stabile, L’archivio è costituito dai documenti prodotti o acquisiti dall’ente nello svolgimento della sotto gli uffici comunali. Il locale ha scaffalature in ferro poste propria funzione amministrativa. Fanno parte del materiale documentario conservato anche sul perimetro e nel centro della stanza. documenti prodotti da enti o istituzioni con un’amministrazione propria, distinta da quella comunale, qui denominati archivi aggregati. Progetto per la costruzione del fabbricato scolastico anni 1887 - 1896 COMUNE QUANTITÀ ESTREMI CRONOLOGICI Sezione archivistica 1 21 buste 1800 - 1897 Sezione archivistica 2 93 buste 1898 - 1949 Sezione archivistica 3 152 buste 1949 - 1960 Registri 100 registri 1816 - 1970 Fogli di famiglia 9 buste s.d. Mappe 1 mappa 1862 Fascicoli personali degli elettori 4 buste 1953 - 1976 Atti contabili 111 buste 1819 - 1960 L’archivio storico ARCHIVI AGGREGATI QUANTITÀ ESTREMI CRONOLOGICI Quadra di Lanzada 1 busta 1544 - 1795 Congregazione di carità 5 buste 1865 - 1937 seguiti al 1944 Ente comunale di assistenza 5 buste 1937 - 1963 Guardia nazionale 1 busta 1843 - 1872 Registri TRACCE DI STORIA ATTRAVERSO I DOCUMENTI dei confini tra l’alpe Zocca e l’alpe Cavaglia, tra il 1822 e il 1826 quella E’ sempre stata essenziale per l’economia del comune anche l’attività Le banche dati create in seguito al lavoro di riordino, inventariazione e relativa alla controversia per il possesso del bosco della Sassa sopra l’Ova, estrattiva. -
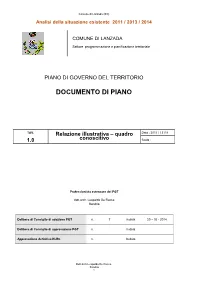
1.0 Conoscitivo Scala
Comune di Lanzada (SO) Analisi della situazione esistente 2011 / 2013 / 2014 COMUNE DI LANZADA Settore programmazione e pianificazione territoriale PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DOCUMENTO DI PIANO TAV. Relazione illustrativa – quadro Data : 2011 / 13 /14 1.0 conoscitivo Scala : Professionista estensore del PGT dott.arch. Leopoldo De Rocco Sondrio Delibera di Consiglio di adozione PGT n. 7 in data 20 – 02 - 2014 Delibera di Consiglio di approvazione PGT n. in data Approvazione definitiva BURL n. In data Dott.arch.Leopoldo De Rocco Sondrio 1 Comune di Lanzada (SO) Analisi della situazione esistente 2011 / 2013 / 2014 Relazione illustrativa quadro conoscitivo Dott.arch.Leopoldo De Rocco Sondrio 2 Comune di Lanzada (SO) Analisi della situazione esistente 2011 / 2013 / 2014 • Premessa • La necessità di un nuovo strumento urbanistico • La nuova Legge Regionale 12/2005 e la nuova organizzazione degli strumenti urbanistici comunali • La costruzione del Quadro Conoscitivo • Le condizioni provinciali • Demografia • Analisi socio-economica • la disoccupazione in provincia di Sondrio • l'occupazione nel settore servizi • l'evoluzione della struttura imprenditoriale • le imprese artigiane • il turismo • situazione infrastrutturale • elementi di criticità evidenziati dal piano generale trasporti • elementi di formazione del reddito provinciale • aspetti economici • Conclusione • Le condizioni sovracomunali • Premessa • Il sub-strato socio economico • Sviluppo urbanistico intercomunale • tipologie costruttive • economia • turismo • struttura produttiva -

Lanzada YC Team Manual Update 10Apr2018.Pdf
1 1. GENERAL INFORMATION 2. ORGANISATIONAL STRUCTURE 3. ARRIVALS 4. ACCREDITATION 5. ACCOMMODATION 6. TRANSPORT 7. TECHNICAL INFORMATION 8. COMPETITION REGULATIONS 9. COMPETITION PROCEDURE 10. MEDICAL SERVICES AND ANTIDOPING 11. SECURITY 12. CEREMONIES AND PROTOCOL 13. DEPARTURES 14. CONTACT DETAILS 15. GENERAL PROGRAMME 16. COMPETITION TIMETABLE 17. COURSE & PROFILE 2 1.GENERAL INFORMATION ITALY: Population of about 61 million inhabitants Capital: Rome LANZADA: Lanzada is a touristic mining village situated in Valmalenco, in the north of Valtellina, Lombardy and it has a population of around 1400 inhabitants. It is situated at an altitude of about 1000m above sea level and it is crossed by a creek, the Lanterna. The valley’s northern boundary is the Bernina Range, which reaches the altitude of 4000m. Lanzada has a small hydroelectric power plant and above the village, in a beautiful setting at 2000m, stand two dams, Campomoro and Alpe Gera, reachable by car. Valmalenco has got five municipalities (Chiesa in Valmalenco, the main village, Caspoggio, Lanzada, Spriana and Torre di Santa Maria) and three of them (Caspoggio, Chiesa in Valmalenco and Lanzada) form the Union of Valmalenco. OFFICIAL TOWNSHIP WEBSITE: http://www.comune.lanzada.gov.it/ OFFICIAL LANGUAGE: Italian Money: Euro Money exchange: It is possible to change money in Bergamo Orio al Serio airport or in the bank offices in Lanzada and in the other villages in Valmalenco. Electricity specifications: 220V 50 Hz Telephone code: International country code for Italy: +39 Shop opening hours: Most shops are open from Monday to Saturday, from 8:00 to 12.30 and from 15.30 to 19.30; Bank opening hours: From Monday to Friday, from 8.10 to 13.00 – from 14.15 to 15.15 2.