Steve Jobs – Stay Hungry, Stay Foolish
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
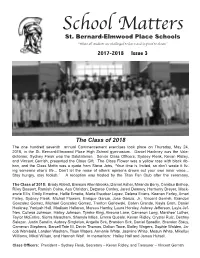
St. Bernard-Elmwood Place Schools “Where All Students Are Challenged to Learn and Inspired to Dream” 2017-2018 Issue 3
School Matters St. Bernard-Elmwood Place Schools “Where all students are challenged to learn and inspired to dream” 2017-2018 Issue 3 The Class of 2018 The one hundred seventh annual Commencement exercises took place on Thursday, May 24, 2018, in the St. Bernard-Elmwood Place High School gymnasium. Daniel Hackney was the Vale- dictorian; Sydney Fleak was the Salutatorian. Senior Class Officers, Sydney Fleak, Kevan Ridley, and Vincent Gerrish, presented the Class Gift. The Class Flower was a yellow rose with black rib- bon, and the Class Motto was a quote from Steve Jobs, “Your time is limited, so don’t waste it liv- ing someone else’s life... Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice... Stay hungry, stay foolish.” A reception was hosted by the Titan Fan Club after the ceremony. The Class of 2018: Brady Abbott, Breaisia Allen Brooks, Darriel Asher, Miranda Berry, Candice Bishop, Riley Bossert, Ramiah Caine, Asa Christon, Dezarae Conley, Jared Downey, Harmony Dreyer, Mack- enzie Ellis, Emily Emerine, Hallie Ernette, Maria Escobar Lopez, Delena Evans, Keenan Farley, Amari Finley, Sydney Fleak, Michail Flowers, Enrique Garcia, Jose Garcia, Jr., Vincent Gerrish, Brandon Gonzalez Gomez, Michael Gonzalez Gomez, Trenton Gorlewski, Calvin Grande, Kayla Groh, Daniel Hackney, Yaniyah Hall, Madison Halloran, Marcus Hamby, Laura Horsley, Aubrey Jefferson, Layla Jef- fries, Collesa Johnson, Hailey Johnson, Tyreke King, Aireona Lane, Cameron Long, Marshee’ Luther, Taylor McEntire, Sierra Meacham, Shanyla Miles, Emma Queale, Kevan Ridley, Crystal Ruiz, Destiny Salazar, Justin Sandlin, Aubrey Singleton, Angella Sirk, Brandon Sirk, Daniel Spradlin, Brandon Stacy, Cameron Stephens, Barzell Tate III, Devin Thomas, Dalton Towe, Bailey Wagers, Sophie Walden, Ja- cob Wambold, Landen Washam, Tison Waters, Armanie White, Jasmine White, Meaun White, Mikelluv Williams, Mikal Wilson, and Hannah Wolf. -

Text 9 Steve Jobs Told Students: 'Stay Hungry. Stay Foolish.'
Text 9 Steve Jobs told students: ‘Stay hungry. Stay foolish.’ The Washington Post, September 5 th 2011 Steve Jobs, the late Apple co-founder revealed in a commencement speech at Stanford University in 2005 why he dropped out of college - and why he thought it was one of the best things he ever did. Yet he had other advice for the students. Jobs started that speech by talking about being adopted as a baby, and why, 17 years later, he attended Reed College in Oregon for only six months before dropping out. He said: “My biological mother was a young, unwed college graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates but later found out that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented when my parents promised that I would someday go to college.” “And 17 years later I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford, and all of my working-class parents’ savings were being spent on my college tuition. After six months, I couldn’t see the value in it. So I decided to drop out and the minute I dropped out I could stop taking the required classes that didn’t interest me, and begin dropping in on the ones that looked interesting. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. -

A Look at Steve Jobs Through His Own Words”, Media Dialogues / Medijski Dijalozi, Vol
International Journal of Scholarly Papers for Media and Society Research Kostic, N. (2012), „Listen to Your Heart and Do What You Love: a Look at Steve Jobs Through His Own Words”, Media dialogues / Medijski dijalozi, Vol. 5, No. 1, pp. 25‐35. NATAŠA KOSTIĆ, PhD Assistant professor at Institute of Foreign Languages, University of Montenegro LISTEN TO YOUR HEART AND DO WHAT YOU LOVE: A LOOK AT STEVE JOBS THROUGH HIS OWN WORDS Abstract: Steve Jobs’ natural talent for public speaking was widely noticed and invariably mentioned in descriptions of this truly inspira‐ tional inventor. This paper gives a brief description of the most re‐ markable elements of Steve’s language, based on his keynote speeches at major trade expos and the Commencement address delivered at Stanford University in 2005. The paper also discusses the great life lessons we can learn from such an amazing person, who had the cou‐ rage to base his goals on his deepest heart’s desires. A strong propo‐ nent of living life to the fullest, Jobs inspired us to listen to our inner voice and follow it, because he believed it to be the only way to live the life with passion, love, and purpose. Key words: Steve Jobs, Language, Keynote Speech, Public Speaking, Figures of Speech 25 POSLUŠAJ SVOJE SRCE I RADI ONO ŠTO VOLIŠ: O STIVU DŽOBSU NJEGOVIM RIJEČIMA Apstrakt: Urođeni talenat Stiva Džobsa za javne govore često je za‐ pažan i uvijek komentarisan u gotovo svim prikazima ovog inspira‐ tivnog inovatora. Ovaj rad daje kratak prikaz najupečatljivijih eleme‐ nata jezika Stiva Džobsa u njegovim plenarnim govorima na velikim skupovima posvećenim predstavljanju novih proizvoda kompanije, kao i govora održanog 2005. -

Steve Jobs' Use of Ethos for Persuasive Success in His 2005
Communication and Theater Association of Minnesota Journal Volume 41 Combined Volume 41/42 (2014/2015) Article 6 January 2014 Steve Jobs’ use of Ethos for Persuasive Success in His 2005 Stanford Commencement Address Keith Bistodeau Ohio University, [email protected] Follow this and additional works at: https://cornerstone.lib.mnsu.edu/ctamj Part of the Speech and Rhetorical Studies Commons Recommended Citation Bistodeau, K. (2014/2015). Steve Jobs’ use of Ethos for Persuasive Success in His 2005 Stanford Commencement Address. Communication and Theater Association of Minnesota Journal, 41/42, 67-90. This General Interest is brought to you for free and open access by Cornerstone: A Collection of Scholarly and Creative Works for Minnesota State University, Mankato. It has been accepted for inclusion in Communication and Theater Association of Minnesota Journal by an authorized editor of Cornerstone: A Collection of Scholarly and Creative Works for Minnesota State University, Mankato. Bistodeau: Steve Jobs’ use of Ethos for Persuasive Success in His 2005 Stanf CTAMJ 2014/2015 67 Steve Jobs’ use of Ethos for Persuasive Success in His 2005 Stanford Commencement Address Keith Bistodeau Graduate Teaching Assistant/Forensics Ohio University [email protected] Abstract The use of ethos in persuasive settings has always been a powerful tool in public speaking, especially by those in power and in businesses. Kenneth Burke’s Pentad plays a primary role in persuasive situations, particularly when we as scholars try to dissect and understand specific aspects of a speech situation. In this essay I used Burke’s Pentad as a framework to explore Steve Jobs’ use of, as I term it, “internal and external ethos” as not only a persuasive mechanism, but also as a force to build his persona/mythological legacy. -

Amanda Moura Da Silva Dos Santos.Pdf
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC - SP Amanda Moura da Silva dos Santos STEVE JOBS E O DISCURSO RELIGIOSO-MIDIÁTICO DA APPLE Mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem São Paulo 2017 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC - SP Amanda Moura da Silva dos Santos Steve Jobs e o discurso religioso-midiático da Apple Mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de MESTRE em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, sob a orientação da Profª. Dra. Profa. Dra. Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva. São Paulo 2017 Banca Examinadora Autorizo a divulgação do texto completo em bases de dados especializadas e a reprodução total ou parcial, por processos fotocopiadores, exclusivamente para fins acadêmicos ou científicos, desde que citada a fonte. Dedico ao Leandro, o dígito que completa meu bit. AGRADECIMENTOS À orientadora deste trabalho, Profa. Dra. Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva, por ter me acolhido e permitido que meus devaneios se tornassem uma profunda experiência de pesquisa e aprendizado. Ao Leandro, por ter me dito “você vai entrar na faculdade neste ano, sim”, naquele dia, no jardim do Centro Cultural de São Paulo. Ao Bolt, meu fiel e eterno companheiro, por me fazer sorrir todos os dias. Aos meus pais, Helena e Tadeu, por terem me levado (de surpresa) à loja de informática em 1998 para me dar de presente o meu primeiro computador. À minha amada avó Liontina, pelo sangue nordestino e pelas grandes lições que me deixou, apesar do analfabetismo. -

SHIFTING INTO a HIGHER GEAR Raising Your Game—Individually and Organizationally
INTRODUCTION SHIFTING INTO A HIGHER GEAR Raising Your Game—Individually and Organizationally “If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right. Stay hungry. Stay foolish.” —Steve Jobs Living in the Age of Uber We were recently at a wedding dinner in Boston honoring the daughter of a close friend from India. The daughter married a boy in the United States, and we were a few of the fortunate guests invited. As the dinner was winding down, the younger sister of the bride was ready to call it a night. She exclaimed, “I’m getting Uber! Who wants to go back to the hotel with me?” She then began placing the order on her iPhone. Within seconds she exclaimed excitedly, “A Suburban we can all fit in will be here in 10 minutes.” A few minutes later she nudged someone sitting next to her and asked, “Hey, shall I get a black one?” After getting confirmation that the color black was definitely the coolest of all color choices, she modified her order. And within 10 minutes she and others climbed into a shiny, new black Chevy Sub- urban. And that was that. 2 REINVENTION In this Age of Uber, there are now more Uber drivers (10,000) in New York City than yellow-cab drivers. New York City cab driv- ers are seeing a serious decrease in their business, and are in the process of asking the government to intervene and protect their livelihoods. But it is not just Uber disrupting the livelihoods of taxi drivers. -

Staying Hungry, Staying Foolish: Academic Reflections on the Life and Career of Steve Jobs Amy E
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Chapman University Digital Commons Chapman University Chapman University Digital Commons Business Faculty Articles and Research Business 2013 Staying Hungry, Staying Foolish: Academic Reflections on the Life and Career of Steve Jobs Amy E. Hurley-Hanson Chapman University, [email protected] Cristina M. Giannantonio Chapman University, [email protected] Follow this and additional works at: http://digitalcommons.chapman.edu/business_articles Part of the Business Administration, Management, and Operations Commons, and the Leadership Studies Commons Recommended Citation Hurley-Hanson, A.E. & Giannantonio, C.M. Staying Hungry, Staying Foolish: Academic Reflections on the Life and Career of Steve Jobs. Journal of Business and Management. 19, 2013, 7-10. This Article is brought to you for free and open access by the Business at Chapman University Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Business Faculty Articles and Research by an authorized administrator of Chapman University Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. Staying Hungry, Staying Foolish: Academic Reflections on the Life and Career of Steve Jobs Comments This article was originally published in Journal of Business and Management, volume 19, issue 1, in 2013. Copyright Chapman University This article is available at Chapman University Digital Commons: http://digitalcommons.chapman.edu/business_articles/40 Hurley-Hanson and Giannantonio 7 Staying Hungry, Staying Foolish: Academic Reflections on the Life and Career of Steve Jobs Amy E. Hurley-Hanson Chapman University Cristina M. Giannantonio Chapman University The 2011 death of Steve Jobs, Apple CEO and cofounder, generated a flood of articles in the popular press acknowledging his influence on the design and delivery of consumer products that changed the way multiple generations work and play. -

Steve Jobs, Apple's Visionary, Dies at 56
Steve Jobs, Apple’s Visionary, Dies at 56 Jim Wilson/The New York Times Steven P. Jobs introduced the iPhone 4 in San Francisco in 2010. By JOHN MARKOFF Published: October 5, 2011 Steven P. Jobs, the visionary co-founder of Apple who helped usher in the era of personal computers and then led a cultural transformation in the way music, movies and mobile communications were experienced in the digital age, died Wednesday. He was 56. Multimedia The death was announced by Apple, the company Mr. Jobs and his high school friend Stephen Wozniak started in 1976 in a suburban California garage. Mr. Jobs had waged a long and public struggle with cancer, remaining the face of the company even as he underwent treatment. He continued to introduce new products for a global market in his trademark blue jeans even as he grew gaunt and frail. He underwent surgery for pancreatic cancer in 2004, received a liver transplant in 2009 and took three medical leaves of absence as Apple‟s chief executive before stepping down in August and turning over the helm to Timothy D. Cook, the chief operating officer. When he left, he was still engaged in the company‟s affairs, negotiating with another Silicon Valley executive only weeks earlier. “I have always said that if there ever came a day when I could no longer meet my duties and expectations as Apple‟s C.E.O., I would be the first to let you know,” Mr. Jobs said in a letter released by the company. “Unfortunately, that day has come.” By then, having mastered digital technology and capitalized on his intuitive marketing sense, Mr. -

Narrative and Rhetorical Analysis of Steve Job's Discourse in 2014
Narrative and rhetorical analysis of Steve Job’s discourse in 2014 By Pablo Ruiz Appendices Appendix 1 ‘You've got to find what you love’, Jobs says. This is a prepared text of the Commencement address delivered by Steve Jobs, CEO of Apple Computer and of Pixar Animation Studios, on June 12, 2005. I am honored to be with you today at your commencement from one of the finest universities in the world. I never graduated from college. Truth be told, this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today I want to tell you three stories from my life. That's it. No big deal. Just three stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop- in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed college graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking: "We have an unexpected baby boy; do you want him?" They said: "Of course." My biological mother later found out that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. -

Speech As Text for Teaching an Analysis of Linguistic
International Journal of English, and Literature (IJEL) ISSN(P): 2249-6912; ISSN(E): 2249-8028 Vol. 6, Issue 1, Feb 2016, 47-58 © TJPRC Pvt. Ltd. SPEECH AS TEXT FOR TEACHING: AN ANALYSIS OF LINGUISTIC AND STYLISTIC MANEUVERINGS OF STEVE JOBS’ FAMOUS SPEECH STAY HUNGRY STAY FOOLISH AND EXERCISES FOR ENHANCING STUDENTS’ LANGUAGE SKILLS MANOJ KUMAR 1 & SANJAY KUMAR 2 1Research Scholar, JK Lakshmipat University, Jaipur, Rajasthan, India 2Associate Professor, JK Lakshmipat University, Jaipur, Rajasthan, India ABSTRACT Analysis of speeches offers more opportunities for the learners to grasp all the nuances of a given text of a speech in comparison to prose, poem or story. Usually students find the exercises on prose passage or poem stanzas somewhat cumbersome. Comparatively the diction in speeches is more comprehensible and approachable to the students than the diction and discourse in prose or poem. Further, the analysis of a speech helps them explore the style of the speaker, the language used, the sentence structure, the use of figures of speech and the lexical and grammatical Article Original elements used by the speaker. Since speeches are delivered in any age, place and situation, they reflect the exigencies and milieu of that era, context and country. Helping students explore speeches linguistically and stylistically therefore, we can help them conceptualise the social, cultural and political perspectives of a time, nation, and context. The present paper analyses a speech of a young business icon Steve Jobs and devises exercises based on it. This speech has been chosen for analysis on the basis of its motivational touch, inspirational content and organisational relevance. -

"Stay Hungry, Stay Foolish"
"Stay Hungry, Stay Foolish" BY JACK MACKENZIE, CGCS Hole Notes Editor North Oaks Golf Club (Editor's Note: The following is a es that didn't interest me and begin drop- typography If I had never dropped in on Transcript of a Commencement Speech at ping in on the ones that looked far more that single course in college, the Mac Stanford given by Steve Jobs in June of2005. interesting. would have never had multiple typefaces Jobs died on October 5, 2011.) It wasn't all romantic. I didn't have a or proportionally spaced fonts, and since Thank you. I'm honored to be with you dorm room, so I slept on the floor in Windows just copied the Mac, it's likely today for your commencement from one friends' rooms. I returned Coke bottles for that no personal computer would have of the finest universities in the world. the five-cent deposits to buy food with, them. Truth be told, I never graduated from col- and I would walk the seven miles across If I had never dropped out, I would lege and this is the closest I've ever gotten town every Sunday night to get one good have never dropped in on that calligraphy to a college graduation. meal a week at the Hare Krishna temple. I class and personals computers might not Today I want to tell you three stories have the wonderful typography that they from my life. That's it. No big deal, just do. three stories. The first story is about con- Of course, it was impossible to connect necting the dots. -
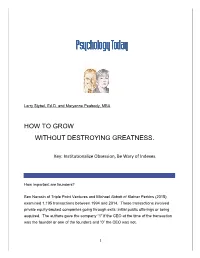
How to Grow Without Destroying Greatness
Larry Stybel, Ed.D. and Maryanne Peabody, MBA HOW TO GROW WITHOUT DESTROYING GREATNESS. Key: Institutionalize Obsession, Be Wary of Indexes. How important are founders? Ben Narasin of Triple Point Ventures and Michael Abbott of Kleiner Perkins (2015) examined 1.195 transactions between 1994 and 2014. These transactions involved private equity-backed companies going through exits: initial public offerings or being acquired. The authors gave the company “1” if the CEO at the time of the transaction was the founder or one of the founders and “0” the CEO was not. 1 Founder CEOs raised more capital than professional managers. They produced higher valuations when it came time to exit. Founders generate more value for owners than “professional” CEOs. In their excellent book The Founder's Mentality, Chris Zook and James Allen of Bain Consulting examined the same issue with a different database. Instead of private equity-backed companies seeking exits, they examined the world’s largest public companies. Their conclusions were the same: owners are better off with founders than without them. “Lessons for Boards: Keep Your Founders? Not really….. Using archival data from 126 private equity investments in the United States between 1990 and 2006, Gong & Wu documented a CEO turnover rate of 51% within two years of the transaction (2011). According to the authors, these removals are usually related to CEOs having failed to retain the confidence of the private equity dominated board of directors. They are not often related to the company having outgrown the CEO. Zook and Allen agree. According to their data only one of every three founders is fired because the founder cannot or will not grow the business.