Fontana, Con Acqua Condotta Per Canali, E Da Un Pozzo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Magnano in Riviera, Montenars, Trasaghis E Venzone
COMUNE di ARTEGNA Provincia di Udine COMUNI DI ARTEGNA; MAGNANO IN RIVIERA, MONTENARS, TRASAGHIS E VENZONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA EROGARE A CONCORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CITTADINI MENO ABBIENTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI MATERIALI DERIVANTI DA FATTI DI MICROCRIMINALITA’ approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 18/05/2005 ART 1 Ambito di applicazione e finalità 1) Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione di contributi per le spese che i cittadini meno abbienti dei comuni di Artegna, Magnano in Riviera, Montenars, Trasaghis e Venzone sostengono per la riparazione di eventuali danni materiali derivanti da fatti di micro-criminalità, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento regionale approvato con DPR 23.04.2003 n. 0107/Pres. e nella misura stabilita con decreto del Direttore del Servizio finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 450/04 del 22.09.2004. Il comune di Artegna, in qualità di capo-fila, provvederà agli adempimenti connessi all’applicazione del presente regolamento anche per conto degli altri enti territoriali testè menzionati. 2) Per “fatto di microcriminalità”che da diritto al contributo si intende la commissione di un reato, consumato o tentato, contro il patrimonio. 3) Per “spesa”si intende la somma , debitamente documentata, versata dal richiedente per riparare il danno materiale al proprio patrimonio subito a seguito della commissione di un reato di cui al comma precedente. 4) Per “cittadino meno abbiente” si intende la persona fisica titolare di un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, riferito al nucleo familiare del richiedente, non superiore a quanto indicato nella specifica tabella a termine riportata. -

Friuli Venezia Giulia: a Region for Everyone
EN FRIULI VENEZIA GIULIA: A REGION FOR EVERYONE ACCESSIBLE TOURISM AN ACCESSIBLE REGION In 2012 PromoTurismoFVG started to look into the tourist potential of the Friuli Venezia Giulia Region to become “a region for everyone”. Hence the natural collaboration with the Regional Committee for Disabled People and their Families of Friuli Venezia Giulia, an organization recognized by Regional law as representing the interests of people with disabilities on the territory, the technical service of the Council CRIBA FVG (Regional Information Centre on Architectural Barriers) and the Tetra- Paraplegic Association of FVG, in order to offer experiences truly accessible to everyone as they have been checked out and experienced by people with different disabilities. The main goal of the project is to identify and overcome not only architectural or sensory barriers but also informative and cultural ones from the sea to the mountains, from the cities to the splendid natural areas, from culture to food and wine, with the aim of making the guests true guests, whatever their needs. In this brochure, there are some suggestions for tourist experiences and accessible NATURE, ART, SEA, receptive structures in FVG. Further information and technical details on MOUNTAIN, FOOD our website www.turismofvg.it in the section AND WINE “An Accessible Region” ART AND CULTURE 94. Accessible routes in the art city 106. Top museums 117. Accessible routes in the most beautiful villages in Italy 124. Historical residences SEA 8. Lignano Sabbiadoro 16. Grado 24. Trieste MOUNTAIN 38. Winter mountains 40. Summer mountains NATURE 70. Nature areas 80. Gardens and theme parks 86. On horseback or donkey 90. -
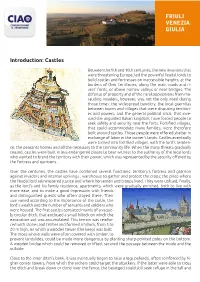
Introduction: Castles
Introduction: Castles Between the 9th and 10th centuries, the new invasions that were threatening Europe, led the powerful feudal lords to build castles and fortresses on inaccessible heights, at the borders of their territories, along the main roads and ri- vers’ fords, or above narrow valleys or near bridges. The defense of property and of the rural populations from ma- rauding invaders, however, was not the only need during those times: the widespread banditry, the local guerrillas between towns and villages that were disputing territori- es and powers, and the general political crisis, that inve- sted the unguided Italian kingdom, have forced people to seek safety and security near the forts. Fortified villages, that could accommodate many families, were therefore built around castles. Those people were offered shelter in exchange of labor in the owner’s lands. Castles eventually were turned into fortified villages, with the lord’s residen- ce, the peasants homes and all the necessary to the community life. When the many threats gradually ceased, castles were built in less endangered places to bear witness to the authority of the local lords who wanted to brand the territory with their power, which was represented by the security offered by the fortress and garrisons. Over the centuries, the castles have combined several functions: territory’s fortress and garrison against invaders and internal uprisings ; warehouse to gather and protect the crops; the place where the feudal lord administered justice and where horsemen and troops lived. They were utilised, finally, as the lord’s and his family residence, apartments, which were gradually enriched, both to live with more ease, and to make a good impression with friends and distinguished guests who often stayed there. -

Documento Completo Relativo Al Sondaggio (In Ottemperanza All’Art
Documento completo relativo al sondaggio (in ottemperanza all’art. 5 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 256/10/CSP, pubblicata su GU n. 301 del 27/12/2010) 1. TITOLO DEL SONDAGGIO La criminalità organizzata vista da Nord Est (Osservatorio sul Nord Est) 2. SOGGETTO CHE HA REALIZZATO IL SONDAGGIO Demos & Pi e Demetra 3. SOGGETTO COMMITTENTE Il Gazzettino 4. SOGGETTO ACQUIRENTE Il Gazzettino 5. DATA O PERIODO IN CUI È STATO REALIZZATO IL SONDAGGIO Dal 04/11/2020 al 06/11/2020 6. MEZZO/MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA SUL/SUI QUALE/QUALI È PUBBLICATO O DIFFUSO IL SONDAGGIO (pubblicato sul quotidiano/periodico cartaceo e/o elettronico, diffuso sull’emittente radiofonica, televisiva o sul sito web) Pubblicato sul quotidiano Il Gazzettino. 7. DATA DI PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE 27.01.2021 8. TEMI/FENOMENI OGGETTO DEL SONDAGGIO (economia, società, attualità, costume, marketing, salute, etica, ambiente etc.) Opinioni e stile di vita dei residenti in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Provincia di Trento. 9. POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO Popolazione residente in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia di Trento di età dai 18 anni in su in possesso di telefonia fissa o mobile, o iscritta al panel web Opinioni.net. 10. ESTENSIONE TERRITORIALE DEL SONDAGGIO Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Regione Friuli-Venezia Giulia (Opzione A) Comuni di rilevazione Abano Terme Casaleone Granze Adria Casarsa della -

Bollettino Dei Trasferimenti
SMOW2A 02/04/07 PAG. 1 SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : UDINE ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2007/08 ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 1. CARPINI STEFANIA . 24/ 5/65 (SI) DA : UDEE05301Q - ENRICO FRUCH - PASIAN DI PRATO (PASIAN DI PRATO) A : UDEE05301Q - ENRICO FRUCH - PASIAN DI PRATO (PASIAN DI PRATO) DA POSTO DI SOSTEGNO :MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 92 2. CASTELLANI SARA . 12/ 5/72 (UD) DA : UDEE04803A - PADRE DAVIDE MARIA TUROLDO (TOLMEZZO) A : UDEE04803A - PADRE DAVIDE MARIA TUROLDO (TOLMEZZO) DA POSTO DI LINGUA :INGLESE PRECEDENZA: TRASFERITO NELL'AMBITO DELL'ORG. FUNZ. PUNTI 131 3. CHIEU GABRIELLA . 21/10/58 (UD) DA : UDEE00201V - QUATTRO NOVEMBRE (UDINE) A : UDEE00201V - QUATTRO NOVEMBRE (UDINE) DA POSTO DI LINGUA :INGLESE PRECEDENZA: TRASFERITO NELL'AMBITO DELL'ORG. FUNZ. PUNTI 114 4. DRI FULVIA . 2/ 4/51 (UD) DA : UDEE007023 - GIANNI RODARI (UDINE) A : UDEE001013 - DANTE ALIGHIERI (UDINE) PUNTI 253 5. DURI SILVIA . 19/ 6/74 (UD) DA : UDEE02901V - MORTEGLIANO- VIA L. DA VINCI (MORTEGLIANO) A : UDEE02901V - MORTEGLIANO- VIA L. DA VINCI (MORTEGLIANO) DA POSTO DI SOSTEGNO :MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 57 6. LUCCHETTA MONICA EMANUELA . 31/ 7/64 (TV) DA : UDEE82003D - ELLERO TRICESIMO (TRICESIMO) A : UDEE82003D - ELLERO TRICESIMO (TRICESIMO) DA POSTO DI SOSTEGNO :MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 176 SMOW2A 02/04/07 PAG. -

Second Report Submitted by Italy Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities
Strasbourg, 14 May 2004 ACFC/SR/II(2004)006 SECOND REPORT SUBMITTED BY ITALY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (received on 14 May 2004) MINISTRY OF THE INTERIOR DEPARTMENT FOR CIVIL LIBERTIES AND IMMIGRATION CENTRAL DIRECTORATE FOR CIVIL RIGHTS, CITIZENSHIP AND MINORITIES HISTORICAL AND NEW MINORITIES UNIT FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES II IMPLEMENTATION REPORT - Rome, February 2004 – 2 Table of contents Foreword p.4 Introduction – Part I p.6 Sections referring to the specific requests p.8 - Part II p.9 - Questionnaire - Part III p.10 Projects originating from Law No. 482/99 p.12 Monitoring p.14 Appropriately identified territorial areas p.16 List of conferences and seminars p.18 The communities of Roma, Sinti and Travellers p.20 Publications and promotional activities p.28 European Charter for Regional or Minority Languages p.30 Regional laws p.32 Initiatives in the education sector p.34 Law No. 38/2001 on the Slovenian minority p.40 Judicial procedures and minorities p.42 Database p.44 Appendix I p.49 - Appropriately identified territorial areas p.49 3 FOREWORD 4 Foreword Data and information set out in this second Report testify to the considerable effort made by Italy as regards the protection of minorities. The text is supplemented with fuller and greater details in the Appendix. The Report has been prepared by the Ministry of the Interior – Department for Civil Liberties and Immigration - Central Directorate for Civil Rights, Citizenship and Minorities – Historical and new minorities Unit When the Report was drawn up it was also considered appropriate to seek the opinion of CONFEMILI (National Federative Committee of Linguistic Minorities in Italy). -

Archivio Di Stato Di Udine
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Archivio di Stato di Udine SCHEDA FONDO 3.1.2 Denominazione o titolo Archivio dell' Ufficio di leva di Udine 3.1.3 Data/e Classi 1834-1940; soggetto a versamenti annuali 3.1.4 Livello di descrizione fondo 3.1.5 Consistenza e supporto regg. 3911 dell'unità archivistica 3.2.1 Denominazione del soggetto Ufficio di leva di Udine produttore 3.2.2 Storia Il processo di unificazione amministrativa del Regno d’Italia in campo militare ebbe inizio con la leva del 1863. istituzionale/amministrativa del La legge 13 luglio 1862 n. 696 chiamava infatti alle armi tutti i cittadini italiani maschi nati nell’anno 1842. Il soggetto produttore nuovo governo italiano non procedette in fase di unificazione alla promulgazione di un nuovo regolamento su leva e reclutamento, ma si limitò ad estendere a tutto il territorio annesso le normative previste dal governo sabaudo: la legge organica del 1854 (legge La Marmora) e il regolamento per il reclutamento del 1855 . Tali disposizioni entrarono in vigore nelle province venete ed in quella di Mantova nel 1866 con i regi decreti 4 e 16 dicembre. Il 4 marzo 1867 il prefetto della provincia di Udine, Giovanni Lanzi, inviava pertanto ai sindaci la circo- lare n. 2892 avente per oggetto la formazione delle liste di leva . Gli organi preposti al complesso delle operazioni della leva erano gli uffici comunali di leva, il ministero della guerra e a livello provinciale i Consigli e gli Uffici di leva. Il Consiglio di leva era presieduto dal prefetto (o dal sottoprefetto se si trattava di un capoluogo di circondario), da due consiglieri designati dal consiglio provinciale e da due ufficiali superiori o capitani rappresentanti il ministero della guerra. -

Centri Per L'impiego
CENTRI PER L’IMPIEGO Provincia di Udine CPI Recapiti telefonici Fax E-mail Indirizzo 0432 209450 e 209453 informazioni utenza 0432 209430, 209431 e 209451 informazioni aziende 0432 209433 e 209460 Viale Duodo, 3 UDINE 0432 209570 [email protected] informazioni mobilità 33100 Udine 0432 209452, 209438 e 209455 servizio ricerca personale 0432 209 410 collocamento obbligatorio aziende Via Ramazzotti, 16 CERVIGNANO DEL FRIULI 0431 388 211 informazioni utenza 0431 388288 [email protected] 33052 Cervignano del Friuli 0432 731 451 informazioni utenza Stretta S. Martino, 4 CIVIDALE DEL FRIULI 0432 704672 [email protected] 0432 701 125 33043 Cividale del Friuli informazioni utenza 0432 740 644 Via Natisone, 34 MANZANO 0432 740644 [email protected] informazioni utenza 33044 Manzano 1 0432 906252 Via Manzoni, 2 CODROIPO 0432 912710 [email protected] informazioni utenza 33033 Codroipo 0432 981033 Via Santa Lucia, 25/27 GEMONA DEL FRIULI 0432 970315 [email protected] informazioni utenza 33013 Gemona del Friuli 0431 5026 informazioni utenza Via Manzoni, 48 LATISANA 0431 512298 [email protected] 0431 59545 33053 Latisana informazioni utenza Viale Europa, 115 0431 427041 LIGNANO SABBIADORO 0431 427041 [email protected] 33054 Lignano informazioni utenza Sabbiadoro 0428 90932 Piazza Garibaldi, 1 PONTEBBA 0428 90397 [email protected] informazioni utenza 33016 Pontebba 0432 957248 Via Udine, 2 S. DANIELE DEL FRIULI 0432 942504 [email protected] -

Formato Europeo Per Il Curriculum Vitae
CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Cognome, Nome ZOZ Fabio Indirizzo 24, Via Don Domenico Tessitori, 33015, MOGGIO UDINESE (UD), ITALY Nazionalità Italiana Data di nascita 28/09/1987 ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) 06/08/2020 – in corso • Nome e indirizzo Comune di del datore di lavoro Cercivento (UD) • Tipo di azienda o settore Area Tecnica e Tecnico-manutentiva – tempo indeterminato • Tipo di impiego Istruttore direttivo tecnico (Cat. D p.e. 1) • Principali mansioni e responsabilità LAVORI PUBBLICI: predisposizione domande di contributo, programmazione degli interventi, esecuzione gare per servizi tecnici, validazione progetti, esecuzione gare d’appalto per lavori, servizi e forniture, gestione dei procedimenti (R.U.P.), acquisti mediante piattaforme telematiche di negoziazione (eAppalti FVG e MEPA), direzione lavori e gestione tecnico-amministrativa dei lavori, predisposizione atti inerenti, aggiornamento banche dati ANAC (AVCPass e SIMOG), BDAP e SimonWEB; URBANISTICA E AMBIENTE: disciplina degli scarichi, predisposizione e gestione iter inerente varianti urbanistiche predisposizione atti inerenti, segnalazione dissesti idrogeologici sul territo- rio; EDILIZIA PRIVATA: disciplina dell’edilizia, controllo e vigilanza dell’attività edilizia predisposi- zione atti inerenti; PATRIMONIO E MANUTENZIONI: manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stra- dale ed immobiliare dell’Ente, gestione tecnico-amministrativa della proprietà forestale, manu- tenzione del parco mezzi dell’Ente predisposizione atti inerenti; PROTEZIONE -

Campoformido Basaldella
V ia Gen. BRESSA Dalla V Chiesa V ia ia Don Corone Piemonte Felice Per Colloredo di . P Zuliani, ia V S. Barbara Via V ia V di Mezzo Via Don ia Gen. Via V Via S. Barbara V del Pietro Boria ia Via Corone ia Dalla Ledra dei Don P Pascoli Scuola Elementare V Mezzo Pegoraro di AV ia Via Chiesa dei Via Caduti 11 Febbraio AV V ia della V ia 11 Febbraio Via da Udine Per Pasian di Prato P P ViaV G. S. G. Bosco V ia P V ia V V di igna V ia ia Mons. ia P Viotte Piemonte Via del Immacolata V Presani P ia Udine Fresco P Alfieri Via P F P . Lucis Piazza Via Udine Unione P V P ia Don D'Agostino V ia 4 ia Basiliano Novembre Per Pasian di Prato V ia Napoleonica AV Udine V Via Nevol Per Villa Primavera Per Per Basiliano Mimose Udine delle Viale Str FERROVIA VENEZIA Str Str Str . delle . degli dei dei AV Variano Betulle T Via Lecci Parco del Aceri T igli LEGENDA Cormor ANGENZIALE AV V Chiese Str. dei Cedri ia Scuola Cormor V Materna ia Viale delle Rose UDINE S. Cimiteri Str ASSONS Caterina P . DI AUTOSTRADA dei Str. degli Abeti CANALE OVEST T Campi da Calcio P igli P CAMPOFORMIDO Str. PT Uffici Postali dei Carpini Udine Club Str. delle Robinie Str. dei Salici AV Aree Verdi Attrezzate Per Via Beato V Parco del ia Aereo Patriarchi Friulano Bertrando V P Parcheggi Pubblici Mariuzza BOSCHETE Villaggio V ia Udine P P Azzurro Via iale dei Cormor Cormor P P FURLANE Marquardo Per iale Palestra V Pasco Udine dei AV di Via LEGENDA CASSONETTI . -

Comune Di AMARO (UD) Comune Di
DIVISIONE ESERCIZIO Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 [email protected] www.fvgstrade.it Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento Dell’unico socio Regione Autonoma FVG Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v. Reg. Imp. di TS n . 01133800324 - REA 127257 Documento trasmesso esclusivamente Alla Prefettura di Udine via posta elettronica o telefax Alla Prefettura di Pordenone Alla Prefettura di Trieste Alla Questura di Udine Alla Questura di Pordenone Alla Questura di Trieste Al Compartimento Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia Alla Sezione Polizia Stradale di Udine Alla Sezione Polizia Stradale di Pordenone Alla Sezione Polizia Stradale di Trieste Al Comando Regionale Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Udine Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pordenone Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Trieste Al Comando Provinciale Carabinieri di Udine Al Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone Al Comando Provinciale Carabinieri di Trieste Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trieste Alla Croce Rossa Italiana di Udine Alla Croce Rossa Italiana di Pordenone Alla Croce Rossa Italiana di Trieste Alla SORES Alla SOGIT Al CCISS Al Servizio viabilità di interesse locale e regionale per il tramite della segreteria del Direttore Generale Alla Direzione Regionale Infrastrutture e Trasporti Alla Direzione Regionale della Protezione Civile All’ ANSA – Agenzia di Stampa Alla RAI del Friuli Venezia Giulia All’ ANAS S.p.A. -

Regolamento Comunale Per La Telefonia Mobile
COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA REGOLAMENTO COMUNALE TELEFONIA MOBILE Comune di Villa Santina Regolamento Comunale per la telefonia Mobile Relazione di accompagnamento alla cartografia COMUNITÀ MONTANA CARNIA REGOLAMENTO COMUNALE TELEFONIA MOBILE INDICE QUADRO CONOSCITIVO .......................................................................................... 2 1. La normativa: natura e contenuti del Regolamento Comunale per la Telefonia Mobile (R.C.T.M.) ........................................................................................ 2 2. Il territorio di riferimento: caratteri fisico-funzionali e unità di paesaggio .... 3 3. Gli impianti esistenti: consistenza e localizzazione .......................................... 5 All. Schede di valutazione della localizzazione e delle condizioni visuali-percettive 9 4. La cartografia di supporto al R.C.T.M. ai sensi della normativa regionale .. 17 Contenuti della Cartografia ................................................................................................ 17 Metodologia di raccolta dei dati .......................................................................................... 19 Cartografia di base ............................................................................................................... 19 Le Stazioni Radio Base i Piani di Sviluppo e le misure di campo. ................................... 20 Criteri per la classificazione della aree .............................................................................. 21 Aree controindicate per la localizzazione