Incognita Libia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Crisis Committee
CRISIS COMMITTEE Lyon Model United Nations 2018 Study Guide Libyan Civil War !1 LyonMUN 2018 – Libyan Civil War Director: Thomas Ron Deputy Director: Malte Westphal Chairs: Laurence Turner and Carine Karaki Backroom: Ben Bolton, Camille Saikali, Margaux Da Silva, and Antoine Gaudim !2 Director’s Welcome Dear Delegates, On behalf of the whole team I would like to welcome you to LyonMUN 2018 and this simulation of the Libyan Civil War. It is strange to feel that such an important topic that we all remember happening is already over 7 years old. Therefore, we felt it would be a good time to simulate it and think about the ways it could have gone. As delegates you will each be given characters to play in this crisis. These were real people who made a difference within the actual Civil War and have their own objectives and goals. You are tasked with advancing the goals of your character and making sure that they end up doing well out of this crisis. Every action will have consequences, everything you do will have ramifications, and mistakes can be deadly. Your chairs will be there to help but they will also be representing characters and have their own interests, meaning they may not be fully trustworthy. Behind the scenes you will have a backroom which will interpret your directives and move the plot forward. We will be there to read what you say and put it into action. However, a word to the wise, the way your wish may be interpreted may not be ideal. -

Philanthropy in Egypt, Libya and Tunisia 2011-2013
Giving in Transition and Transitions in Giving: Philanthropy in Egypt, Libya and Tunisia 2011-2013 May 2013 4 Contents 1) Introduction ..................................................................................................................................................................6 2) Chapter 1: Egypt ..........................................................................................................................................................14 2.1) Introduction.......................................................................................................................................................15 2.1.1) Mass Mobilization and a Rethinking of Egyptian Philanthropy .........................................................15 2.1.2) Methodology and Challenges..................................................................................................................15 2.2) Institutional Philanthropy, the Regulatory Environment and Definitional Confusion................................15 2.3) A Leap of Faith: Citizen Philanthropy and an Interfaith Movement.............................................................17 2.3.1) Institutionalized Philanthropy and Mixed Responses...........................................................................18 2.3.2) Youth, Informal Philanthropy and the Egyptian Awakening ................................................................22 2.4) Financing Philanthropy and Restrictions to the Sector .................................................................................25 -

WRAP Theses Alfasi 2017.Pdf
A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick Permanent WRAP URL: http://wrap.warwick.ac.uk/101760/ Copyright and reuse: This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. For more information, please contact the WRAP Team at: [email protected] warwick.ac.uk/lib-publications Political Agency and the Symbolic Legacy of Authoritarian Regimes: The Case of Libya Kawther Nuri Alfasi A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Politics and International Studies University of Warwick Department of Politics and International Studies September 2017 Contents Acknowledgements iii Abstract iv List of Acronyms v 1 Introduction 1 1.1 Why Study Political Agency? Why Authoritarianism? 2 1.2 Political Agency and the Libyan Uprising of 2011 7 1.3 Theoretical Framework 11 1.4 Research Methods and Reflexivity 16 1.5 Chapter Outline 21 2 Literature Review: Political Agency in the Middle East 25 2.1 Introduction 25 2.2 Political Agency and Resilient Autocracy 26 2.3 Political Agency: Beyond Democratisation and Authoritarian Resilience 32 2.4 Political Agency and the Arab Spring 38 2.5 Political Agency under Authoritarianism: Toward a Point of Enquiry 46 3 Theoretical Framework 48 3.1 Introduction 48 3.2 Structural Social Movement Theory 49 3.2.1 -

Alternatif Politika Is Devoted to the Arab Revolts of 2011 –The Series of Dynamic Social and Political Developments Not Seen in the Arab World for Over Fifty Years
alternatif politika Cilt 3, Sayı 3, Kasım 2011 Misafir Editör: Prof. Bogdan SZAJKOWSKİ Timeline of the Arab Revolt: December 2010-June 2011 Bogdan SZAJKOWSKİ Social Media Tools and the Arab Revolts Bogdan SZAJKOWSKİ The Social Opposition Movement in Syria: The Assad Regime in the Context of Reform and Revolution Veysel AYHAN European Union’s Ineffective Middle East Policy Revealed after Revolution in Tunisia Bahar Turhan HURMİ Libyan Uprising And International Intervention: NATO’s Mission and Libya’s Gridlock Veysel AYHAN Arab Spring and Israeli Security: The New Threats Dünya BAŞOL Background of the Tunisian Revolution Nebahat TANRIVERDİ alternatif politika Cilt 3, Sayı 3, Kasım 2011 Introduction- Bogdan SZAJKOWSKİ, i-ii. Timeline of the Arab Revolt: December 2010 – June 2011- Bogdan SZAJKOWSKİ, 256-419. Social Media Tools and the Arab Revolts-Bogdan SZAJKOWSKİ, 420-432. The Social Opposition Movement in Syria: The Assad Regime in the Context of Reform and Revolution-Veysel AYHAN, 433- 454. European Union’s Ineffective Middle East Policy Revealed after Revolution in Tunisia-Bahar Turhan HURMİ, 455-489. Libyan Uprising And International Intervention: NATO’s Mission and Libya’s Gridlock-Veysel AYHAN, 490-508. Arab Spring and Israeli Security: The New Threats-Dünya BAŞOL, 509-546. Background of the Tunisian Revolution-Nebahat TANRIVERDİ, 547-570. INTRODUCTION Guest Editor: Prof. Bogdan Szajkowski This special issue of Alternatif Politika is devoted to the Arab revolts of 2011 –the series of dynamic social and political developments not seen in the Arab world for over fifty years. Throughout 2011 the Middle East, the Gulf region, Arab Peninsula and North Africa have witnessed social and political turmoil that has fundamentally impacted not only on these regions but also on the rest of the world. -

2Nd Quarter ASPJ
http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/aspj_f/Index.asp ASPJ–Afrique etFrancophonie2 2e trimestre 2014 Volume 5, No. 2 e Aron Shai, PhD Shai, Aron 2014 Trimestre Relations and Future Prospects Future and Relations Réseautage pour une voix politique des femmes dans les sociétés China and Israel Israel and China déstabilisées du Moyen Orient et de l’Afrique Une étude préliminaire Cheryl Van Den Handel, PhD Jennifer Edwards, PhD Andrej Zwitter, PhD Zwitter, Andrej Jacqueline Watson State of Emergency and Constitutional Reform Constitutional and Emergency of State The Arab Uprising Arab The Un capitalisme africain néo-patrimonial ? Aventures conceptuelles via John Kenneth Galbraith Adam Sneyd, PhD Sneyd, Adam Adam Sneyd, PhD Conceptual Adventures via John Kenneth Galbraith Kenneth John via Adventures Conceptual Neopatrimonial African Capitalism? African Neopatrimonial Le Printemps arabe État d’urgence et réforme constitutionnelle Jacqueline Watson Jacqueline Andrej Zwitter, PhD Jennifer Edwards, PhD PhD Edwards, Jennifer Cheryl Van Den Handel, PhD PhD Handel, Den Van Cheryl A Preliminary Study Preliminary A Societies of the Middle East and Africa and East Middle the of Societies La Chine et Israël Networking for Political Voice among Women in Disrupted Disrupted in Women among Voice Political for Networking Relations et perspectives futures Aron Shai, PhD Volume 5, No. 2 No. 5, Volume 2014 Quarter 2nd ASPJ–Africa and Francophonie 2nd Quarter 2014 Chief of Staff, US Air Force Gen Mark A. Welsh III Commander, Air Education and Training Command Gen Robin Rand Commander and President, Air University http://www.af.mil Lt Gen David S. Fadok Director, Air Force Research Institute Allen G. -

December 2015, the Anniversary of the Death of Prize Founder Occurring Microorganisms in Pharmaceuticals to Treat Alfred Nobel
MONTHLY ISSUE - DECEMBER - 2015 CurrVanik’s ent Affairs Banking | Railway | Insurance | SSC | UPSC | OPSC | PSU Vanik’s Page 200 Updated MCQs y) reliminar 100 One Liners or IBPS-Clerk (P ractice Set f Two P -Clerk (Main) 40 MCQs on Computers e Set for IBPS Two Practic e Set for CHSL 100 GK for SSC & Railway One Practic Vanik’s Knowledge Garden Leading Institute for Banking, Railway & SSC P u b l i c a t i o n s VANIK'S PAGE COUNTRY, CAPITAL & CURRENCY BOOKS AUTHOR S BOOK S AUTHOR S A Bend in the River V.S. Naipul Death of a patriot R.E. Haring ton A House for Mr. Biswas V.S. Naipul Decline and fall of a Edward Gibbon Roman Empir e A million Mutinies now William Shakespear e Diplomacy Henry Kissing er A passage to England Nirad C.Choudhari Discovery of India Jawahar lal Nehru A passage to India E.M Foster Divine lif e Swami Sivananda A prisoner’s scrap Book L.K.Advani Family matter s Rohinton Mis try A suitable Boy Vikram Seth Final Days .The Bob Woodward and carl Berns tein A thousand Days Arthur M Schlesigner Freedom Revolution Thomas Carlyle Alls Well that Ends Well William Shakespear e Freedom at midnigh t Larry collines and Dominique Lapierr e Amar Kosh Amar Singh Gardener Rabindranath Tag ore An American Dilema Gunner Myrdal Ghasiram Kotw al Vijay tendulk ar An Areas of Darkness V.SNaupul Gitanjali Rabindranath Tag ore An Autobiography Jawahar lal Nehru Good time Bad Time Harod Ev ans An Equal Music Vikram Seth Half a lif e V.S.Naipul An Idealistic view of life Dr.S.Radhakrishanan Halme t W.Shakespear e Anandmath Bikram Chandra Harry poter and the J.K.Rowling Chaterjee Goblet of pow er As you like it William Shakespear e Hindu view of life Dr .S. -

USA Ready for Trade
Eli Hazan Peter Lundgren MEP THE THIS TIME I’M VOTING MAGICIAN NEXT WEEKEND IN So, how did this happen? How is EUROSCEPTIC it possible that despite everything We should do everything we can to described in the international oppose the use of institutions that media, the Israeli public trusts should be neutral in the elections p.20 Netanyahu over and over again? p.9 for party political purposes. p.9 Issue #6 | May 2019 A fortnightly Newspaper by the Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE) | theconservative.online ECR Group CONSERVATIVES CONTINUE TO Photo: Shutterstock.com Photo: GROW When the ECR Group was founded in 2009, many critics said that it would not survive on. They said it was impossible to split from the EPP. However it managed to sur- vive and grow, and became the third largest group in the Euro- pean Parliament. p.3 Richard Milsom WE MUST ACT NOW TO SAVE THE BALTIC The Baltic takes on a further importance when it comes to security. As we all know, Russia is a Baltic state. It’s largest naval ports are on to the Baltic. p.8 Profile ELISABETTA GARDINI High-profile EPP MEP from Forza Italia, joins ECR p.10 panish voters went to increased number of seats. direction of Spain’s economy, three parties have managed party. This government found the polls on Sunday The Socialists are set to return as well as debate about the to secure 40% of the popular itself in difficulty following 28 April to decide the with an increased majority. -
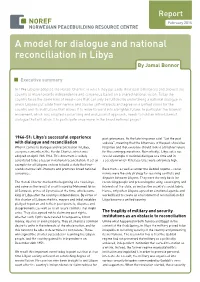
A Model for Dialogue and National Reconciliation in Libya
Report February 2015 A model for dialogue and national reconciliation in Libya By Jamal Bennor Executive summary In 1946 Libyans adopted the Harabi Charter, in which they put aside their past differences and allowed the country to move towards independence and consensus based on a shared national vision. Today the country faces the same kind of need – one that can only be fulfilled by undertaking a national dialogue in which Libyans put aside their narrow and divisive self-interests and agree on a unified vision for the country and its institutions that allows it to move forward into a brighter future. In particular the Islamist movement, which has adopted a polarising and exclusionist approach, needs to hold an intra-Islamist dialogue that will allow it to participate once more in the broad national project. 1946-51: Libya’s successful experience past grievances. As the late king once said: “Let the past with dialogue and reconciliation subside”, meaning that the bitterness of the past should be When it comes to dialogue and reconciliation in Libya, forgotten and that everyone should look to a brighter future everyone remembers the Harabi Charter, which was for the coming generations. Remarkably, Libya set a suc- adopted on April 18th 1946. This document is widely cessful example of national dialogue at a time and in considered to be a lesson in national reconciliation. It set an a society in which illiteracy rates were extremely high. example for all Libyans on how to build a state that tran- scends narrow self-interests and promotes broad national Back then – as well as under the Qaddafi regime – social consensus. -

Apple's Visionary Redefined Digital
Apple‘s Visionary Redefined Digital Age 3 Celebrating Frugality 11 Google Books as index 14 The Revolution Arrived, Then It Was Drawn 15 'A Good Investment' 19 Geneticists Develop Promising Mouse Model for Testing New Autism Therapies 22 New Scrutiny on Law School Data 25 When Life Becomes Art 28 Occupied, Dissatisfied 31 400 Years Old and Ageless 35 Reverse Brain Drain 38 Galaxy Caught Blowing Bubbles 41 New Higher Education Model 43 Modernist Landmark Behind a Court Battle 45 Online Higher Education's Individualist Fallacy 48 Earth's Plant Life 'Recycles' Carbon Dioxide Faster Than Previously Estimated 50 A Little History of Philosophy 53 Placing Islamic Art on a New Pedestal 56 Hofstadter‘s 'Lost' Book 60 Astronomers Reveal Supernova Factory 66 Family-Friendly Science 68 Sharks Are in Trouble, New Analysis Confirms 70 A Multi-Part Question 72 How to Procrastinate and Still Get Things Done 74 Academic Publishing and Zombies 76 Single Dose of 'Magic Mushrooms' Hallucinogen May Create Lasting Personality Change 81 Mining Student Data Could Save Lives 84 Correcting Sickle Cell Disease With Stem Cells 87 Saving the 'Lost Boys' of Higher Education 89 Fish Uses Tool to Dig Up and Crush Clams 91 Collaborative Learning for the Digital Age 93 Easily Embarrassed? Study Finds People Will Trust You More 100 Cultural Divide Persists as Musical Tastes Shift 102 Scientists Reveal Molecular Sculptor of Memories 105 Sistema de Infotecas Centrales Universidad Autónoma de Coahuila Conversion Therapy Fails to ‗Pray Away the Gay‘ 107 Cosmic Weight Watching Reveals Black Hole-Galaxy History 110 Among Antibiotics, Resistance Knows No Bounds 112 Performance Surpasses Existing Rechargeable Batteries and Supercapacitors 116 Sweetener Death Match: Sugar vs. -

Libya's Floundering Transition | the Washington Institute
MENU Policy Analysis / PolicyWatch 1903 Libya's Floundering Transition by Andrew Engel Feb 21, 2012 ABOUT THE AUTHORS Andrew Engel Andrew Engel, a former research assistant at The Washington Institute, recently received his master's degree in security studies at Georgetown University and currently works as an Africa analyst. Brief Analysis Washington should help improve conditions on the ground in Libya before the upcoming parliamentary elections, supporting civil society organizations that include rebels and prodding the interim government toward greater transparency. ebruary 17 marked the one-year anniversary of the Libyan revolution, yet the country's transition toward F democracy has floundered due to mismanagement by the interim government. Plans to hold parliamentary elections by June 23 are under way regardless of the domestic situation -- or how many rebels remain armed. In response, Washington should do what it can to encourage a more amicable electoral environment, one that includes rebels as stakeholders. Governing by Crisis S ince Muammar Qadhafi's fall, both Mustafa Abdul Jalil's National Transitional Council (NTC) and Prime Minister Abdul Rahim al-Keib's interim cabinet have been unable to exert authority evenly throughout Libya. As a result, the security situation has deteriorated, and public confidence in the transition has plummeted. Today, the interim government makes its presence felt only at times of crisis, intervening to stem intra-rebel fighting, human-rights abuses, protests against the national leadership, and rebel attempts to impose control over pro-Qadhafi towns. Top officials have been dispatched to mediate such crises, from Abdul Jalil and al-Keib to Defense Minister Osama Juwaili and Sheikh Sadiq al-Ghiryani, the country's leading religious figure. -

Download Download
Trípodos, número 30 | Barcelona 2012 | 57-81 Rebut / Recived: 12/02/2012 ISSN: 1138-3305 Acceptat / Accepted: 15/06/2012 57 Media and Revolution in Lybia1 TRÍPODOS 2012 | 30 Jacobo Quintanilla Director of Humanitarian Media for Internews Network Jamal Dajani Vice President of Middle East, North Africa, Latin America and the Caribbean, Internews Network An exuberant proliferation of media Una incessant proliferació de mitjans de outlets is emerging in areas contro- comunicació està emergent en àrees sota lled by Libya’s rebels. The ability to control dels rebels libis. La capacitat de talk openly, publish, and broadcast parlar obertament, i de publicar i trans- without fear is an unprecedented free- metre sense cap tipus de por, significa una dom for a society repressed and hea- llibertat desconeguda per a una societat vily censored for decades, and one reprimida i durament censurada durant that is being seized with energy and dècades i que ara avança amb energia enthusiasm. This is a monumental — i entusiasme. Això representa un canvi indeed revolutionary— shift in Libyan extraordinari —autènticament revolucio- politics and society, and is one of the nari— en la política i la societat líbies i key channels for the extraordinary le- és un dels canals clau per l’extraordinari vel of energy released by the uprising. nivell d’energia alliberat per la revolta. New initiatives include print and sate- Noves iniciatives inclouen publicacions, llite TV; terrestrial TV and radio; mul- televisió per satèl·lit, televisió i ràdio ter- tiple online collaborations; as well as restres, múltiples col·laboracions online, cartoons, music, graffiti, theatre, and així com tires còmiques, graffitti, teatre other forms. -

UNSMIL) for a Three-Month Period Until 16 March 2012
United Nations S/2012/129 Security Council Distr.: General 1 March 2012 Original: English Report of the Secretary-General on the United Nations Support Mission in Libya I. Introduction 1. The present report is submitted pursuant to Security Council resolution 2022 (2011), by which the Council extended the mandate of the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) for a three-month period until 16 March 2012. The report covers major developments since my report of 22 November 2011 (S/2011/727) and describes the activities undertaken by UNSMIL in line with its mandate under Security Council resolutions 2009 (2011), 2017 (2011) and 2022 (2011). It also assesses the challenges facing Libya as it continues its historic transition, and provides recommendations on the future role of the Mission in Libya. II. Political and security developments 2. On 17 February 2012, the people of Libya marked the first anniversary of the beginning of the Libyan revolution and their struggle for freedom after almost 42 years of authoritarian rule. Despite concerns that there might be attempted attacks or disruptions by pro-Qadhafi elements, the anniversary passed peacefully as public celebrations took place in cities and towns nationwide, with effective security operations coordinated among State security forces and key “brigades”. While celebrations were intended to commemorate those who died in the struggle for freedom, they also signalled hope for the future. 3. In speeches to the nation, Mustafa Abdul Jalil, Chair of the National Transitional Council, and Abdurrahim el-Keib, the Prime Minister acknowledged the sacrifices of the Libyan people, noted the challenges ahead and emphasized the importance of institution-building, particularly the need for revolutionaries to support national security institutions.