Città Metropolitana Di Bari
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Comune Di Turi (Ba)
COMUNE DI TURI (BA) - ELENCO GIUDICI POPOLARI CORTE D'ASSISE DI APPELLO BIENNIO 2017-2018 - DEFINITIVO E CORRETTO COGNOME NOME Sesso Data Nasc Luogo Nascita RESIDENZA_INDIRIZZO Residenza PROFESSIONE TITOLO_DI_STUDIO ACITO ANNA F 27/01/1969 TURI STRADA MOLA II TRAVERSA DX, 9 p. 3 TURI IMPIEGATA DIPLOMA DI PERITO COMMERCIALE ACITO CATERINA F 25/07/1965 TURI STRADA CASAMASSIMA, 122/G p. 1 TURI CASALINGA DIPLOMA DI MATURITA' SCIENTIFICA ACITO PASQUA F 07/08/1963 TURI VIA FRATELLI SPINELLI, 47 TURI COMMERCIANTE DIPLOMA DI MATURITA' MAGISTRALE ALBANESE MARIA ANTONIA F 05/10/1953 TURI VIA LUDOVICO D'ADDABBO, 2 TURI IMPIEGATO DI UFFICIO DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA ALBANO PALMA F 13/09/1963 TURI VIA STEFANO CAMPOSEO, 1 TURI INSEGNANTE ELEMENTARE LICENZA DI SCUOLA MAGISTRALE ALBERGO ANNA MARIA F 08/09/1968 GIOIA DEL COLLE VIA CAVOUR, 66 TURI CASALINGA DIPLOMA DI MATURITA' ARTISTICA ALBU ALINA MARIA F 09/03/1985 BUCAREST STRADA GIOIA CANALE I TRAVERSA SX, 25 int. 3 p. 2 TURI LIBERO PROFESSIONISTA LAUREA GIURIDICA ALESSANDRELLI GIUSEPPE M 30/11/1956 TURI STRADA MOLA, 60 TURI PERITO CHIMICO DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO ANTONICELLI PRIMULA MARIELLA F 16/08/1957 MASSAFRA VIA FRANCESCO AVELLA, 2 TURI COLTIV. AGRICOLA COAD. DIPLOMA DI PERITO AGRARIO ARRE' ANNA TERESA F 19/11/1956 TURI VIA GUGLIELMO DE DONATO, 149 TURI IMPIEGATA DIPLOMA DI MATURITA' MAGISTRALE ARRE' FILIPPO M 20/06/1957 TURI VIA CASTELLANA, 10 TURI INSEGNANTE LAUREA IN LETTERE ARRE' GIOVANNI M 17/04/1959 TURI STRADA PUTIGNANO, 133/1 TURI FUNZIONARIO LAUREA DI INGEGNERIA INDIRIZZO PROGETTAZ -

1389 DEL 15 OTI, 2N20
BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 1389 DEL 15 OTI, 2n20 OGGETTO: AREA GESTIONE RISORSE UMANE -UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO - RILEVAZIONE ZONE CARENTI DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA ASL Bari - ANNO 2020 . Il Direttore Generale Vista la deliberazione n. 1492/2018,con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore GRU — Dott Rodolfo Minervini che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue. Premesso che: a norma dell'ari 33 dell' ACN del 29/7/2009 , come novellato dall'ari 4 dell'ACN 21/6/2018, questa ASL deve determinare le zone carenti per l'iscrizione dei medici specialisti pediatri nell'elenco dei medici convenzionati; in conformità all' art.33 co.1 , come sopra novellato, entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna Regione , o il soggetto da questa individuato pubblica sul BURP, l'elenco degli ambiti territoriali carenti e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 32; il comma 8 dell'ari 32 dell'ACN del 29/7/2009 stabilisce l'iscrizione di un medico pediatra ogni 600 o frazione superiore a 300 assistibili residenti in età compresa tra 0-6; verificato che occorre tener conto delle eventuali limitazioni dei massimali esistenti a carico dei singoli medici già iscritti negli elenchi e che ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze delle limitazioni sullo stesso si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente; la circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale alla Sanità dell' 1.6.98 prot. -

Allegato B Tav.1 02-10-2013 REV
ALLEGATO B -TAV. 1 - DESCRIZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI VALORIZZAZIONE Denominazione del bene o attività (i) Modalità attuali di Dati su presenze e visitatori e/o Interventi realizzati o in corso per la Eventuali fabbisogni Localizzazione (ii) (come al punto B.1) funzionamento e gestione (iii) altri indicatori di performance (iv) valorizzazione del bene o attività (v) di ulteriori interventi (vi) Soggetto proprietario e gestore: A.B.M.C. L'A.B.M.C. Offre un servizio di consulenza per la fruizione del sistema bibliotecario e archivistico attraverso la consultazione degli schedari e del suo patrimonio librario attraverso il sistema nazionale SBN. Sono a disposizione dell'utenza 70 posti con illuminazione autonoma e possibilità di connettere il proprio PC alla rete. Per i beni Nel bilancio preventivo dell'Ente annualmente museali, il personale in servizio presso l'Ente sono indicati alcuni capitoli di spesa riservati ad guida i visitatori lungo un percorso espositivo attività di valorizzazione, approvati dal consiglio ARCHIVIO BIBLIOTECA MUSEO CIVICO I visitatori annui sono aumentati da 25000 nel allestito in due ampie sale. L'Ente pubblicizza il di amministrazione e dall'assemblea dei soci. (A.B.M.C.): Archivio storico; biblioteca; museo Comune di Altamura Fog. 161 p.lla 1181 2008 (13% esterni al Comune) a 40000 nel 2012 suo patrimonio, le attività, i servizi attraverso il Inoltre l'Ente si candida a bandi regionali civico di cui il 15% esterno al Comune suo sito web all'indirizzo www.abmcaltamura.it I accedendo a finanziamenti; in corso vi è un locali in cui si trova l'A.B.M.C. -
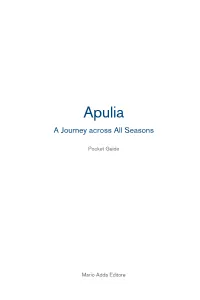
Apulia a Journey Across All Seasons
Apulia A Journey across All Seasons Pocket Guide Mario Adda Editore Regione Puglia AreA Politiche Per lA Promozione del territorio, dei sAPeri e dei tAlenti Servizio Turismo – Corso Sonnino, 177 – cap 70121 Bari Tel. +39 080.5404765 – Fax +39 080.5404721 e-mail: [email protected] www.viaggiareinpuglia.it Text: Stefania Mola Translation: Christina Jenkner Photographs: Nicola Amato and Sergio Leonardi Drawings: Saverio Romito Layout: Vincenzo Valerio ISBN 9788880829362 © Copyright 2011 Mario Adda Editore via Tanzi, 59 - Bari Tel. e fax +39 080 5539502 www.addaeditore.it [email protected] Contents A Journey across All Seasons ....................................................pag. 7 A History ............................................................................................ 9 Buried Treasures ....................................................................................... 11 Taranto’s Treasure ........................................................................ 12 Egnazia ....................................................................................... 12 The Bronzes of Brindisi ............................................................... 13 The Vases of Ruvo ....................................................................... 13 Between Legend and Reality on the Hill of Cannae ....................... 14 Ostuni – Pre-Classical Civilizations ............................................... 14 Caves and Prayers ....................................................................... -

Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie C2 – Girone A
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C2 – GIRONE A Stagione Sportiva 2020-2021 1a Giornata 2a Giornata 3a Giornata 17 Ott 2020 - 23 Gen 2021 24 Ott 2020 - 30 Gen 2021 31 Ott 2020 - 6 Feb 2021 C.U.S. BARI A.S.D. NOX MOLFETTA AUDAX RUTIGLIANO THURIAE ERACLIO CALCIO A 5 NOX MOLFETTA ERACLIO CALCIO A 5 NETTUNO C.U.S. FOGGIA A.S.D. FUTSAL BYRE RUVO FUTSAL BYRE RUVO VIGOR BARLETTA FUTSAL BYRE RUVO AUDAX RUTIGLIANO EMMEBI FUTSAL GIOVINAZ POGGIORSINI CALCIO FUTSAL TERLIZZI C.U.S. BARI A.S.D. FUTSAL TERLIZZI REINELLA SPORTING NETTUNO SOCCER ALTAMURA ORTHRUS CANOSA EMMEBI FUTSAL GIOVINAZ ORTHRUS CANOSA C.U.S. FOGGIA A.S.D. NOX MOLFETTA FUTSAL TERLIZZI POGGIORSINI CALCIO NETTUNO POGGIORSINI CALCIO VIGOR BARLETTA REINELLA SPORTING ERACLIO CALCIO A 5 SOCCER ALTAMURA REINELLA SPORTING SOCCER ALTAMURA EMMEBI FUTSAL GIOVINAZ VIGOR BARLETTA ORTHRUS CANOSA THURIAE C.U.S. FOGGIA A.S.D. Riposa................ THURIAE Riposa................ C.U.S. BARI A.S.D. Riposa................ AUDAX RUTIGLIANO 4a Giornata 5a Giornata 6a Giornata 7a Giornata 7 Nov 2020 - 13 Feb 2021 14 Nov 2020 - 20 Feb 2021 21 Nov 2020 - 6 Mar 2021 28 Nov 2020 - 13 Mar 2021 C.U.S. BARI A.S.D. ERACLIO CALCIO A 5 AUDAX RUTIGLIANO VIGOR BARLETTA C.U.S. BARI A.S.D. POGGIORSINI CALCIO AUDAX RUTIGLIANO NETTUNO C.U.S. FOGGIA A.S.D. AUDAX RUTIGLIANO ERACLIO CALCIO A 5 FUTSAL TERLIZZI EMMEBI FUTSAL GIOVINAZ AUDAX RUTIGLIANO C.U.S. FOGGIA A.S.D. EMMEBI FUTSAL GIOVINAZ EMMEBI FUTSAL GIOVINAZ FUTSAL BYRE RUVO FUTSAL BYRE RUVO NETTUNO FUTSAL TERLIZZI SOCCER ALTAMURA FUTSAL BYRE RUVO NOX MOLFETTA NETTUNO ORTHRUS CANOSA ORTHRUS CANOSA REINELLA SPORTING NETTUNO THURIAE ORTHRUS CANOSA C.U.S. -

COMUNE Di SANTERAMO in COLLE [email protected] Provincia Di Bari
Ufficio Segreteria Generale P.zza Dott.Simone, 8 - C.A.P. 70029 Tel.080.3028303/Fax 080.3036619 Cod. Fisc. 82001050721 – P.IVA 00862890720 COMUNE di SANTERAMO IN COLLE [email protected] Provincia di Bari www.comune.santeramo.ba.it Prot.n. 4835 Li, 23.03.2017 Alla Corte dei Conti sez. Controllo per la Puglia via Matteotti, 56 70120 BARI Trasmessa: Email: [email protected] Pec: [email protected] E, p.c. Collegio dei Revisori dei Conti Sede Municipale OGGETTO: Ricognizione sul processo di razionalizzazione delle società partecipate. (Art.24, commi 1 e 2 del d.lgs. 175/2016). Invio relazione. Con la presente trasmetto la relazione in oggetto d’ordine del Sindaco in formato digitale. Distinti saluti IL SEGRETARIO Gen.le Dott.ssa Anna Maria Punzi Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005 Ricognizione sul processo di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 24, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016) Premessa Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, all’art. 24, così dispone: “1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. -

Acquaviva Delle Fonti Via Privata T. Francavilla, 4 70021 Acquaviva Delle Fonti Ba 0805767366 Adelfia Piazza Galtieri, 41-43
BARI CENTRI ELABORAZIONE ACQUAVIVA DELLE FONTI VIA PRIVATA T. FRANCAVILLA, 4 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA 0805767366 ADELFIA PIAZZA GALTIERI, 41-43 70010 ADELFIA BA 0805767392 ALBEROBELLO PIAZZA ROMA, 16/A 70011 ALBEROBELLO BA 0804322743 ALTAMURA VIA M. CONTINISIO, 9 70022 ALTAMURA BA 0805767363 BARI CARBONARA VIA P. VERRI, 5-5/A 70131 BARI BA 0805767356 BARI POGGIOFRANCO VIA V. DI CAGNO, 32 70124 BARI BA 0805648532 BARI JAPIGIA VIA NATALE LOIACONO, 20/B 70126 BARI BA 0805767533 BARI LIBERTA' VIA E. FIERAMOSCA, 75 70123 BARI BA 0805794296 BARI MADONNELLA VIA VOLPE, 4 70121 BARI BA 0805767695 BARI SAN PAOLO VIA LOMBARDIA, 43-47 70132 BARI BA 0805767352 BARI SANTA RITA VIA R. DI CILLO, 6/E 70131 BARI BA 0805657446 BARI S. SPIRITO VIA NAPOLI, 21/F 70127 BARI BA 0805767357 BITETTO VIA VESCOVADO, 9 70020 BITETTO BA 0805767384 BITONTO VIA N. FORNELLI, 43 70032 BITONTO BA 0805767365 BITRITTO LARGO ODEGITRIA, 9-10 70020 BITRITTO BA 0805767382 CAPURSO VIA ROMA, 33 70010 CAPURSO BA 0805767386 CASAMASSIMA VIA DANTE, 14 70010 CASAMASSIMA BA 0805767372 CASSANO DELLE MURGE VIA DEI MILLE, 7-9 70020 CASSANO DELLE MURGE BA 0805767367 CASTELLANA GROTTE VIA F. CORRIDONI, 15 70013 CASTELLANA GROTTE BA 0805767394 CELLAMARE CORSO ROMA, 45 70010 CELLAMARE BA 0805767393 CONVERSANO VIA G. MAZZINI, 30 70014 CONVERSANO BA 0805767383 CORATO VIA CANOVA, 6 70033 CORATO BA 0805767361 GIOIA DEL COLLE VIA DANTE ALIGHIERI, 30-32 70023 GIOIA DEL COLLE BA 0805767370 GIOVINAZZO VIA G. VERNICE, 35 70054 GIOVINAZZO BA 0805767350 GRAVINA IN PUGLIA VIA MATTEOTTI, 29 70024 GRAVINA IN PUGLIA BA 0805767362 GRUMO APPULA VIA CAPOSTRADA, 15 70025 GRUMO APPULA BA 0805767374 LOCOROTONDO VIA ABRUZZO, 4/6 70010 LOCOROTONDO BA 0805767387 MODUGNO VICO ALBEROTANZA, 8 70026 MODUGNO BA 0805767368 MOLA DI BARI VIA LUNGARO PORTO, 8 70042 MOLA DI BARI BA 0805767378 MOLFETTA VIA ORSINI, 5 70056 MOLFETTA BA 0805767354 MONOPOLI VIA VITT. -

Soci Della Società Consortile a R.L. DISTRETTO
SOCI DELLA SOCIETA' CONSORTILE a r.l. DISTRETTO DEL CIBO SUD EST BARESE N. DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE COMUNE 1 Az. Agr. Iannone Anna Acquaviva delle Fonti 2 Az. Agr. Pietroforte Vincenzo Acquaviva delle Fonti 3 Produttori Agricoli Associati Soc. Coop. Acquaviva delle Fonti 4 Az. Agr. Cassano Alessia Acquaviva delle Fonti 5 Az. Agr. Tenute Chiaromonte Soc.Semp. Soc.Agr. Acquaviva delle Fonti 6 Az. Agr. Bruno Carlo Fabio Acquaviva delle Fonti 7 Az. Agr. Armo'nja di Latorre Giuseppe Acquaviva delle Fonti 8 Agriconetto Soc. Agr. a r.l. Cassano delle Murge 9 Soc. Agr. Polvanera di Cassano Filippo & C. Soc. Semp. Gioia del Colle 10 Az. Agr. De Palo Mario Adelfia 11 Az. Agr. Capozzolo Maria Giuseppe Adelfia 12 Az. Agr. Pirolo Costantino Silvio Adelfia 13 Az. Agr. De Carlo Soc. Agr. Semp. Bitritto 14 De Carlo Srl Bitritto 15 Az. Agr. Carone Arturo Bitritto 16 Az. Siciliani Soc. Agr. Semp. Bitritto 17 Az. Zootecnica San Luca Soc. Agr. Semp. Bitritto 18 Agricola La Fitta Srl Soc. Agr. Casamassima 19 Az. Agr. Fanelli Deodato Silvio Conversano 20 Coop. del Frantoio Sociale di Conversano Soc. Coop. a r.l. Conversano 21 Grotte di San Giacinto Soc. Agr. Srl Conversano 22 GAL Sud Est Barese S.c.ar.l. Mola di Bari 23 Carbonara Srl Mola di Bari 24 Romaneuro Srl Mola di Bari 25 Soc. Agr. Franchini Farm di Franchini G. & C. Sas Mola di Bari 26 Az. Agr. Franchini Vito Mola di Bari 27 Az. Agr. Pinto Domenico Mola di Bari 28 Az. Agr. Martello Matteo Mola di Bari 29 Griseta Srl Soc. -

Verbale Utilizzazioni Su Spezzoni Liceo Musicale
Repubblica Italiana MINISTERO DELL' ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia UFFICIO VII Ambito territoriale per la Provincia di Bari Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 e-mail : [email protected] [email protected] t VERBALE DELLE UTILIZZAZIONI SU SPEZZONI PRESSO I LICEI MUSICALI Art. 6 BIS C.C.N.I. DEL 15/05/2013 - A.S. 2013/14 INSEGNAMENTO n. ore. Ist.di utilizzazione Ist.di completamento orario d'obbligo CHITARRA OSTUNI PIERLUIGI 14 ISA MONOPOLI S.M. "Bregante -Volta" MONOPOLI LOSPALLUTI LEONARDO 16 IM ACQUAVIVA S.M. "Casavola-D'Assisi" MODUGNO DI NOIA COSIMO 6 LC BARLETTA S.M. "Dimiccoli" BARLETTA CLARINETTO CREATORE GIUSEPPE 9 ISA MONOPOLI S.M. "Alighieri" BITRITTO VIRGILIO DOMENICO 6 LC BARLETTA S.M. "Fieramosca" BARLETTA CORNO DE VITIS DARIO G. 6 ISA MONOPOLI S.M. "G.Bianco" FASANO (BR) FLAUTO PASCALI ANTONIO 8 ISA MONOPOLI S.M. "Sarnelli-De Donato" POLIGNANO FANELLI VINCENZO 11 LC BARLETTA S.M. "Dimiccoli" BARLETTA BUCCI PIETRO 15 IM ACQUAVIVA S.M. "Bianco-Pascoli" FASANO PIANOFORTE MONTEMURRO LEONARDO A. 10 IM ACQUAVIVA + 8 LS GRAVINA SASSOFONO LOVECCHIO ANTONIETTA 7 ISA MONOPOLI S.M. "Volta" MONOPOLI TROMBA-TROMBONE NUZZACO DOMENICO 10 IM ACQUAVIVA S.M."Netti" SANTERAMO VALENZANO NICOLA 16 ISA MONOPOLI S.M. "Sarnelli-De Donato" POLIGNANO CARAMIA BARTOLOMEO 5 LS GRAVINA S.M. "Manzoni-Lucarelli" BARI VIOLINO - VIOLA RIZZO GIUSEPPINA 13 ISA MONOPOLI S.M. "Bregante -Volta" MONOPOLI QUARANTA GIOVANNI 5 IM ACQUAVIVA S.M. "Alighieri" BITRITTO VIOLONCELLO TODISCO MADIA 6 ISA MONOPOLI S.M. "Gallo" NOCI LAB. -

Cacciatori Extraprovinciali Ammessi All'esercizio Venatorio Av 2019/2020
CACCIATORI EXTRAPROVINCIALI AMMESSI ALL'ESERCIZIO VENATORIO A.V. 2019/2020 N. ORD. PROT DATA AR COGNOME NOME LUOGO DI NASC. DATA DI NASC. INDIRIZZO RESIDENZA PROV. 1 2722 02/03/2019 ABBATECOLA MICHELE ADELFIA 05/05/1947 VIA FABIO FILZI,3 ADELFIA BA 2 1940 16/02/2019 ABBINANTE CAMILLO BARI 26/10/1960 VIA M. D'ASSIA, 12 BARI - CARBONARA BA 3 2053 22/02/2019 ABBINANTE NICOLA BARI - CARBONARA 29/05/1962 VIA U.FOSCOLO, 157/1 BARI BA 4 106 01/02/2019 ABBINANTE VITO BARI 09/07/1953 VIA MASELLI CAMPAGNA, 186 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA 5 454 01/02/2019 ACHILLE ANTONIO BIAGIO LAVELLO 01/02/2029 VIA P. BORSELLINO, 150 CANOSA DI PUGLIA BT 6 1700 15/02/2019 ACQUAVIVA FRANCO ANDRIA 10/05/1960 VIA TOLOMEO,53E TRANI BT 7 422 01/02/2019 ADDABBO FRANCESCO GIOIA DEL COLLE 01/11/1966 VIA DELLA REPUBBLICA, 45 GIOIA DEL COLLE BA 8 3601 21/03/2019 ADDANTE ALESSANDRO TRIGGIANO 29/10/1985 VIA DEGASPERI,33 CELLAMARE BA 9 792 07/02/2019 AGOSTINO GIANDOMENICO ALBEROBELLO 01/03/1959 C.DA CURCIO,3 ALBEROBELLO BA 10 1308 11/02/2019 AGRUSI VINCENZO ALBEROBELLO 18/01/1967 VIA MARCO LACATENA DECORATO, ALBEROBELLO14 BA 11 1814 20/02/2019 ALBANESE GIOVANNI LOCOROTONDO 16/09/1954 VIA SC 18 C.DA CERROSA, 53 LOCOROTONDO BA 12 2429 19/02/2019 ALBANESE TOMA BITETTO 09/02/1958 VIA BALENZANO, 21 BITETTO BA 13 3404 13/03/2019 ALBERGA VITO BITRITTO 15/11/1950 VIA DIAZ,26 BITRITTO BA 14 738 01/02/2019 ALBERGO ONOFRIO BARI 22/02/1949 VIA DE ROSSI,168 BARI BA 15 456 01/02/2019 ALBERGO GIOVANNI BARI 28/04/1955 VIA VITO DE FANO, 1 BARI BA 16 180 01/02/2019 ALBERGO SAVERIO BARI 03/10/1978 -

BARI Totale Provincia: 79 Società
Regione: PUGLIA - Provincia: BARI 000536 POL. C FERRINI BRINDISI BRINDISI RI 1 000895 A.DIL. BASKET FRANCAVILLA FRANCAVILLA FONTAN RI 1 Codice Società Città Voti 002345 U.S. SAN PIETRO A.S.D. SAN PIETRO VERNOTIC RI 1 000351 A.S.DIL. CUS BARI BARI RI 1 005577 ENDAS PUGLIA BASKET BRINDISI BRINDISI RI 1 000353 A.S.D. PALL. FIORE DI PUGLIA RUVO DI PUGLIA RI 1 005593 PALL. CAROVIGNO CAROVIGNO RI 1 000884 GINNASTICA ANGIULLI BARI RI 1 008056 BASKET BALL SCHOOL S.VITO SAN VITO DEI NORMAN RI 1 001148 A.S.D. FIDENS GIOVINAZZO GIOVINAZZO RI 1 008428 A.S. CLUB GIGANTI CISTERNINO RI 1 002157 A.S.DIL. BASKET CORATO CORATO RI 1 008447 ASSI BASKET BRINDISI A.DIL. BRINDISI RI 1 002898 A. DIL. NUOVA PALL. MOLA MOLA DI BARI RI 1 008448 POL.D. PALL. INVICTA BRINDISI BRINDISI RI 1 003300 A.D. NUOVA U.S. BASKET TRANI TRANI RI 1 012447 S.S.D. ASSI BASKET OSTUNI ARL OSTUNI RI 1 006364 A.G.S.DIL. TORITTO TORITTO RI 1 014712 A.DIL. BASKET CEGLIE CEGLIE MESSAPICA RI 1 006368 A.DIL. SPORTING CLUB BITONTO BITONTO RI 1 017045 POL. ENDAS BOZZANO BRINDISI BRINDISI RI 1 007294 U.S. MONOPOLI MONOPOLI RI 1 017067 A.S.D. BASKET TRE ERRE BRINDISI RI 1 008076 CESTISTICA SANTERAMO SANTERAMO IN COLLE RI 1 026447 A.S. FUTURA BASKET BR BRINDISI RI 1 008080 POL. GIOVENTU' DON BOSCO BARI RI 1 027163 A.S.D. BASKET TORRE TORRE SANTA SUSANN RI 1 010022 POL. OLYMPIA CLUB RUTIGLIANO RI 1 029394 A.S.D. -

Antichi Cuori Urbani Documento Programmatico Di Rigenerazione Territoriale
Comune di Comune di Comune di Adelfia Bitetto Bitritto Piano Integrato di Sviluppo Territoriale ANTICHI CUORI URBANI Rigenerazione degli insediamenti umani DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE (Lr 21/2008 Del.G.R. n.743/19.04.2011) Giugno 2011 Piano Integrato di Sviluppo Territoriale Documento Programmatico di Rigenerazione Territoriale ANTICHI CUORI URBANI Rigenerazione degli insediamenti umani INDICE 1. PREMESSE 1.1 La nuova stagione della pianificazione in Puglia: la rigenerazione urbana e territoriale, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 1.2 Coerenza con gli indirizzi del DSR e con la programmazione FESR 2007-13 1.3 Indirizzi per l 1.4 Metodo e articolazione del Documento Programmatico di Rigenerazione Territoriale 1.5 I processi partecipativi 2. IL SISTEMA DELLE CONOSCENZE 2.1 Nota sulle fonti cartografiche e sulle banche dati p 2.2 Il quadro strutturale e strategico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 2.4 Bozza del PTCP di Bari: sistema insediativo della provincia di bari quadro conoscitivo e interpretazioni 2.4.1 Peculiarità del sistema insediativo provinciale 2.4.3 I1 sistema delle funzioni sovralocali 2.5 Le analisi di cont 2.5.1 Gli abitanti: dinamiche demografiche locali 2.5.2 Gli abitanti: dinamiche socio-economiche locali (dati tratti dal PS MTB) 2.5.3 Territorio e paesaggio 2.5.4 La città storica 2.5.5 Il walfare 3. LE PROSPETTIVE PROGRAMMATICHE: VISION E INDIRIZZI PER IL PIST 3.1 Quadro di coerenza e continuità strategica del PIST 3.2 Descrizione degli ambiti di intervento 3.3 I macro obiettivi generali del PIST 3.4 Gli obiettivi strategici e gli obiettivi specifici del PIST 3.5 Linee di intervento 3.6 Il quadro logico programmatico 1 Piano Integrato di Sviluppo Territoriale Documento Programmatico di Rigenerazione Territoriale ANTICHI CUORI URBANI Rigenerazione degli insediamenti umani 4.