Musica & Figura Figura
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lucrezia Vizzana's Componimenti
“READING BETWEEN THE BRIDES”: LUCREZIA VIZZANA’S COMPONIMENTI MUSICALI IN TEXTUAL AND MUSICAL CONTEXT BY Copyright 2011 KATRINA MITCHELL Submitted to the graduate degree program in the School of Music and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. _________________________________ Chairperson, Dr. Paul Laird _________________________________ Dr. Charles Freeman _________________________________ Dr. Thomas Heilke _________________________________ Dr. Deron McGee _________________________________ Dr. Roberta Freund Schwartz Date Defended: 9 June 2011 The Dissertation Committee for Katrina Mitchell certifies that this is the approved version of the following dissertation: “READING BETWEEN THE BRIDES”: LUCREZIA VIZZANA’S COMPONIMENTI MUSICALI IN TEXTUAL AND MUSICAL CONTEXT _________________________________ Chairperson, Dr. Paul Laird Date approved: 9 June 2011 ii ABSTRACT “Reading Between the Brides”: Lucrezia Vizzana’s Componimenti musicali in Textual and Musical Context There had never been a Bolognese nun known to have published her music when Lucrezia Vizzana’s Componimenti musicali was printed in 1623, nor has there been any since then. This set of twenty motets became a window into the musical world of cloistered nuns in the seventeenth century. Following the research of Craig Monson in Disembodied Voices: Music and Culture in an Early Modern Italian Convent (Berkeley: University of California Press, 1995), this project identifies similarities and differences present in Vizzana’s motets using a number of clarifying means not yet explored. Looking at each work in detail, we are able to surmise some favorite musical devices of Vizzana and how they fit in with other monodists of the day. This project fills a specific lacuna in that ten of the twenty motets are not known to be published in modern notation and are available here for the first time in that form. -

Vocal & Instrumental Music
Legrenzi Canto & Basso Vocal & Instrumental Music Ensemble Zenit Canto & Basso Vocal & Instrumental Music Giovanni Legrenzi 1626-1690 Giovanni Legrenzi Carlo Francesco Pollarolo 1653-1723 Giovanni Legrenzi 1. Sonata ‘La Foscari’ à 2 3’06 6. Sonata ‘La Colloreta’ à 2 2’56 11. Sonata No.2 del Pollaroli 12. Albescite flores à 4 6’14 from Sonate a due, e tre Op.2, from Sonate a due, e tre Op.2, di Venezia 2’54 from Harmonia d’affetti devoti, Venice 1655 Venice 1655 from Sonate da organo di varii Venice 1655 autori, Bologna 1697 Tarquinio Merula 1595-1665 7. Ave Regina coelorum à 2 4’39 2. Canzon di Tarquinio Merula 5’01 from Sentimenti devoti, Venice 1660 from Libro di Fra’ Gioseffo da Ravenna, Ravenna Classense Giovanni Paolo Colonna 1637-1695 Ensemble Zenit MS.545 8. Sonata No.7 del Colonna di Pietro Modesti cornetto · Fabio De Cataldo baroque trombone Bologna 4’31 Gilberto Scordari organ Giovanni Legrenzi from Sonate da organo di varii 3. Plaudite vocibus 5’55 autori, Bologna 1697 Isabella Di Pietro alto · Roberto Rilievi tenor from Acclamationi divote a voce sola, Bologna 1670 Giovanni Legrenzi 9. Suspiro Domine 7’46 4. Hodie collentatur Coeli à 2 6’09 from Acclamationi divote a voce from Harmonia d’affetti devoti, sola, Bologna 1670 Venice 1655 10 Sonata ‘La Donata’ à 2 4’05 Luigi Battiferri 1600-1682 from Sonate a due, e tre Op.2, 5. Ricercare Sesto. Venice 1655 Con due sogetti. 3’58 from Ricercari a quattro, a cinque, e a sei Op.3, Bologna 1699 This recording was made possible with the support of Recording: September 2018, Monastero -

Il Favore Degli Dei (1690): Meta-Opera and Metamorphoses at the Farnese Court
chapter 4 Il favore degli dei (1690): Meta-Opera and Metamorphoses at the Farnese Court Wendy Heller In 1690, Giovanni Maria Crescimbeni (1663–1728) and Gian Vincenzo Gravina (1664–1718), along with several of their literary colleagues, established the Arcadian Academy in Rome. Railing against the excesses of the day, their aim was to restore good taste and classical restraint to poetry, art, and opera. That same year, a mere 460 kilometres away, the Farnese court in Parma offered an entertainment that seemed designed to flout the precepts of these well- intentioned reformers.1 For the marriage of his son Prince Odoardo Farnese (1666–1693) to Dorothea Sofia of Neuberg (1670–1748), Duke Ranuccio II Farnese (1639–1694) spared no expense, capping off the elaborate festivities with what might well be one of the longest operas ever performed: Il favore degli dei, a ‘drama fantastico musicale’ with music by Bernardo Sabadini (d. 1718) and poetry by the prolific Venetian librettist Aurelio Aureli (d. 1718).2 Although Sabadini’s music does not survive, we are left with a host of para- textual materials to tempt the historical imagination. Aureli’s printed libretto, which includes thirteen engravings, provides a vivid sense of a production 1 The object of Crescimbeni’s most virulent condemnation was Giacinto Andrea Cicognini’s Giasone (1649), set by Francesco Cavalli, which Crescimbeni both praised as a most per- fect drama and condemned for bringing about the downfall of the genre. Mario Giovanni Crescimbeni, La bellezza della volgar poesia spiegata in otto dialoghi (Rome: Buagni, 1700), Dialogo iv, pp. -

FRANCESCO SPONGA-USPER COMPOSITORE VENEZIANO DI ORIGINE ISTRIANA Considerazioni Preliminari
FRANCESCO SPONGA-USPER COMPOSITORE VENEZIANO DI ORIGINE ISTRIANA Considerazioni preliminari ENNIO SHPCEVIé Zavod za mu z ik o l o~ k a istrazivanja JAZU CDU 78.071 (497 .13 Istria)d6/ l6• Zagabria Saggio scienti fi co originale L'Istria, penisola dell'Adriatico settentrionale, fu divisa per secoli tra due potestà, l'austriaca e la veneziana. Nell'interno, la Contea di Pisino era sotto il dominio degli Asburgo e, data la sua importanza strettamente continentale, rappresentava un territorio abbastanza uni tario. D'altra parte, l'ex marchesato di Aquileia, divenuto !stria veneta, non costituiva un'unità amministrativa compatta, ma ogni città - ri chiamandosi agli antichi statuti e alle secolari libertà - si ammini strava da sé. I conflitti uscocco-veneti e, in seguito, la guerra tra la Serenissima e gli Asburgo provocarono forti migrazioni della popolazione ed epi demie esiziali. Nei secoli X,VI e XVII l'Istria fu teatro di scontri cruen ti e di una grave decadenza economica. Illustri scienziati, letterati e artisti del territorio istriano tentaro no di eludere l'insicurezza locale e cercarono migliori condizioni esi stenziali nelle varie corti nobiliari e nelle famose università d'Europa. A tale proposito, si citano almeno alcuni di coloro, che si occuparono in un modo o nell'altro dell'arte musicale, Pier Paolo Vergerio il vec chio (1370-1444), celebre Doctor artium e Doctor medicinae di Padova, nell'opera che lo rese illustre - fino al 1500 ebbe circa 20 ristampe - De ingenuis moribus et liberalibus studiis adulescentiae (Padova 1400-1402) ha lasciato alcuni brani, in cui si discute del posto da riser vare alla musica nel curriculum di una istruzione ideale) L'Istria ha dato pure due noti tipografi di ,cose musicali - Andrea Antico da Mon tana (Motovun) operò in Italia 2 e Jacques Moderne da Pinguente (Bu- l SrANISLAV TUKSAR , Musico-theoretical fra gments by two medieval scholars: Herman Dalmatinac and Peter Pavao Vergerije, Sr. -

Bach2000.Pdf
Teldec | Bach 2000 | home http://www.warnerclassics.com/teldec/bach2000/home.html 1 of 1 2000.01.02. 10:59 Teldec | Bach 2000 | An Introduction http://www.warnerclassics.com/teldec/bach2000/introd.html A Note on the Edition TELDEC will be the first record company to release the complete works of Johann Sebastian Bach in a uniformly packaged edition 153 CDs. BACH 2000 will be launched at the Salzburg Festival on 28 July 1999 and be available from the very beginning of celebrations to mark the 250th anniversary of the composer's death in 1750. The title BACH 2000 is a protected trademark. The artists taking part in BACH 2000 include: Nikolaus Harnoncourt, Gustav Leonhardt, Concentus musicus Wien, Ton Koopman, Il Giardino Armonico, Andreas Staier, Michele Barchi, Luca Pianca, Werner Ehrhardt, Bob van Asperen, Arnold Schoenberg Chor, Rundfunkchor Berlin, Tragicomedia, Thomas Zehetmair, Glen Wilson, Christoph Prégardien, Klaus Mertens, Barbara Bonney, Thomas Hampson, Herbert Tachezi, Frans Brüggen and many others ... BACH 2000 - A Summary Teldec's BACH 2000 Edition, 153 CDs in 12 volumes comprising Bach's complete works performed by world renowned Bach interpreters on period instruments, constitutes one of the most ambitious projects in recording history. BACH 2000 represents the culmination of a process that began four decades ago in 1958 with the creation of the DAS ALTE WERK label. After initially triggering an impassioned controversy, Nikolaus Harnoncourt's belief that "Early music is a foreign language which must be learned by musicians and listeners alike" has found widespread acceptance. He and his colleagues searched for original instruments to throw new light on composers and their works and significantly influenced the history of music interpretation in the second half of this century. -

2 Fifteenth Berkeley Festival & Exhibition 2
2 FIFTEENTH BERKELEY FESTIVAL & EXHIBITION 2 june 3–10, 2018 Festival Advisory Committee, Board of Directors & Staff ...............................................................................................2 Festival Supporters ...........................................................................................................................................................3 Welcome ..........................................................................................................................................................................6 Festival Calendar .............................................................................................................................................................8 Main Stage Players Sunday, June 3 Seattle Historical Arts for Kids ...............................................................................................................................14 California Bach Society ..........................................................................................................................................17 Monday, June 4 Christine Brandes & Elizabeth Blumenstock ..........................................................................................................23 Tuesday, June 5 San Francisco Conservatory Baroque Ensemble Students and Alumni ...................................................................27 Davis Senior High School Baroque Ensemble ........................................................................................................30 -

Venice Music Biennale Announces 2021 Programme, ‘Choruses’, September 17-26
VENICE MUSIC BIENNALE ANNOUNCES 2021 PROGRAMME, ‘CHORUSES’, SEPTEMBER 17-26 FIRST MUSIC BIENNALE UNDER ARTISTIC DIRECTOR LUCIA RONCHETTI FIFTEEN WORLD PREMIERES TO BE GIVEN KAIJA SAARIAHO RECEIVES GOLDEN LION LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD Lucia Ronchetti. Photo credit: Vanessa Francia The programme for the 2021 Venice Music Biennale, one of the six Biennale di Venezia that showcase the best in contemporary Architecture, Art, Dance, Film, Music and Theatre, has been announced by Artistic Director Lucia Ronchetti. For her first Biennale as Artistic Director the Italian composer is presenting 15 world premieres over 10 days of performances across Venice under the heading of ‘Choruses.’ ‘Choruses’ will focus on contemporary choral writing through performances of new commissions and some of the most important works of the last 50 years that explore the human voice. The Venice Music Biennale 2021 is fostering a dialogue between the Venetian past and the present, and the possible renaissance of vocal polyphony through performances from major Venetian organisations across the city. The 65th Music Biennale will welcome major European vocal and choral ensembles such as Theatre of Voices from Copenhagen, Neue Vocalsolisten from Stuttgart, Accentus choir from Paris, vocal ensemble Sequenza 9.3 from Paris and SWR Vokalensemble from Stuttgart, as well as the renowned historical Venetian choirs the Cappella Marciana di San Marco and the choir of the Teatro La Fenice. The Festival will open at the Teatro La Fenice with a performance of Oltra mar for choir and orchestra by Kaija Saariaho, winner of the Golden Lion for Music, whose chamber work Only the sound remains will also be presented at the Teatro Malibran. -

Musica Antica in Casa Cozzi
venerdì 14 chiesa febbraio 2020 di San Teonisto ore 20.30 Treviso Splendori della Serenissima Magnificenze della Basilica di San Marco Musica antica in casa Cozzi Made in Venice Musica Serenissima Stagione di musica antica Direzione artistica settima edizione Stefano Trevisi iniziativa promossa da con il patrocinio Fondazione Benetton e il sostegno di almamusica433 organizzata da Culturae srl Città di Treviso Splendori della Serenissima Programma Magnificenze della Basilica di San Marco Il viaggiatore inglese Thomas Coryate (1577–1617), nel dimenticare i molti che, dando ampia diffusione Jacques Buus (1500 ca.–1565) Giovanni Croce (1557–1609) Coryat’s Crudities: Hastily gobled up in Five Moneth’s Travels, al suo lavoro, contribuirono alla creazione di una Recercar primo, 1547, a quattro voci Laudans exultet, 1595, a otto voci pubblicato nel 1611, racconta le memorie del viaggio vera e propria “scuola”. compiuto dal maggio all’ottobre del 1608 tra Francia, La Basilica Marciana, con la sua posizione strategica Iachet Van Berchem (1505–1567), Giovanni Gabrieli (1557 ca.–1612) Svizzera, Germania, Paesi Bassi e Italia. accanto al palazzo Ducale, era il centro musicale più Dominique Phinot (1510 ca.–1556 ca.) O Domine Iesu Christe, 1597, a otto voci E, del suo soggiorno veneziano, descrive la cerimonia attivo di Venezia, connessa com’era alla vita civile, Beati omnes, 1550, a otto voci avvenuta alla Scuola Grande di San Rocco il 16 agosto pubblica e anche religiosa della Repubblica. E così, Giovanni Bassano (1558 ca.–1617) di quel 1608: «era così bella e dilettevole, così tanto nella musica sacra, quanto in quella profana, Adrian Willaert (1490 ca.–1562) Viri Galilaei, 1598, a sette voci eccezionale ed ammirevole, così super eccellente Willaert e i musicisti della Marciana diventarono Te Deum, 1559, a sette voci che non poteva che incantare e meravigliare tutti gli un punto di riferimento importante per gli sviluppi Baldassarre Donato (1525/30–1603) stranieri che non avevano mai sentito niente di simile!» musicali, anche alla moda, della città. -

Down Bea MUSIC '65 10Th YEARBOOK $1
down bea MUSIC '65 10th YEARBOOK $1 The Foundation Blues By Nat Hentoff Jazzmen As Critics By Leonard Feather The Academician Views De Jazz Musician ,By Malcolm E. Bessom The Jazz Musician Views The Academiciau By Marjorie Hyams Ericsson Jazz 1964: Good, Bad, Or Indifferent? Two Views Of The Year By Don DeMicheal And Tom Scanlan Articles by Stanley Dance, Vernon Duke, Don Heckman, George Hoefer, Dan Morgenstern, Pete Welding, and George Wiskirchen, C.S.C., Plus Many Other Features GUITARS Try a Harmony Soon ELECTRIC AT YOUR GUITARS gt AMPLIFIERS Favorite Music Dealer MANDOLINS BANJOS UKULELES Write for FREE full-color catalog •Address: Dept. 0Y5 Copyright 1964. The Harriony Co. Chicago 60632, U.S.A. introduces amajor current in Meateeee titiVe as COLTRANE presents SHEPP Highlighting a release of 12 distinguished new albums, is the brilliant debut A-68 J. J. JOHNSON - PROOF POSITIVE recording of ARCHIE SHEPP, who was discovered and introduced to us by A-69 YUSEF LATEEF LIVE AT PEP'S JOHN COLTRANE. We think you will agree that the young saxophonist's lucid A-70 MILT JACKSON - JAll 'N' SAMBA style and intuitive sense of interpretation will thrust him high on the list of A-71 ARCHIE SHEPP - FOUR FOR TRANE today's most influential jazz spokesmen. A-73 SHIRLEY SCOTT - EVERYBODY LOVES ALOVER A-74 JOHNNY HARTMAN - THE VOICE THAT IS As for COLTRANE himself, the 1964 Downbeat Poll's 1st place Tenor Man has A-75 OLIVER NELSON - MORE BLUES AND THE again produced a performance of unequalled distinction. ABSTRACT TRUTH Other 1st place winners represented by new Impulse albums are long-time favor- A-76 MORE OF THE GREAT LOREZ ALEXANDRIA ites J.J. -
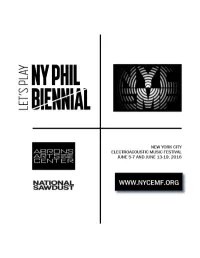
2016-Program-Book-Corrected.Pdf
A flagship project of the New York Philharmonic, the NY PHIL BIENNIAL is a wide-ranging exploration of today’s music that brings together an international roster of composers, performers, and curatorial voices for concerts presented both on the Lincoln Center campus and with partners in venues throughout the city. The second NY PHIL BIENNIAL, taking place May 23–June 11, 2016, features diverse programs — ranging from solo works and a chamber opera to large scale symphonies — by more than 100 composers, more than half of whom are American; presents some of the country’s top music schools and youth choruses; and expands to more New York City neighborhoods. A range of events and activities has been created to engender an ongoing dialogue among artists, composers, and audience members. Partners in the 2016 NY PHIL BIENNIAL include National Sawdust; 92nd Street Y; Aspen Music Festival and School; Interlochen Center for the Arts; League of Composers/ISCM; Lincoln Center for the Performing Arts; LUCERNE FESTIVAL; MetLiveArts; New York City Electroacoustic Music Festival; Whitney Museum of American Art; WQXR’s Q2 Music; and Yale School of Music. Major support for the NY PHIL BIENNIAL is provided by The Andrew W. Mellon Foundation, The Fan Fox and Leslie R. Samuels Foundation, and The Francis Goelet Fund. Additional funding is provided by the Howard Gilman Foundation and Honey M. Kurtz. NEW YORK CITY ELECTROACOUSTIC MUSIC FESTIVAL __ JUNE 5-7, 2016 JUNE 13-19, 2016 __ www.nycemf.org CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS 4 DIRECTOR’S WELCOME 5 LOCATIONS 5 FESTIVAL SCHEDULE 7 COMMITTEE & STAFF 10 PROGRAMS AND NOTES 11 INSTALLATIONS 88 PRESENTATIONS 90 COMPOSERS 92 PERFORMERS 141 ACKNOWLEDGEMENTS THE NEW YORK PHILHARMONIC ORCHESTRA THE AMPHION FOUNDATION DIRECTOR’S LOCATIONS WELCOME NATIONAL SAWDUST 80 North Sixth Street Brooklyn, NY 11249 Welcome to NYCEMF 2016! Corner of Sixth Street and Wythe Avenue. -

Mingus Dynasty Chair in the Sky Mp3 Free Download Joe Farrell - Farrell's Inferno Álbum
mingus dynasty chair in the sky mp3 free download Joe Farrell - Farrell's Inferno álbum. Joe Farrell - Farrell's Inferno 1980. To favorites 1 Download album. Listen album. Contemporary Jazz. Joe Farrell. Songs in album Joe Farrell - Farrell's Inferno 1980. Joe Farrell - Let's Go Dancing. Joe Farrell - Autumn Leaves. Joe Farrell - Dreams. Joe Farrell - Whip It Up. Joe Farrell - Invitation. Joe Farrell - Flamingo. Joe Farrell - Moon Germs. Joe Farrell with Victor Feldman, John Guerin, and Bob Magnusson. Recorded live at Pasquales, Malibu, California, on this original VINYL LP from 1980. The tunes are: Let's Go Dancing, Autumn Leaves, Dreams, Whip It Up, Invitation, Flamingo, and Moon Germs. Original Release Date: 1980. Number of Discs: 1. Joseph Carl Firrantello December 16, 1937 January 10, 1986, known as Joe Farrell, was an American jazz saxophonist and flutist. He is best known for a series of albums under his own name on the CTI record label and for playing in the initial incarnation of Chick Corea's Return to Forever. Farrell was born in Chicago Heights, Illinois. As a child, Farrell began playing the flute and clarinet. Farrel graduated from the University of Illinois at UrbanaChampaign in 1959, he moved to New York City to. Artist: Farrell, Joe Title: Farrell's Inferno Genre: Jazz Type: New - LP Label: Jazz A La Carte Catalog ID: Vol 4 Country: USA Our ID: 86019. View other items by this Artist View other items on this Label. Biography by Scott Yanow. Follow Artist. Joe Farrell's CTI albums of 1970-1976, which combined together his hard bop style with some pop and fusion elements, made him briefly popular among listeners not familiar with his earlier work. -

Cappella Sistina
Antwerpen, 22-30 augustus Inhoudstafel Woord vooraf | Philip Heylen 7 Laus Polyphoniae 2009 | Dag aan dag 10 Introductie | Bart Demuyt 23 Interview met Philippe Herreweghe 27 Essays De Spaanse furie in de pauselijke kapel 35 De Magistri Caeremoniarum, hoeders en beschermers van de rooms-katholieke liturgie 51 De Lage Landen in de pauselijke kapel 87 Muziekbronnen in het Vaticaan 103 Het Concilie van Trente 121 De Romeinse curie 137 De dagelijkse zangpraktijk in de pauselijke kapel 151 Muziek aan het hof van de Medici-pausen 171 Het groot Westers Schisma (1378-1417) 187 Rituelen bij overlijden en begrafenis van de paus 205 Virtuozen aan de pauselijke kapel 225 De architectuur van de Sixtijnse Kapel 241 Meerstemmige muziekpraktijk en repertoire van de Cappella Sistina 257 De paus en het muzikale scheppingsproces 271 De pausen in Avignon (1305-1377) 295 Van internationaal tot nationaal instituut: de Sixtijnse Kapel in de 17de eeuw 349 Decadentie en verval van de pauselijke kapel 379 Concerten Cursussen, lezing & interview 22/08/09 20.00 Collegium Vocale Gent 39 Polyfonie in de Sixtijnse Kapel, cursus polyfonie voor dummies 97 23.00 Capilla Flamenca & Psallentes 55 Cappella Sistina, themalezing 167 23/08/09 06.00 Capilla Flamenca & Psallentes 61 Philippe Herreweghe en de klassieke renaissancepolyfonie, interview 183 09.00 Capilla Flamenca & Psallentes 65 De Sixtijnse Kapel: geschiedenis, kunst en liturgie, cursus kunstgeschiedenis 221 12.00 Capilla Flamenca & Psallentes 69 Op bezoek bij de paus, muziekvakantie voor kinderen 291 15.00 Capilla