Caraffa Di Catanzaro Gharrafa E Katanxaros
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
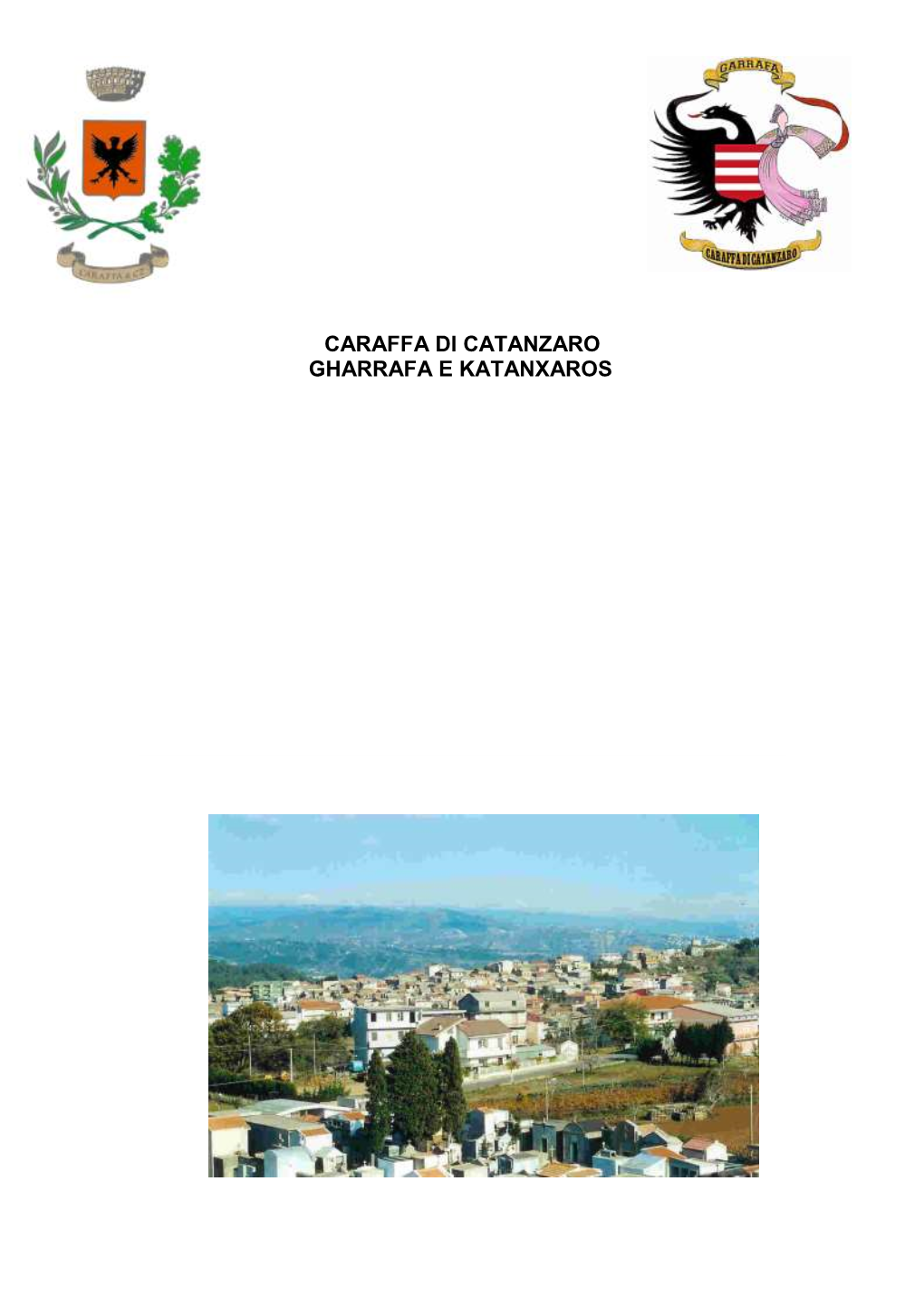
Load more
Recommended publications
-

Long Lasting Differences in Civic Capital: Evidence from a Unique Immigration Event in Italy
Long Lasting Differences in Civic Capital: Evidence from a Unique Immigration Event in Italy. E. Bracco, M. De Paola and C. Green Abstract We examine the persistence of cultural differences focusing on the Arberesh in Italy. The Arberesh are a linguistic and ethnic minority living in the south of Italy. They settled in Italy at the end of the XV century, following the invasion of the Balkans by the Ottoman Empire. Using a large dataset from the Italian parliamentary elections of the lower chamber of the Parliament, taking place from 1946 to 2008, we compare turnout in Arberesh municipalities with turnout in indigenous municipalities located in the same geographical areas. We also use two alternative different indicators of social capital like turnout at referendum and at European Parliament Elections. We find that in Arberesh municipalities turnout and compliance rates are higher compared to indigenous municipalities located in the same area. 1 I. INTRODUCTION A range of evidence now exists that demonstrates the relationship between social capital and a range of important socio-economic outcomes. Using a variety of proxies, social capital has been shown to have predictive power across a range of domains, including economic growth (Helliwell and Putnam, 1995; Knack and Keefer, 1997; Zak and Knack, 2001), trade (Guiso et al., 2004), well- functioning institutions (Knack, 2002), low corruption and crime (Uslaner, 2002; Buonanno et al., 2009) and well functioning financial markets (Guiso et al., 2004a). While this literature demonstrates large and long-lived within and across country differences in values, social and cultural norms rather less is known about the origins of these differences. -

Comune Altitudine Del Centro
Altitudine del Comune centro (metri) Abano Terme 14 Abbadia Cerreto 64 Abbadia Lariana 204 Abbadia San Salvatore 822 Abbasanta 315 Abbateggio 450 Abbiategrasso 120 Abetone 1.388 Abriola 957 Acate 199 Accadia 650 Acceglio 1.200 Accettura 770 Acciano 600 Accumoli 855 Acerenza 833 Acerno 727 Acerra 28 Aci Bonaccorsi 365 Aci Castello 15 Aci Catena 170 Aci Sant'Antonio 302 Acireale 161 Acquacanina 734 Acquafondata 926 Acquaformosa 756 Acquafredda 55 Acqualagna 204 Acquanegra Cremonese 45 Acquanegra sul Chiese 31 Acquapendente 420 Acquappesa 80 Acquarica del Capo 110 Acquaro 262 Acquasanta Terme 392 Acquasparta 320 Acquaviva Collecroce 425 Acquaviva delle Fonti 300 Acquaviva d'Isernia 730 Acquaviva Picena 359 Acquaviva Platani 558 Acquedolci 15 Acqui Terme 156 Acri 720 Acuto 724 Adelfia 154 Adrano 560 Adrara San Martino 355 Adrara San Rocco 431 Adria 4 Adro 271 Affi 191 Affile 684 Afragola 43 Africo 15 Agazzano 187 Agerola 630 Aggius 514 Agira 650 Agliana 46 Agliano Terme 263 Agliè 315 Aglientu 420 Agna 3 Agnadello 94 Agnana Calabra 210 Agnone 830 Agnosine 465 Agordo 611 Agosta 382 Agra 655 Agrate Brianza 165 Agrate Conturbia 337 Agrigento 230 Agropoli 24 Agugliano 203 Agugliaro 13 Aicurzio 230 Aidomaggiore 250 Aidone 800 Aielli 1.021 Aiello Calabro 502 Aiello del Friuli 18 Aiello del Sabato 425 Aieta 524 Ailano 260 Ailoche 569 Airasca 257 Airola 270 Airole 149 Airuno 222 Aisone 834 Ala 180 Alà dei Sardi 663 Ala di Stura 1.080 Alagna 92 Alagna Valsesia 1.191 Alanno 307 Alano di Piave 308 Alassio 6 Alatri 502 Alba 172 Alba Adriatica 5 Albagiara -

Liquirizia Di Calabria”
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA PQAI IV DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORGINE PROTETTA “LIQUIRIZIA DI CALABRIA” Art1 (Denominazione del prodotto) La Denominazione di Origine Protetta “Liquirizia di Calabria” è riservata esclusivamente alla liquirizia fresca o essiccata e al suo estratto. Tale liquirizia deve provenire dalle coltivazioni e dallo spontaneo di Glychirrhiza glabra (Fam. Leguminose), nella varietà denominata in Calabria “Cordara”, e rispondente alle condizioni ed i requisiti stabiliti nel presente Disciplinare di Produzione. Art. 2 (Descrizione del prodotto) All’atto dell’immissione al consumo la “Liquirizia di Calabria” DOP si presenta nelle tipologie di seguito indicate: • Radice fresca o Colore giallo paglierino o Sapore dolce aromatico intenso e persistente o Umidità ≤ 52% o Glicirrizzina ≤ 1,40% •Radice essiccata o Colore dal giallo paglierino al giallo ocra o Sapore dolce e fruttato leggermente astringente o Umidità ≤ 12% o Glicirrizzina ≤ 5% su s.s. Estratto di radice: 1 o Colore dal marrone terra bruciata al nero o Sapore dolce-amaro, aromatico, intenso e persistente o Umidità compresa tra il 9% e il 15% o Glicirrizzina ≤ 6 % su s.s Art. 3 (Delimitazione area di produzione) La zona di produzione della “Liquirizia di Calabria” D.O.P. comprende i seguenti comuni: Provincia di Cosenza: Falconara Albanese; -

Second Report Submitted by Italy Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities
Strasbourg, 14 May 2004 ACFC/SR/II(2004)006 SECOND REPORT SUBMITTED BY ITALY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (received on 14 May 2004) MINISTRY OF THE INTERIOR DEPARTMENT FOR CIVIL LIBERTIES AND IMMIGRATION CENTRAL DIRECTORATE FOR CIVIL RIGHTS, CITIZENSHIP AND MINORITIES HISTORICAL AND NEW MINORITIES UNIT FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES II IMPLEMENTATION REPORT - Rome, February 2004 – 2 Table of contents Foreword p.4 Introduction – Part I p.6 Sections referring to the specific requests p.8 - Part II p.9 - Questionnaire - Part III p.10 Projects originating from Law No. 482/99 p.12 Monitoring p.14 Appropriately identified territorial areas p.16 List of conferences and seminars p.18 The communities of Roma, Sinti and Travellers p.20 Publications and promotional activities p.28 European Charter for Regional or Minority Languages p.30 Regional laws p.32 Initiatives in the education sector p.34 Law No. 38/2001 on the Slovenian minority p.40 Judicial procedures and minorities p.42 Database p.44 Appendix I p.49 - Appropriately identified territorial areas p.49 3 FOREWORD 4 Foreword Data and information set out in this second Report testify to the considerable effort made by Italy as regards the protection of minorities. The text is supplemented with fuller and greater details in the Appendix. The Report has been prepared by the Ministry of the Interior – Department for Civil Liberties and Immigration - Central Directorate for Civil Rights, Citizenship and Minorities – Historical and new minorities Unit When the Report was drawn up it was also considered appropriate to seek the opinion of CONFEMILI (National Federative Committee of Linguistic Minorities in Italy). -

Actes Dont La Publication Est Une Condition De Leur Applicabilité)
30 . 9 . 88 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 270/ 1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) N° 2984/88 DE LA COMMISSION du 21 septembre 1988 fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1987/1988 en Italie, en Espagne et au Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que, compte tenu des donnees reçues, il y a lieu de fixer les rendements en Italie, en Espagne et au vu le traité instituant la Communauté économique euro Portugal comme indiqué en annexe I ; péenne, considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22 grasses, septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT : n0 2210/88 (2), vu le règlement (CEE) n0 2261 /84 du Conseil , du 17 Article premier juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive , et aux organisa 1 . En Italie, en Espagne et au Portugal, pour la tions de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le campagne 1987/ 1988 , les rendements en olives et en règlement (CEE) n° 892/88 (4), et notamment son article huile ainsi que les zones de production y afférentes sont 19 , fixés à l'annexe I. 2 . La délimitation des zones de production fait l'objet considérant que, aux fins de l'octroi de l'aide à la produc de l'annexe II . -

Documento Informativo Completo
DOCUMENTO INFORMATIVO COMPLETO (In ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 153/02/CSP, allegato A, art. 3, pubblicato su G.U. dell’8.8.2002, e 237/03/CSP, su GU 285 del 9 dicembre 2003) Soggetto che ha realizzato il sondaggio Istituto Piepoli S.p.A. Committente/acquirente Domenica Cinque del 20 febbraio 2011. Tipo e oggetto del sondaggio Sondaggio di opinione – “Gli italiani chi preferiscono tra le due showgirl di Sanremo 2011, Elisabetta Canalis o Belen Rodriguez?”. Metodo di raccolta delle informazioni C.A.T.I. – interviste telefoniche con questionario strutturato. Universo di riferimento Popolazione italiana maggiorenne. Campione Casuale, rappresentativo per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri. Estensione territoriale Intero territorio italiano. Unità intervistate 503 casi. Margine di errore (livello di confidenza 95%) ± 4.3% Rispondenti Totale contatti 2023; totale interviste (da field) effettuate 503 (25% sul totale dei contatti); non rispondenti/sostituzioni effettuate 1520 (75% sul totale dei contatti). Periodo/date di rilevazione 14 Febbraio 2011. Verifica della coerenza delle risposte Controllo a priori effettuato tramite sistema C.A.T.I. Istituto Piepoli S.p.A. 20129 Milano Via Benvenuto Cellini, 2/A t. +39 02 5412 3098 f. +39 02 5455 493 00186 Roma Via di Ripetta, 39 t. +39 06 3211 0003 f. +39 06 3600 0917 www.istitutopiepoli.it [email protected] P.IVA: 03779980964 REA 1701566 TESTO INTEGRALE DELLE DOMANDE RIVOLTE E PERCENTUALI DEI “NON SA/SENZA OPINIONE”; PERCENTUALE DELLE PERSONE CHE HANNO RISPOSTO ALLE DOMANDE. -

Comuni Di Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina –Capodistretto-, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola Dell’Alto, Strongoli, Umbriatico, Verzino
DISTRETTO DI CIRO’ MARINA Comuni di Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina –CapoDistretto-, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Strongoli, Umbriatico, Verzino. CRITERI PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI AFFIDAMENTO AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DEI SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ED AI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE E PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO AI RICHIEDENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. Premesso che la Regione, in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di solidarietà, del principio di sussidiarietà e nel rispetto delle Leggi dello Stato, disciplina, ai sensi della L.R. N° 23/2003, i rapporti tra Comuni e le forme associative con i soggetti dei terzo settore ai fini dell’affidamento dei servizi agli anziani non autosufficienti e portatori di handicap grave ed ai fini della valorizzazione del loro ruolo nell’ambito della programmazione e della progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; Che è compito della Regione adottare, ai sensi dell’art. 11, 2° comma, lett. d) ed e) della L.R. N° 23/2003 e dell’art. 14 della medesima Legge, specifici indirizzi al fine di: a) Promuovere l’offerta, il miglioramento della qualità e l’innovazione dei servizi e degli interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti qualitativi; b) Favorire la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa; c) Favorire l’utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziale, che consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo settore; d) Favorire forme di co-progettazione, promosse dalle Amministrazioni Pubbliche interessate che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l’Individuazione dei progetti sperimentali ed innovativi per la risoluzione di specifiche problematiche sociali; e) Definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale. -

Elenco Comuni Montani E Zone Soggette a Vincoli Naturali O Altri Vincoli Specifici Diversi Da Quelli Montani
Elenco comuni montani e zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici diversi da quelli montani Superfic Superfi Codice PRO ie cie Catast COMUNE Territorio fogli catastali V Territori Delimit ale ale (ha) ata (ha) CS A033 ACQUAFORMOSA montano 2.250,3 2.250,3 CS A041 ACQUAPPESA montano 1.089,7 1.089,7 19.868, CS A053 ACRI montano 19.868,8 8 CS A102 AIELLO CALABRO montano 3.815,8 3.815,8 CS A105 AIETA montano 4.787,7 4.787,7 CS A160 ALBIDONA montano 6.406,2 6.406,2 ALESSANDRIA DEL CS A183 montano 4.221,4 4.221,4 CARRETTO CS A234 ALTILIA svantaggiato 1.046,9 1.046,9 CS A240 ALTOMONTE svantaggiato 6.511,3 6.511,3 CS A253 AMANTEA svantaggiato 2.981,5 2.981,5 CS A263 AMENDOLARA svantaggiato 6.041,0 6.041,0 12.126, CS A340 APRIGLIANO montano 12.126,8 8 CS A762 BELMONTE CALABRO montano 2.374,5 2.374,5 CS A768 BELSITO montano 1.162,9 1.162,9 BELVEDERE CS A773 montano 3.686,8 3.686,8 MARITTIMO CS A842 BIANCHI montano 3.239,3 3.239,3 CS A887 BISIGNANO svantaggiato 8.543,4 8.543,4 CS A912 BOCCHIGLIERO montano 9.780,3 9.780,3 CS A973 BONIFATI montano 3.374,6 3.374,6 CS B270 BUONVICINO montano 3.033,8 3.033,8 CS B424 CALOPEZZATI svantaggiato 2.232,1 2.232,1 CS B426 CALOVETO svantaggiato 2.472,4 2.472,4 10.356, CS B500 CAMPANA montano 10.356,7 7 parzialmente CS B607 CANNA 2.018,6 2.008,5 da 1 a 24 montano CS B774 CARIATI svantaggiato 2.856,6 2.856,6 CS B802 CAROLEI montano 1.526,9 1.526,9 1 CS B813 CARPANZANO montano 1.416,2 1.416,2 CS B983 CASOLE BRUZIO svantaggiato 390,9 390,9 CS C002 CASSANO ALLO IONIO 15.735,1 0,0 CASTIGLIONE CS C301 -

Gestützt Auf Die Verordnung Nr. 136/66/EWG Des Ra Geändert Durch Die Vero
19 . 8 . 80 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 218/5 VERORDNUNG ( EWG) Nr. 2192/80 DER KOMMISSION vom 13 . August 1980 zur Festsetzung der Erträge an Oliven und Olivenöl für das Wirtschaftsjahr 1979/80 DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen GEMEINSCHAFTEN — entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus schusses für Fette — gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä ischen Wirtschaftsgemeinschaft, gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Ra HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN : tes vom 22. September 1966 über die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für Fette ('), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1917/ Artikel 1 80 (2 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 5, ( 1 ) Für das Wirtschaftsjahr 1979/80 werden die Er in Erwägung nachstehender Gründe : träge an Oliven und Olivenöl sowie die entsprechen Zum Zwecke der Gewährung der Erzeugungsbeihilfe den Erzeugungsgebiete im Anhang I festgesetzt . an Olivenbauern, die keiner Erzeugerorganisation an gehören , bestimmt Artikel 1 1 der Verordnung (EWG) (2) Die Abgrenzung der Erzeugungsgebiete ist dem Nr. 2753/78 des Rates ( 3 ), geändert durch die Verord Anhang II zu entnehmen . nung (EWG) Nr . 2378/79 (4), daß die Erträge an Oli ven und Olivenöl nach gleichartigen Erzeugungsgebie ten auf der Grundlage der von den Erzeugermitglied Artikel 2 staaten übermittelten Angaben festgesetzt werden . Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Ver Aufgrund der erhaltenen Angaben sind diese Erträge öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Ge wie im Anhang angegeben festzusetzen . meinschaften in Kraft. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat . Brüssel, den 13 . August 1980 Für die Kommission Finn GUNDELACH Vizepräsident (') ABl . -

Documento Completo Relativo Al Sondaggio (In Ottemperanza All’Art
Documento completo relativo al sondaggio (in ottemperanza all’art. 5 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 256/10/CSP, pubblicata su GU n. 301 del 27/12/2010) 1. TITOLO DEL SONDAGGIO CHE FINE HA FATTO IL NOSTRO CETO MEDIO 2. SOGGETTO CHE HA REALIZZATO IL SONDAGGIO Demos & Pi e Demetra 3. SOGGETTO COMMITTENTE COOP 4. SOGGETTO ACQUIRENTE COOP 5. DATA O PERIODO IN CUI È STATO REALIZZATO IL SONDAGGIO Dal 26/04/2016 al 28/04/2016 6. MEZZO/MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA SUL/SUI QUALE/QUALI È PUBBLICATO O DIFFUSO IL SONDAGGIO (pubblicato sul quotidiano/periodico cartaceo e/o elettronico, diffuso sull’emittente radiofonica, televisiva o sul sito web) Pubblicato sul quotidiano cartaceo la Repubblica e diffuso sul sito web www.demos.it 7. DATA DI PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE 30.05.2016 8. TEMI/FENOMENI OGGETTO DEL SONDAGGIO (economia, società, attualità, costume, marketing, salute, etica, ambiente etc.) Opinioni e stile di vita degli italiani 9. POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO Pololazione residente in italia di età dai 15 anni in sù in possesso di telefonia fissa o mobile. 10. ESTENSIONE TERRITORIALE DEL SONDAGGIO Italia (Opzione A) Comuni di rilevazione Abano Terme Ar cugnano Bergolo Abbadia San Salvatore Ardore Bertiolo Acciano Arenzano Beverino Acerno Arezzo Biancavilla Acerra Argelato Bientina Acireale Ari Binasco Acquasparta Ariccia Binetto Acqui Terme Arluno Bitritto Adrara San Martino Armungia Bobbio Adria -

Global Map of Irrigation Areas ITALY
Global Map of Irrigation Areas ITALY Province Area equipped for irrigation (ha) total with groundwater with surface water ABRUZZO 59 358 8 077 51 281 BASILICATA 80 640 17 529 63 111 CALABRIA 117 247 64 148 53 099 CAMPANIA 125 305 72 499 52 806 EMILIA-ROMAGNA 565 573 159 981 405 592 FRIULI-VENEZIA GIULIA 91 876 30 886 60 991 LAZIO 150 088 92 602 57 486 LIGURIA 11 391 2 707 8 684 LOMBARDIA 704 517 105 037 599 480 MARCHE 49 559 23 967 25 591 MOLISE 20 881 687 20 194 PIEMONTE 449 047 101 878 347 169 PUGLIA 389 617 308 116 81 501 SARDEGNA 165 707 49 937 115 770 SICILIA 209 035 101 725 107 310 TOSCANA 111 603 41 133 70 469 TRENTINO-ALTO ADIGE 61 774 15 610 46 164 UMBRIA 66 927 17 825 49 103 VALLE D'AOSTA 26 212 506 25 707 VENETO 435 845 70 931 364 914 Italy total 3 892 202 1 285 783 2 606 419 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/irrigationmap/ita/index.stm Created: March 2013 Global Map of Irrigation Areas ITALY Area equipped for irrigation Area actually irrigated District Province (ha) (ha) CHIETI ABRUZZO 11 167 5 142 L'AQUILA ABRUZZO 21 693 12 330 PESCARA ABRUZZO 12 232 5 225 TERAMO ABRUZZO 14 267 7 299 MATERA BASILICATA 52 579 32 990 POTENZA BASILICATA 28 061 9 335 CATANZARO CALABRIA 18 435 10 849 COSENZA CALABRIA 49 814 27 306 CROTONE CALABRIA 22 206 10 370 REGGIO CALABRIA CALABRIA 21 300 15 083 VIBO VALENTIA CALABRIA 5 492 3 374 AVELLINO CAMPANIA 6 671 3 480 BENEVENTO CAMPANIA 10 625 6 115 CASERTA CAMPANIA 48 714 33 352 NAPOLI CAMPANIA 16 078 13 821 SALERNO CAMPANIA 43 217 29 647 BOLOGNA EMILIA-ROMAGNA 76 680 23 610 FERRARA EMILIA-ROMAGNA -

Igp Olio Di Calabria" Al 07/06/2019 Legenda: P= Produttore Olivicolo; F= Frantoiano; C= Confezionatore; I= Intermediario
ELENCO OPERATORI ATTIVI "IGP OLIO DI CALABRIA" AL 07/06/2019 LEGENDA: P= PRODUTTORE OLIVICOLO; F= FRANTOIANO; C= CONFEZIONATORE; I= INTERMEDIARIO CAP_DO Provinci Ragione Sociale CUAA Attività Svolta Indirizzo Azienda M Comune a BOVA PAOLO BVOPLA69E18A255X P-F-C C.DA ARGADI 88050 AMARONI CZ GABRO S.R.L. 02506020789 C C.DA SISTO - FRAZ. LAUROPOLI 87011 CASSANO ALL'IONIO CS SOC. AGR. SEMPLICE GABRO DI BROGNA GIOVANNA & C. 02726800788 P C.DA SISTO - FRAZ. LAUROPOLI 87011 CASSANO ALL'IONIO CS LA FATTORIA BIOLOGICA DI BROGNA MARIO V. BRGMVN58M15C002Y P VIA GORIZIA, 31 87011 CASSANO ALL'IONIO CS GATTO IDA GTTDIA48L62C002G P VIA GORIZIA, 31 87011 CASSANO ALL'IONIO CS SOCIETA' AGRICOLA URSINO 03366700791 P VIA MONSIGNOR G.APA ,9 88100 CATANZARO CZ MAURO RODOLFO MRARLF72B27C352P P VIA TRAVERSA BARLAM DA SEMINARA 88100 CATANZARO CZ CANINO LUIGI CNNLGU55D29C352V P VIA DEI GELSOMINI, 11 88100 CATANZARO CZ CANINO S.R.L. 01995470794 P-F-C VIA DEI GELSOMINI, 88 - LOC. SIANO 88100 CATANZARO CZ CANINO RAFFAELE CNNRFL57L29C352P P VIA DEI GELSOMINI 90 88100 CATANZARO CZ GENTILE FORTUNATO GNTFTN65T30C352B P C.DA MICCIULLA 88069 SQUILLACE CZ AZIENDA AGRICOLA CARVELLI FRANCESCO CRVFNC94B05C352M P VIA TOMMASO CAMPANELLA,39 88837 PETILIA POLICASTRO KR MAZZEI FRANCESCO MZZFNC56P05C352R P VIA VERRAZZANO, 7 88100 CATANZARO CZ CARVELLI ROSARIO CRVRSR66A07G508Z P LOC.PANTANO 88837 PETILIA POLICASTRO KR AZIENDA AGRICOLA CANINO F.LLI RAFFAELE E ELIO S.S. 01612050797 P VIA SANTA DOMENICA - CONTRADA MELE, 2 88100 CATANZARO CZ STRONGOLI PASQUALE STRPQL47E29I929P P C.DA PIETRA DEL LUPO 88069 SQUILLACE CZ FATTORIE GRECO S.R.L. 02210320780 F-C VIA MAGENTA, 33 87062 CARIATI CS AZ.AGR.MICHELE E BEATRICE SALAZAR TENUTA GUGLIELMINA 00109220798 P C.DA GUGLIELMINA 88050 SOVERIA SIMERI CZ VENTURA VITTORIO VNTVTR59L06H501U P C.DA FANGIANO ,17 88047 NOCERA TERINESE CZ ORG.NE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI A.O.C.