Philedonius, 1657, Spinoza, Van Den Enden E I Classici Latini
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
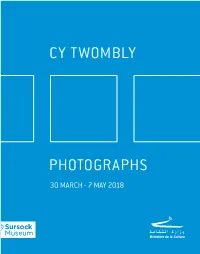
Ph0t0graphs Cy Tw0mbly
CY TWOMBLY PHOTOGRAPHS 30 MARCH - 7 MAY 2018 The Sursock Museum is proud to present, for the first time in Lebanon, an exhibition of photographs by Cy Twombly. The exhibition comprises of thirty photographs of subjects including intimate spaces, landscapes, and natural subjects, taken between 1985 and 2008. From his days as a student at Black Mountain College during the early 1950s until his death in 2011 at the age of 83, Twombly captured his daily life in photographs. He recorded the verdant landscapes of Virginia and the coasts of Italy; close-up details of ancient buildings and sculptures; studio interiors; and still lifes of objects and flowers. Beginning in the early 1990s, Twombly used specialized copiers to enlarge his Polaroid images on matte paper, resulting in subtle distortions that approximate the timeless qualities of his paintings and sculptures with their historical and literary allusions. In association with Fondazione Nicola Del Roscio In partnership with The Ministry of Culture Lenders of artworks Fondazione Nicola Del Roscio and Gagosian Gallery Lighting Joe Nacouzi Booklet design Mind the gap Printing Byblos Printing Preferred wine partner Château Marsyas 2 AURA DI LIMONI (AURA OF LEMONS) Mary Jacobus Aura, n.: 1 A gentle breeze, a zephyr 2 A subtle emanation or exhalation from any substance, e.g., the aroma of blood, the odour of flowers, etc Also, a distinctive impres- sion of character or aspect 3 A supposed subtle emanation from and enveloping living persons and things, viewed by mystics as consisting of the essence of the individual … — Oxford English Dictionary Cy Twombly’s photographs are like ema- and “By the Ionian Sea” Sculpture, Bassano nations. -

Coexistence of Mythological and Historical Elements
COEXISTENCE OF MYTHOLOGICAL AND HISTORICAL ELEMENTS AND NARRATIVES: ART AT THE COURT OF THE MEDICI DUKES 1537-1609 Contents Introduction ........................................................................................................................................................ 3 Greek and Roman examples of coexisting themes ........................................................................ 6 1. Cosimo’s Triumphal Propaganda ..................................................................................................... 7 Franco’s Battle of Montemurlo and the Rape of Ganymede ........................................................ 8 Horatius Cocles Defending the Pons Subicius ................................................................................. 10 The Sacrificial Death of Marcus Curtius ........................................................................................... 13 2. Francesco’s parallel narratives in a personal space .............................................................. 16 The Studiolo ................................................................................................................................................ 16 Marsilli’s Race of Atalanta ..................................................................................................................... 18 Traballesi’s Danae .................................................................................................................................... 21 3. Ferdinando’s mythological dream ............................................................................................... -

A Reconsideration of Some Fourth-Century British Mosaics
Originalveroffentlichung in: Britannia 11, 1980, S. 289-301 A Reconsideration of some Fourth-Century British Mosaics By REINHARD STUPPERICH oman Britain in late antiquity is an area of special interest to the archaeologist, because life was flourishing peacefully there at a time when we hear about disorder and destruc R tion afflicting the nearby provinces on the continent. Nevertheless - and this perhaps increases the interest - we know very little about cultural life, about the state of education and knowledge in the British provinces at this time. The Channel, which protected Britain from the majority of the invaders, might seem to have had its effect also on the cultural influx from Gaul. The literary sources, which very seldom mention Britain after the Severi, provide scarcely any useful information. There is virtually no one prominent in literary or even political life known to have come from Britain. Nor do we know anything about the cultural effect of the court of the British usurpers or of the presence of Constantius Chlorus and his son Constantine.1 A. A. Barrett has recently considered this problem and has rehearsed all the quotations and reminiscences which give evidence of the influence of classical literature in Britain.2 This is very helpful, but is too restrictive for the general question of the degree of education to be found in fourth-century Britain. One has to look for more than purely literary reflections, for other traces indicating knowledge ultimately derived from traditional education or the reading of classical authors. A wider formulation of the question will necessarily lead to a less precise yet nonetheless interesting answer. -

Mapping an Arm's Length
MAPPING AN ARM’S LENGTH: Body, Space and the Performativity of Drawing Roohi Shafiq Ahmed A thesis in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Fine Arts College of Fine Arts, University of New South Wales. 2013 ORIGINALITY STATEMENT ‘I hereby declare that this submission is my own work and to the best of my knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the award of any other degree or diploma at UNSW or any other educational institution, except where due acknowledgement is made in the thesis. Any contribution made to the research by others, with whom I have worked at UNSW or elsewhere, is explicitly acknowledged in the thesis. I also declare that the intellectual content of this thesis is the product of my own work, except to the extent that assistance from others in the project's design and conception or in style, presentation and linguistic expression is acknowledged.’ Signed …………………………………………….............. 28th March 2013 Date ……………………………………………................. ! DECLARATIONS Copyright Statement I hereby grant the University of New South Wales or its agents the right to archive and to make available my thesis or dissertation in whole or part in the University libraries in all forms of media, now or here after known, subject to the provisions of the Copyright Act 1968. I retain all proprietary rights, such as patent rights. I also retain the right to use in future works (such as articles or books) all or part of this thesis or dissertation. -

' Anti-Theological Foundations of Modern Constitutional Theory: The
‘ Anti-Theological Foundations of Modern Constitutional Theory: The Dutch Revolt, Locke’s Dualism and the Spinozist Basis of Modern Freedom of Expression’ Jonathan Israel, Institute for Advanced Study, Princeton One of the Enlightenment’s principal roots, historians would generally agree, should be sought in the seventeenth-century ‘general crisis’, the deeply divisive effects of confessionalization, the Wars of Religion (1567-1648), and the impact of what Cartesians interpreted as the post-1600 Galilean ‘scientific revolution’. The Netherlands, of course, shared in these experiences like the rest of Europe, no more and no less; yet there are concrete, structural reasons why the Radical Enlightenment’s beginnings and early rise should have first occurred in Holland rather than England, Italy or elsewhere: no other seventeenth century republican milieu had its very existence and rationale so profoundly challenged by an anti-republican alignment as the United Provinces during the seventeenth century. No less than three times - in 1618-19, in 1650, and in 1672 - the patrician oligarchy of ‘regents’ rejecting monarchical and ecclesiastical power and offering extended religious toleration, was dragged helplessly into major conflict with the ‘Orangist’ alliance of the Stadholder, public Church and common people. Prince Maurits, William II, and William III were right in calculating that if it came to a trial of strength, as it did each time, they would gain the upper hand and overpower the republican oligarchy because they had Church and common -

Baruch Spinoza Chronology
Baruch Spinoza Chronology 1391 Spanish Jews are forced to convert to Catholicism for the sake of "social and sectarian uniformity." 1478 Establishment of the Spanish Inquisition, whose primary task is to convict and execute those found "judaizing." 1492 All practising Jews in Spain are given the choice to convert or be expelled. 1497 All Portuguese Jews (including Spinoza’s ancestors) are forced to convert. A steady stream of Jewish refugees begins to flow from Portugal. 1587/8 Spinoza’s father Michael is born in Vidigere, Portugal, to Isaac d’Espinoza 1609 Beginning of the twelve year truce between the United Provinces and Spain, effectively establishing political independence (after nearly a 100 year struggle) for the seven northern provinces as well as their (Protestant) sectarian separation from the (Catholic) southern provinces. 1618 Defenestration of Prague and beginning of the Thirty Years War. Calvinist-inspired coup d’état in the Dutch Republic, led by the Prince of Orange, leading to the execution of Oldenbarnevelt and imprisonment of Grotius. Uriel d’Acosta (or da Costa), a Portuguese “New Christian” who had returned to Judaism in Amsterdam but became disillusioned with the Jewish community, is excommunicated for the first time in Venice for denying the immortality of the soul and questioning the Mosaic authorship of the Torah, a decree later affirmed in Amsterdam in 1623 and renewed in 1633. 1619 Batavia, Java is established as headquarters of the Dutch East India Company. 1620 Francis Bacon writes Novum organum. 1621 Hostilities resume between Spain and the United Provinces. 1622 Probable date Spinoza’s father arrives in Amsterdam, probably from Nantes. -

Spinoza's Pedagogical Experience and His Relation to F
ACCESS: CONTEMPORARY ISSUES IN EDUCATION 2018, VOL. 39, NO. 1, 6–16 https://doi.org/10.1080/00131857.2017.1384722 Honors and theater: Spinoza’s pedagogical experience and his relation to F. Van den Enden Maxime Rovere Departamento de Filosofia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil ABSTRACT KEYWORDS Franciscus Van den Enden (1602–1674) is commonly considered as the man Spinoza; Van den Enden; who taught Latin to B. de Spinoza (1632–1677). It is unknown if he actually honorary titles; theater; affects taught him something else, but we do know he used a pedagogy of his own and made the young philosopher aware of the importance of pedagogical issues. The present article helps to document their relationship from a historical ARTICLE HISTORY and theoretical perspective, by clarifying Van den Enden’s ideas on a most First published in debated subject: the use of honorary titles to distinguish pupils in the Educational Philosophy and Theory, 2018, Vol. 50, No. 9, classroom. In particular, it shows how the rejection by Van den Enden of titles 809–818 commonly used in Jesuits schools finds echoes in Spinoza’s philosophy. At the same time, the article argues that through their common participation in theatrical plays, Van den Enden and Spinoza shared a pedagogical experience that helped to overcome the problems linked to the introduction of a hierarchy, not theoretically, but in practice. Introduction Spinoza’s proximity to Franciscus Van den Enden’s private school, which he attended first as a student and then as a teacher, put him in direct contact with the educational problems of his time. -

Bibliography
BIBLIOGRAPHY Abbott, Edwin A., The Kernel and the Husk: Letters on Spiritual Christianity, by the Author of “Philochristus” and “Onesimus”, London: Macmillan, 1886. Adams, Dickenson W. (ed.), The Papers of Thomas Jefferson (Second Series): Jefferson’s Extracts from the Gospels, Ruth W. Lester (Assistant ed.), Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983. Addis, Cameron, Jefferson’s Vision for Education, 1760–1845, New York: Peter Lang, 2003. Adorno, Theodore W., and Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment, John Cumming (trans.), London: Allen Lane, 1973. Agrippa, Heinrich Cornelius, The Vanity of the Arts and Sciences, London: Printed by R. E. for R. B. and Are to Be Sold by C. Blount, 1684. Albertan-Coppola, Sylviane, ‘Apologetics’, in Catherine Porter (trans.), Alan Charles Kors (ed.), The Encyclopedia of the Enlightenment (vol. 1 of 4), Oxford: Oxford University Press, 2001, pp. 58–63. Alexander, Gerhard (ed.), Apologie oder Schutzschrift für die vernünfti- gen Verehrer Gottes/Hermann Samuel Reimarus (2 vols.), im Auftrag der Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften in Hamburg, Frankfurt: Insel, 1972. ———, Auktionskatalog der Bibliothek von Hermann Samuel Reimarus: alphabe- tisches Register, Hamburg: Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften, 1980. Alexander, H. G. (ed.), The Leibniz-Clarke Correspondence: Together with Extracts from Newton’s “Principia” and “Opticks”, Manchester: Manchester University Press, 1956. © The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2019 375 J. C. P. Birch, Jesus in an Age of Enlightenment, Christianities in the Trans-Atlantic World, https://doi.org/10.1057/978-1-137-51276-5 376 BIBLIOGRAPHY Allegro, John M., The Sacred Mushroom and the Cross: A Study of the Nature and Origins of Christianity Within the Fertility Cults of the Ancient Near East, London: Hodder and Stoughton, 1970. -
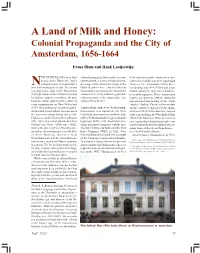
Blom and Looijestejn.Pmd
A Land of Milk and Honey: Colonial Propaganda and the City of Amsterdam, 1656-1664 Frans Blom and Henk Looijesteijn EW NETHERLAND, in its final colonial propaganda. In this article we dem- Netherland was a task entrusted to a com- decade under Dutch rule, had a onstrate that these texts serving to promote mittee of several directors of the Amsterdam Nstrong presence in Amsterdam’s the image of the American colony in the Chamber. The exact number of the direc- wide variety of public media. The colony Dutch Republic were closely linked to tors dealing with New Netherland is un- was depicted at large in the Description Amsterdam’s growing involvement in the known; usually the same names would re- (1655) by Adriaen van der Donck, who had colony in these years, and to one particular occur in the signatures. These commissaries lived there. Another eyewitness, the poet settlement project: the Amsterdam city- kept the correspondence with the colony and Jacob Steendam, published three different colony of New Amstel. prepared decision-making of the whole verse compositions on New Netherland chamber.1 Both the Chamber of Amsterdam (1659-1662) following his return to patria. Amsterdam and New Netherland. and the committee charged with the admin- Amsterdam-based authors also discussed Amsterdam was important for New istration of New Netherland were housed the American colony during this period. Netherland, for its involvement with the trade in the same building, the West-Indisch Huis Franciscus van den Enden, the headmaster of New Netherland had been great from the (West India House) on Haarlemmerstraat, of the city’s Latin School, published his Kort beginning. -

Uva-DARE (Digital Academic Repository)
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Ordinary People in the New World: The City of Amsterdam, Colonial Policy, and Initiatives from Below, 1656-1664 Blom, F.; Looijesteijn, H. DOI 10.1057/9781137380524.0016 Publication date 2013 Document Version Author accepted manuscript Published in In praise of ordinary people: early modern Britain and the Dutch Republic Link to publication Citation for published version (APA): Blom, F., & Looijesteijn, H. (2013). Ordinary People in the New World: The City of Amsterdam, Colonial Policy, and Initiatives from Below, 1656-1664. In M. C. Jacob, & C. Secretan (Eds.), In praise of ordinary people: early modern Britain and the Dutch Republic (pp. 203-236). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137380524.0016 General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:02 Oct 2021 In Praise of Ordinary People October 28, 2013 15:14 MAC-US/DUTCH Page-i 9781137380517_01_prex October 28, 2013 15:14 MAC-US/DUTCH Page-ii 9781137380517_01_prex In Praise of Ordinary People Early Modern Britain and the Dutch Republic Edited by Margaret C. -
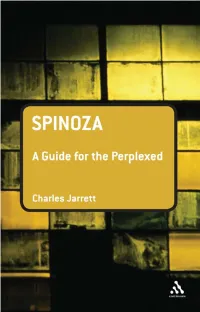
Spinoza: a Guide for the Perplexed
SPINOZA: A GUIDE FOR THE PERPLEXED Continuum Guides for the Perplexed Adorno: A Guide for the Perplexed – Alex Thomson Deleuze: A Guide for the Perplexed – Claire Colebrook Existentialism: A Guide for the Perplexed – Stephen Earnshaw Gadamer: A Guide for the Perplexed – Chris Lawn Hobbes: A Guide for the Perplexed – Stephen J. Finn Husserl: A Guide for the Perplexed – Matheson Russell Kierkegaard: A Guide for the Perplexed – Clare Carlisle Levinas: A Guide for the Perplexed – B. C. Hutchens Merleau-Ponty: A Guide for the Perplexed – Eric Matthews Quine: A Guide for the Perplexed – Gary Kemp Rousseau: A Guide for the Perplexed – Matthew Simpson Sartre: A Guide for the Perplexed – Gary Cox Wittgenstein: A Guide for the Perplexed – Mark Addis SPINOZA: A GUIDE FOR THE PERPLEXED CHARLES E. JARRETT Continuum International Publishing Group The Tower Building 80 Maiden Lane 11 York Road Suite 704 London SE1 7NX New York, NY 10038 www.continuumbooks.com © Charles Jarrett 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or trans- mitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including pho- tocopying, recording, or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publishers. Thanks are due to the following publishers for permission to reprint portions of Samuel Shirley’s translations of Spinoza’s works. Spinoza. Complete Works; translated by Samuel Shirley and others; edited, with introduction and notes, by Michael L. Morgan. Copyright © 2002 by Hackett Publishing Company, Inc. Reprinted by permission of Hackett Publishing Company, Inc. All rights reserved. Baruch Spinoza. Tractatus Theologico-Politicus, translated by Samuel Shirley. -

Iconografia E Dinâmica De Movimento Em Imagens Romanas Que Figuram a Velificatio Jaqueline Souza Veloso1
Figura: Studies on the Classical Tradition Iconografia e dinâmica de movimento em imagens romanas que figuram a velificatio Jaqueline Souza Veloso1 Submetido em: 13/04/2021 Aceito em: 13/05/2021 Publicado em: 15/07/2021 Resumo O tema do presente artigo é o estudo da velificatio e suas aplicações durante fins do século I a.C. ao III d.C. O que se pretende realizar é uma análise da plasticidade da velificatio, levando em consideração a dimensão de movimento ou suspensão dele nas imagens representadas, seus usos, preâmbulos, conexões e as reificações aos quais esse símbolo esteve submetido. A delimitação temporal e a localização das imagens foram escolhidas de maneira a inserir a pesquisa no contexto de um sistema visual próprio da Roma imperial (ZANKER, 2010, p. 67). As imagens escolhidas procuram atender a suportes diferentes, são alegorias de divindades femininas e um retrato. Serão discutidas a imagem das velificantes do Ara Pacis, o afresco da Mênade de Casa de Naviglio, de Pompeia, um altar funerário com cena do Rapto de Proserpina e o Sarcófago com retrato de casal. Os dois principais questionamentos a serem discutidos são: Quais dispositivos pelos quais a velificatio poderia se servir para representar o movimento? E quais as diferenças e aproximações possíveis de significado que essa iconografia desenvolveu na dinâmica das imagens analisadas? Palavras-chave: Velificatio; Movimento; Roma. 1 Doutoranda do programa de História da UFMG ([email protected]), bolsista CAPES. Orientador: Rafael Scopacasa. Co-orientadora: Maria Berbara. Figura: Stud. Class. Tradit. Campinas, SP v. 9 n. 1 pp. 333-888 Jan.-Jun.