La Regia Abbazia Di an Costanzo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Juniores Regionale� �
ARCHIVIO STAGIONE 2013/2014 JUNIORES REGIONALE Data di inizio: 22-09-2012 Data di fine: 13-04-2012 Gironi GIRONE G GIRONE G Data di inizio: 21-09-2013 Data di fine: 22-03-2014 calendario giornata 1 21-09-2013 CHERASCHESE REVELLO 1-0 via Giolitti, Cherasco 21-09-2013 CORNELIANO BOVES MDG 1-4 località Giardino, Corneliano d'Alba 21-09-2013 MORETTA PEDONA 0-2 via Fornace, Moretta 21-09-2013 OLMO BUSCA 1-1 via della Battaglia, Mad. dell'Olmo 21-09-2013 SOMMARIVA PERNO FOSSANO 2-9 località Galano, Sommariva Perno 21-09-2013 VILLAFRANCA SALUZZO 1-1 via Aldo Moro, Villafranca Piemonte giornata 2 28-09-2013 BOVES MDG VILLAFRANCA 1-0 via Peveragno, Boves 28-09-2013 BUSCA CORNELIANO 3-2 via Monte Ollero, Busca 28-09-2013 FOSSANO MORETTA 4-0 corso Trento, Fossano 28-09-2013 PEDONA OLMO 0-3 partita sospesa, via Vittorio risultato deciso dal Veneto, giudice sportivo Borgo San (c.u. regionale n. Dalmazzo 25 del 17/10/2013) 28-09-2013 REVELLO SOMMARIVA PERNO 2-0 piazze Peirone, Revello 28-09-2013 SALUZZO CHERASCHESE 0-1 via della Croce, Saluzzo giornata 3 05-10-2013 CHERASCHESE BOVES MDG 4-2 via Giolitti, Cherasco 05-10-2013 CORNELIANO PEDONA 1-2 località Giardino, Corneliano d'Alba 05-10-2013 MORETTA SOMMARIVA PERNO 1-1 via Fornace, Moretta 05-10-2013 OLMO FOSSANO 2-1 via della Battaglia, Mad. dell'Olmo 05-10-2013 REVELLO SALUZZO 0-3 piazze Peirone, Revello 05-10-2013 VILLAFRANCA BUSCA 0-1 via Aldo Moro, Villafranca Piemonte giornata 4 12-10-2013 BOVES MDG SALUZZO 0-2 via Peveragno, Boves 12-10-2013 BUSCA CHERASCHESE 3-0 via Monte Ollero, Busca 12-10-2013 FOSSANO CORNELIANO 4-0 corso Trento, Fossano 12-10-2013 MORETTA REVELLO 2-3 via Fornace, Moretta 12-10-2013 PEDONA VILLAFRANCA 5-3 via Vittorio Veneto, Borgo San Dalmazzo 12-10-2013 SOMMARIVA PERNO OLMO 2-4 località Galano, Sommariva Perno giornata 5 19-10-2013 CHERASCHESE PEDONA 1-1 via Giolitti, Cherasco 19-10-2013 CORNELIANO SOMMARIVA PERNO 1-2 località Giardino, Corneliano d'Alba 19-10-2013 OLMO MORETTA 3-2 via della Battaglia, Mad. -

Scarica L'appendice Con L'elenco Completo Degli Edifici Dismessi
Appendice II del Quaderno 37 della Collana della Fondazione CRC Rigenerare spazi dismessi Nuove prospettive per la comunità Elenco completo dei beni dismessi rilevati in provincia di Cuneo attraverso le fonti e grazie alle segnalazioni degli enti territoriali (aggiornato al 18 giugno 2018) Nota metodologica A cura di Fondazione Fitzcarraldo Si rende disponibile l’elenco dei 449 beni dismessi in provincia di Cu- neo rilevati attraverso le fonti disponibili e grazie alle segnalazioni dirette degli enti territoriali nell’ambito della mappatura realizzata per il Quaderno 37 Rigenerare spazi dismessi. Nuove prospettive per la comunità, pro- mosso dalla Fondazione CRC e realizzato da Fondazione Fitzcarraldo. Di seguito si specificano alcune considerazioni relative alla metodolo- gia adottata e alcune indicazioni utili alla consultazione dell’elenco. La scelta effettuata per disporre di una prima ricognizione di parte del patrimonio dismesso cuneese si è concretata, da un lato, in una ricerca e una lettura dei dati estrapolati dalle poche fonti disponibili e, dall’altro, nella raccolta di segnalazioni dirette da parte degli enti territoriali. Una mappatura efficace e puntuale in grado di fotografare dal punto di vista quantitativo e localizzativo tutte le opportunità e gli edifici in stato di abbandono e di sottoutilizzo in un territorio così vasto come la provincia di Cuneo non può prescindere da sopralluoghi mirati in tutti i 250 comuni del territorio. Per questo è più realistico definire questa parte della ricerca come una ricognizione “a maglie larghe” di un immenso patrimonio di- smesso che comprende una moltitudine di proprietari differenti. Le diverse fonti oggetto della presente ricognizione individuano beni le cui condizioni effettive non sono direttamente verificate, non essendo stati effettuati i sopralluoghi. -

1912 College of the Sacred Heart Catalogue
Seitnt r, (HoloraJw Catalogue 1911-1912 The Miles 4 Dryer Printing Co. COLLEGE OF THE SACRED HEART BOARD OF TRUSTEES Very Rev. Joseph M. Marra, S. J., President. Rev. John J. Brown, S. J. Rev Dominic Pantanella, S. J. Rev. Augustine M. Bertram, S. J. Rev. Eldridge S. J. Hyde, S. J. THE CORPORATE TITLE IS: "COLLEGE OF THE SACRED HEART, DENVER, COLO." COLLEGE OF THE SACRED HEART FACULTY AND OFFICERS Rev. John J. Brown, S. J. President. Rev. C. Marion Garde, S. J. Vice-President, Prefect of Studies and Discipline. Rev. John X. Peters, S. J. Chaplain. Rev. Dominic Pantanella, S. J. Treasurer. COLLEGIATE DEPARTMENT. Rev. Joseph M. Mi not, S. J. Evidences of Religion. Rev. John X. Peters, S. J. Logic, Metaphysics, Ethics. Rev. Armand W. Forstall, S. J. Physics and Chemistry. Rev. Eugene J. Montell, S. J. English in Senior, Classics and English in Junior Year. Evidences of Religion in Freshman Year. Mr. Francis D. Stephenson, S. J. Sophomore Year. Rev. Charles A. McDonnell, S. J. Freshman Year. COLLEGE OF THE SACRED HEART ACADEMIC (HIGH SCHOOL) DEPARTMENT. Rev. John B. Hugh, S. J. Mr. Edward S. J.ohnson, S. J. Professors of First Academic. Mr. John M. Floyd, S. J. Professor of Second Academic. Rev. Joseph M. Minot, S. J. Professor of Special Academic. Rev. Sebastian Mayer, S. J. Professor of Third Academic. Mr. Aloysius L. Scheid, A. B. Professor of Fourth Academic. MATHEMATICS. Mr. Francis D. Stephenson, S. J. College Algebra and Analytical Geometry. Rev. C. Marion Garde, S. J. Trigonometry and College Algebra. Rev. John B. -

Case Study Italy
TOWN Small and medium sized towns in their functional territorial context Applied Research 2013/1/23 Case Study Report | Italy Version 15/February/2014 ESPON 2013 1 This report presents the interim results of an Applied Research Project conducted within the framework of the ESPON 2013 Programme, partly financed by the European Regional Development Fund. The partnership behind the ESPON Programme consists of the EU Commission and the Member States of the EU27, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. Each partner is represented in the ESPON Monitoring Committee. This report does not necessarily reflect the opinion of the members of the Monitoring Committee. Information on the ESPON Programme and projects can be found on www.espon.eu The web site provides the possibility to download and examine the most recent documents produced by finalised and ongoing ESPON projects. This basic report exists only in an electronic version. © ESPON & University of Leuven, 2013. Printing, reproduction or quotation is authorised provided the source is acknowledged and a copy is forwarded to the ESPON Coordination Unit in Luxembourg. ESPON 2013 2 List of authors Cristiana Cabodi (Officina Territorio) Alberta de Luca (Officina Territorio) Alberto Di Gioia (Politecnico di Torino) Alessia Toldo (Officina Territorio) ESPON 2013 3 Table of contents 1. National context (p. 9) 1.1 Semantic point of view (p. 9) 1.2 Institutional and administrative point of view (p. 9) 1.3 statistical point of view (p. 9) 1.4 Small and Medium Sized Towns (SMSTs) in National/Regional settlement system: literary overview (p 12.) 1.4.1 The Italian urban system from the 1960s to the 1970s: the polarized structure (p. -

1909 College of the Sacred Heart Catalogue
OkiU?0e of Q\\t g>arreft If ?art Btnxttt, (Mnraim i Catalogue 1900-1900 «{>^i^(<{«<|»^i^i^M2>»Je^Hfi^>£>t|>^t^r^»ii|»«{t<2t*J>»2»«2>*2'if>*2><{'** < : COLLEGE OF THE SACRED HEART BOARD OF TRUSTEES- Very Rev. Joseph M. Marra, S. J., President. Rev. John J. Brown, S. J. Rev. Dominic Pantanella, S. J. Rev. William Lonergan, S. J. Rev. Francis X. Hoefkens, S. J. The Corporate Title is "College of the Sacred Heart." COLLEGE OF THE SACRED HEART FACULTY AND OFFICERS. Rev. John J. Brown, S. J., President. Rev. William Lonergan, S. J., Vice-President, Prefect of Studies and Discipline. Rev. John J. Driscoll, S. J., Chaplain. Rev. Dominic Pantanella, S. J., Treasurer. COLLEGIATE DEPARTMENT. Rev. Leo M. Krenz, S. J., Logic, Metaphysics and Ethics, Evidences of Religion. Rev. Armand W. Forstall, S. J., Natural Philosophy and Chemistry. Rev. Eugene J. Montell, S. J., Classics and English in Junior Year. Rev. Joseph M. Minot, S. J., Classics and English in Sophomore Year. Rev. Aloysius Laur, S. J., Classics and English in Freshman Year. COLLEGE OF THE SACRED HEART ACADEMIC (HIGH SCHOOL) DEPARTMENT. Rev. Charles A. McDonnell, S. J., Professor of First Academic. William J. Fitzgerald, S. J., Professor of Second Academic. Rev. John B. Hugh, S. J., Professor of Special Academic. Francis D. Stephenson, S. J., Professor of Third Academic. Frederick Ralph, S. J., Professor of Fourth Academic. MATHEMATICS. Rev. Aloysius Laur, S. J., Analytical Geometry, Trigonometry, Solid Geometry, Rev. Charles A. McDonnell, S. J., Plane Geometry. Rev. John B. Hugh, S. J., William J. -

Racconti E Percorsi Tra Collina E Montagna Provincia Di Cuneo / Ente Proponente Il Progetto Comune Di Vernante, Comune Di Verzuolo, Comune Di Cherasco
PROVINCIA DI CUNEO Ufficio Servizio Civile 0171.445872 [email protected] www.provincia.cuneo.it/serviziocivile SCHEDA SINTETICA PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE TITOLO DEL PROGETTO RACCONTI E PERCORSI TRA COLLINA E MONTAGNA PROVINCIA DI CUNEO / ENTE PROPONENTE IL PROGETTO COMUNE DI VERNANTE, COMUNE DI VERZUOLO, COMUNE DI CHERASCO Patrimonio artistico e culturale SETTORE ED AREA DI INTERVENTO Valorizzazione storie e culture locali Comune di Vernante - Ex Segheria - Settore Cultura Strada Statale 20 n. 12 – Vernante Dalmasso Blangero Lorella 0171-920104 int.1 [email protected] Comune di Verzuolo - Settore Cultura eTurismo - Area RIFERIMENTI amministrativa-produttiva P.zza Martiri della Libertà 1 – Verzuolo Quaranta Carla 338-1909137 [email protected] Comune di Cherasco - Ufficio Turistico Via Vittorio Emanuele 79 – Cherasco Innocenti Licia 0172-427052 [email protected] Comuni di Vernante e Verzuolo: diploma scuola superiore + patente B REQUISITI D’ACCESSO Comune di Cherasco: - Diploma di scuola superiore 4 VOLONTARI: n.1 a Vernante NUMERO POSTI n.2 a Verzuolo n.1 a Cherasco - 30 ore settimanali su 5 gg. alla settimana Per le sedi di Vernante e Verzuolo : - Disponibilità ad attività in movimento, flessibilità oraria, eventuale ORARIO DI SERVIZIO impegno in alcuni giorni festivi. Disponibilità alla guida dell’automezzo dell’Ente Per la sede di Cherasco : -disponibilità a prestare servizio anche in orari serali e in giorni festivi SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI) Il progetto persegue lo scopo di valorizzare il patrimonio storico e culturale dei territori coinvolti, riscoprire le tradizioni locali attraverso i documenti e la memoria degli abitanti e divulgare il patrimonio immateriale raccolto attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e innovativi. -
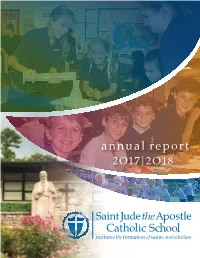
Learning | Praying | Serving | Growing
OUR VISION Saint Jude the Apostle Catholic School strives to develop the Catholic faith, demonstrate Christian living, commit to student learning, and foster good stewardship of God’s world. learning | praying | serving | growing 2 Dear Saint Jude Family and Friends, As I reflect on the end of another school year, it brings me great joy to think of our many accomplishments. From welcoming new families in August, celebrating the lives of the saints in November, sending 11,800 meals to children in Swaziland during Catholic Schools Week, walking with Christ during His final hours as our 8th Graders lead the Living Stations in the spring, celebrating First Holy Eucharist with our 2nd Graders, and graduating 47 wonderful young men and women in May, we are grateful for the learning, loving, and laughter of each day. I am delighted to share our 2017-2018 Annual Report with you. We began our school year with 100% participation in the Annual Fund from our Faculty and Staff and ended the year with 100% parent participation for the third consecutive year! Your generosity and continued financial support make much possible for so many. Thank you! Our wonderful volunteers continue to bring to reality the plans and ideas for all to enjoy. Thank you for giving so selflessly of your time and talents. Your dedication, support, and commitment are the true embodiment of Christ’s spirit alive in our midst. The PTA Shine Auction has funded the update of gratitude the entire campus to LED lighting and replaced the aging air conditioner in can transform the gym. -

Medie Radon Provincia Cuneo 2017
Provincia Comune media radon al piano terra (Bq/m 3) Cuneo Acceglio 133 Cuneo Aisone 149 Cuneo Alba 99 Cuneo Albaretto della torre 79 Cuneo Alto 498 Cuneo Argentera 216 Cuneo Arguello 79 Cuneo Bagnasco 112 Cuneo Bagnolo Piemonte 135 Cuneo Baldissero d'Alba 105 Cuneo Barbaresco 89 Cuneo Barge 145 Cuneo Barolo 85 Cuneo Bastia mondovi' 108 Cuneo Battifollo 96 Cuneo Beinette 160 Cuneo Bellino 80 Cuneo Belvedere Langhe 79 Cuneo Bene Vagienna 148 Cuneo Benevello 79 Cuneo Bergolo 81 Cuneo Bernezzo 102 Cuneo Bonvicino 79 Cuneo Borgo San Dalmazzo 133 Cuneo Borgomale 79 Cuneo Bosia 87 Cuneo Bossolasco 79 Cuneo Boves 140 Cuneo Bra 146 Cuneo Briaglia 82 Cuneo Briga Alta 125 Cuneo Brondello 120 Cuneo Brossasco 118 Cuneo Busca 148 Cuneo Camerana 83 Cuneo Camo 80 Cuneo Canale 107 Cuneo Canosio 130 Cuneo Caprauna 602 Cuneo Caraglio 63 Cuneo Caramagna Piemonte 157 Cuneo Carde' 155 Cuneo Carru' 147 Cuneo Cartignano 116 Cuneo Casalgrasso 154 Cuneo Castagnito 92 Cuneo Casteldelfino 90 Cuneo Castellar 143 Cuneo Castelletto Stura 154 Cuneo Castelletto Uzzone 81 Cuneo Castellinaldo 98 Cuneo Castellino Tanaro 85 Cuneo Castelmagno 96 Cuneo Castelnuovo di Ceva 99 Cuneo Castiglione Falletto 94 Cuneo Castiglione Tinella 81 Cuneo Castino 81 Cuneo Cavallerleone 161 Cuneo Cavallermaggiore 160 Cuneo Celle di Macra 73 Cuneo Centallo 159 Cuneo Ceresole d'Alba 151 Cuneo Cerretto Langhe 79 Cuneo Cervasca 142 Cuneo Cervere 151 Cuneo Ceva 105 Cuneo Cherasco 140 Cuneo Chiusa di Pesio 147 Cuneo Ciglie' 98 Cuneo Cissone 79 Cuneo Clavesana 94 Cuneo Corneliano d'Alba 104 Cuneo -

The History of Napoleon Buonaparte
THE HISTORY OF NAPOLEON BUONAPARTE JOHN GIBSON LOCKHART CHAPTER I BIRTH AND PARENTAGE OF NAPOLEON BUONAPARTE—HIS EDUCATION AT BRIENNE AND AT PARIS—HIS CHARACTER AT THIS PERIOD—HIS POLITICAL PREDILECTIONS—HE ENTERS THE ARMY AS SECOND LIEUTENANT OF ARTILLERY—HIS FIRST MILITARY SERVICE IN CORSICA IN 1793. Napoleon Buonaparte was born at Ajaccio on the 15th of August, 1769. The family had been of some distinction, during the middle ages, in Italy; whence his branch of it removed to Corsica, in the troubled times of the Guelphs and Gibellines. They were always considered as belonging to the gentry of the island. Charles, the father of Napoleon, an advocate of considerable reputation, married his mother, Letitia Ramolini, a young woman eminent for beauty and for strength of mind, during the civil war— when the Corsicans, under Paoli, were struggling to avoid the domination of the French. The advocate had espoused the popular side in that contest, and his lovely and high-spirited wife used to attend him through the toils and dangers of his mountain campaigns. Upon the termination of the war, he would have exiled himself along with Paoli; but his relations dissuaded him from this step, and he was afterwards reconciled to the conquering party, and protected and patronised by the French governor of Corsica, the Count de Marbœuff. It is said that Letitia had attended mass on the morning of the 15th of August; and, being seized suddenly on her return, gave birth to the future hero of his age, on a temporary couch covered with tapestry, representing the heroes of the Iliad. -

Mortuary File.Xlsx
Index to the Mortuary Files of Valente, Marini, Perata & Co 3448 Mission Street, San Francisco Mortuary Books are located in the Colma Historical Museum 1500 Hillside Blvd, Colma Index by The San Mateo County Genealogical Society (Lauren Perritt, Russ & Eunice Brabec, Jean Ann Carroll, Cath Trindle) This is a work in progress the records to be indexed cover the years the years 1888-1964 Some books are numbered the early ones are titled only by the years they cover. For ease of indexing we have given them a letter designation. The books included in this first installment include: Notes: Date given is death date if know, otherwise it might be burial date, date plot was purchased or date at the top of the page. In the case of removals from one cemtery to another the date is given in the notes column to avoid confusion over death dates. In the case of stillbirths and infants, the name given might be that of a parent, the records were often not clear. Remember, this is an index not an extraction, the actual record is likely to contain additional information, including who is responsible for payment, some societies the individual belonged to, names of newspapers where notices were places, and in some journals prior to 1920 obituaries might be attached. There is some duplication in the records, some of the Journal were most likely copied to the later books. We chose to include both because these were the years that might also have attached obituaries. When requesting a copy from the Colma Historical Society, be sure to copy the book volume and page number carefully. -

San Mateo County Naturalization Index 1926-1945 San Mateo County 1926-1945
San Mateo County Naturalization Index 1926-1945 San Mateo County Genealogical Society 2000 San Mateo County Naturalization Index Volume 3 1926-1945 San Mateo County Genealogical Society ©2000 Project Co-ordinator/ Editor Cath MaddenTrindle Record Entry Cath Trindle, Ken & Pam Davis, Mary Lou Grunigen, Margaret Deal, Janice Marshall © September 2000 San Mateo County Genealogical Society Library of Congress Catalog Card Number 99-071151 Order Copies from the Publisher: San Mateo County Genealogical Society PO Box 5083 San Mateo CA 94402 Table of Contents San Mateo County 1926-1945 ........................................ ii Changes in Naturalization Laws .........................................iv Overview of San Mateo County Naturalization Records ......................v. Naturalization Index .................................................. 1 Bibliography ....................................................... 247 SMCGS Archives Project i San Mateo County Naturalization Index 1926-1945 San Mateo County 1926-1945 The two decades between 1926 and 1945 were a period of great growth in San Mateo County. Between 1930 and 1940 the population increased by nearly 50% from 77400 in 1930 to 111800 in 1940. New cities formed as the population grew including the incorporation of Belmont, Menlo Park and Woodside in 1927. Increasing transportation needs were answered by the opening of Mills Field (San Francisco Airport) in 1927 and the building of the San Mateo Hayward Bridge in 1929. The Great Depression was one of the reasons for an increase in population. Whereas previously immigrants might be likely to settle in San Francisco neighborhoods, now the lack of jobs and high rents led them to relocate to the peninsula. With much of the county still unincorporated it was still possible to find a strip of land and put up an inexpensive dwelling. -

Modello Sedi Disponibili CN PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA Codice meccanografico Codice meccanografico Denominazione Comune Tipologia di posto Istituto principale Sede CNIC85600V CNEE856011 ALBA CENTRO STORICO ALBA COMUNE CNIC85600V CNEE856011 ALBA CENTRO STORICO ALBA COMUNE CNIC85600V CNEE856011 ALBA CENTRO STORICO ALBA COMUNE CNIC855003 CNEE855015ALBA ALBA QUARTIERE MORETTA ALBA COMUNE CNIC855003 CNEE855015ALBA ALBA QUARTIERE MORETTA ALBA COMUNE CNIC855003 CNEE855015ALBA ALBA QUARTIERE MORETTA ALBA COMUNE CNIC855003 CNEE855015ALBA ALBA QUARTIERE MORETTA ALBA COMUNE CNIC855003 CNEE855015ALBA ALBA QUARTIERE MORETTA ALBA COMUNE CNIC86400T CNEE86401X BRA 1 BRA COMUNE CNIC86400T CNEE86401X BRA 1 BRA COMUNE CNIC86400T CNEE86401X BRA 1 BRA COMUNE CNIC838009 CNEE83802C CAVALLERMAGGIORE CAVALLERMAGGIORE COMUNE CNIC838009 CNEE83802C CAVALLERMAGGIORE CAVALLERMAGGIORE COMUNE CNIC825007 CNEE825019 CHERASCO CHERASCO COMUNE CNIC825007 CNEE825019 CHERASCO CHERASCO COMUNE CNIC825007 CNEE825019 CHERASCO CHERASCO COMUNE CNIC825007 CNEE825019 CHERASCO CHERASCO COMUNE CNIC825007 CNEE825019 CHERASCO CHERASCO COMUNE CNIC825007 CNEE825019 CHERASCO CHERASCO COMUNE CNIC84900Q CNEE849052 DIANO D'ALBA DIANO D'ALBA COMUNE CNIC84900Q CNEE849052 DIANO D'ALBA DIANO D'ALBA COMUNE CNIC84900Q CNEE849052 DIANO D'ALBA DIANO D'ALBA COMUNE CNIC84900Q CNEE849052 DIANO D'ALBA DIANO D'ALBA COMUNE CNIC84900Q CNEE849052 DIANO D'ALBA DIANO D'ALBA COMUNE CNIC83600N CNEE83602R GARESSIO GARESSIO COMUNE CNIC82300G CNEE82303Q GOVONE GOVONE COMUNE CNIC81900X CNEE819034 LA MORRA LA MORRA COMUNE CNIC81900X CNEE819034 LA MORRA