Libro Cgil Memoria Xp6 2.A Parte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Alto Oltrepò Pavese (Regione Lombardia) PARTE PRIMA ANALISI E DESCRIZIONE
La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali AREA INTERNA appennino lombardo- O V alto oltrepo' pavese I REGIONE LOMBARDIA T A Z Z I N A G R O A E R A ' D R E I S S O D Nota introduttiva Le Aree Interne rappresentano una ampia parte del Paese. Si tratta di aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (quali istruzione, salute e mobilità) ma ricche di importanti risorse ambientali e culturali, fortemente diversificate per natura e per processi di antropizzazione. Un quarto della popolazione italiana occupa queste aree, con un’estensione territoriale che supera il sessanta per cento del totale della superficie nazionale e interessa oltre quattromila comuni. Il Piano Nazionale di Riforma (PNR) ha individuato e messo in atto una Strategia che ha come obiettivo non solo la ripresa demografica, ma anche un miglioramento qualitativo di vita promuovendo per queste aree uno sviluppo intensivo (benessere e inclusione sociale) ed estensivo (lavoro e utilizzo di risorse locali) attraverso fondi ordinari della Legge di Stabilità e Fondi comunitari. La Strategia Nazionale per le Aree Interne, che coinvolge un quarto dei comuni classificati come aree interne, ha individuato e selezionato 72 aree progetto, ricadenti in ambiti territoriali omogenei, distribuite su tutto il territorio nazionale. Per esse si è avviato un processo di crescita e coesione territoriale. Il Dossier d’area organizzativo è un documento di sintesi (analitica e documentale) su alcune condizioni strutturali dell’area e sulle scelte che i comuni hanno effettuato per rafforzare la loro capacità di gestire i servizi pubblici locali e i progetti previsti dalla Strategia. -
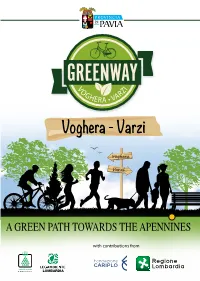
Greenway V O I G Rz Hera • Va
GREENWAY V O I G RZ HERA • VA Voghera - Varzi Voghera Varzi A GREEN PATH TOWARDS THE APENNINES with contributions from Credits Voghera - Varzi Greenway: a green path towards the Apennines • The guide to the route is a project promoted by Provincia di Pavia in partnership with Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese and Legambiente Lombardia, with contributions from the Fondazione Cariplo and Regione Lombardia. Editing, design, graphics, text, layout and printing: Bell&Tany, Voghera, bell-tany.it. Finished printing in the month of June 2021. ©Province of Pavia 2021 ©Bell&Tany 2021 All rights reserved. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited. www.provincia.pv.it www.visitpavia.com www.greenwayvogheravarzi.it This guide is printed respecting the environment on recycled paper. discovering the OLTREPÒ PAVESE 2044 0053 AT / 11 / 002 GREENWAY V O I G RZ HERA • VA Voghera - Varzi Exploring Walking Cycling Savouring discovering the OLTREPÒ PAVESE 2 The Voghera - Varzi Greenway is ready. It is a 33 kilometers long dream, begone when dreaming cost nothing. When thinking of recovering the old railway line was a romantic, good and appealing idea, yet so unlikely. Still we succeeded. With passion, persistence, and a lot of good will. If it is true, as Eleanor Roosevelt wrote, “that the future belongs to the ones who believe in the beauty of their dreams”, therefore today we are giving Oltrepò a little something to hope a different, better future. Discovering the territory, experiencing the natural beauty, sharing the pleasure of good food, letting the silence of unexpected and magical places conquer ourselves, being together with friend hoping the time will never pass. -

Piano Annuale Dell'offerta Abitativa 2021
COMUNE DI VOGHERA Provincia di Pavia PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE Comuni di Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Casei Gerola,Cecima, Codevilla, Colli Verdi, Corana, Cornale e Bastida, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano Terme, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Val di Nizza, Varzi, Voghera, Zavattarello PIANO ANNUALE DELL’OFFERTA ABITATIVA 2021 CONTESTO Il presente Piano Annuale dell’Offerta dei Servizi Abitativi Pubblici e Sociali è stato predisposto in conformità all’articolo 4 del Regolamento Regionale n. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni e sulla base dei dati forniti dai Comuni dell’Ambito e dall’ALER di Pavia-Lodi, che è stata sentita prima di sottoporre la proposta all’Assemblea dei Sindaci. L’Ambito Territoriale Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese è composto dai Comuni di Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Casei Gerola, Cecima, Codevilla, Corana, Cornale e Bastida, Colli Verdi, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano Terme, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Val di Nizza, Varzi, Voghera e Zavattarello. In data 9.05.2019 l’Assemblea dei Sindaci ha designato il Comune di Voghera quale Ente capofila dell’Ambito per la programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale. Il Presente Piano Annuale 2021 dell’offerta abitativa, come indicato dal punto 3 del Comunicato regionale n. 45 del 2 aprile 2019, contiene tutti i dati indicati come contenuti minimi ed essenziali inviati dai Comuni dell’Ambito territoriale e dall’ALER di Pavia-Lodi. -

Provincia Di Pavia
Comune di Menconico (PV) PGT 2010 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO Comune di Menconico Provincia di Pavia RAPPORTO AMBIENTALE PGT_2010 FASE I: DOCUMENTO DI SCOPING LUGLIO 2010 FASE II: VALUTAIZONE AMBIENTALE del Documento di Piano DICEMBRE 2010 VAS del Documento di Piano adottato il con DCC n. del approvato il con DCC n. del Il Sindaco Sig. Livio Bertorelli Il segretario comunale Dott. Giuseppe Pinto Il responsabile del procedimento Geom. Pietro Camporotondo L’Autorità competente per la VAS Geom. Pietro Camporotondo Progettazione Urbanistica Ing. Francesco Escoli Valutazione Ambientale Strategica Arch. Luigi Corti Ing. Claudia Lucotti Studio geologico Dott. Giorgio Negrini Comune di Menconico (PV) PGT 2010 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO 1 PREMESSA ..........................................................................................................1-4 2 RIFERIMENTI NORMATIVI ...................................................................................2-6 2.1 Il quadro di riferimento nazionale: Testo Unico Ambientale e decreti correttivi............2-6 2.2 La Legge Regionale 12/2005: pianificazione comunale...................................................2-7 2.3 La Legge Regionale 12/2005: Valutazione Ambientale Strategica ..................................2-9 2.4 Gli indirizzi regionali.....................................................................................................2-10 3 FASI PROCEDURALI ...........................................................................................3-11 -

Verbale Seconda Conf
COMUNE DI MENCONICO PROVINCIA DI PAVIA Via Capoluogo, 21 - 27050 Menconico (PV) Tel. 0383574001 - Fax 0383574156 P. IVA/C.F. 01240140184 Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica del P.G.T. Verbale 2^ Conferenza di Valutazione Finale ‐ VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 18 FEBBRAIO 2011 Premesso che: ‐ ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 12/2005, delle indicazioni contenute negli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale in data 13.03.2007 n° VIII/351, del DGR n. 6420 del 27 dicembre 2007 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi" e della parte seconda del D.Lgs 152/06 e della direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001, la formazione del Piano di Governo del Territorio è sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) attraverso l’assoggettamento del Documento di Piano (e delle sue varianti) alla stessa procedura di VAS; Premesso che: ‐ con atto della Giunta Comunale n. 14 del 24/04/2010 e modifiche ed integrazioni introdotte con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 06/07/2010 è stato deliberato l’avvio del procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nell’ambito della redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) ed è stata attivata e disciplinata la “fase di informazione, consultazione e partecipazione”; ‐ in dipendenza della delibera della Giunta Comunale sopra citata, l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato integralmente all’albo comunale -

Provincia Di Pavia Assessorato Alle Politiche Agricole, Faunistiche E
Provincia di Pavia Assessorato alle Politiche Agricole, Faunistiche e Naturalistiche PIANO FAUNISTICO-VENATORIO E DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PAVIA 2006 - 2010 Provincia di Pavia Assessorato alle Politiche Agricole, Faunistiche e Naturalistiche PIANO FAUNISTICO-VENATORIO E DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PAVIA Assessore alle Politiche Agricole, Faunistiche e Naturalistiche: Ruggero Invernizzi Supervisione scientifica Guido Tosi Settore Faunistico-Naturalistico: Anna Betto (Dirigente) Mario Tuzzi (Responsabile di Unità Operativa) Anna Brangi (Funzionario) Ernestino Mezzadra (Istruttore) Simona Galuppi (Funzionario) Enrica Ambrosini (Funzionario) Paolo Losio (Funzionario) Bruno Sparpaglione (Funzionario) Sergio Carlissi (Primo Vigile Caccia e Pesca) Giovanni Boiocchi (Primo Vigile Caccia e Pesca) Alberto Lanati (Istruttore) Settore Agricoltura: Franco Campetti (Funzionario) Consulenti esterni: Eugenio Carlini Barbara Chiarenzi Giovanni Franco Zoller Hanno collaborato: Alessandro Banterle, Renato Bertoglio, Paolo Ferrari, Vincenzo Fontana, Enrico Leone, Pietro Soria, Wilma Tosi INDICE PIANO FAUNISTICO VENATORIO ....................................................... 1 1. INTRODUZIONE ............................................................................................................................ 3 1.1. PREMESSA......................................................................................................................................... 3 1.2. OBIETTIVO GENERALE -

Bollettino Lavoro 20.04.2020
SPORTELLO LAVORO AMBITO TERRITORIALE DI CERTOSA DI PAVIA PIANO DI ZONA - COMUNE CAPOFILA SIZIANO BASCAPÈ, BATTUDA, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA, CURA CARPIGNANO, GIUSSAGO, LANDRIANO, LARDIRAGO, MARCIGNAGO, MARZANO, ROGNANO, RONCARO, SANT’ALESSIO CON VIALONE, TORREVECCHIA PIA, TROVO, TRIVOLZIO, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO E ZECCONE Gli Sportelli Lavoro sono attivi presso 9 Comuni dell'Alto Pavese: Bornasco, Casorate Primo, Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Landriano, Siziano, Torrevecchia Pia, Vellezzo Bellini, Vidigulfo. Il servizio si occupa di fornire gratuitamente ai cittadini del Distretto tutte le informazioni necessarie in tema di occupazione e di formazione, con la priorità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per prenotare un appuntamento scrivere all'indirizzo mail: [email protected] BOLLETTINO OFFERTE DI LAVORO DEL 20/04/2020 Attenzione! Per rispondere alle inserzioni pubblicate fare riferimento ai recapiti riportati all’interno del testo di ciascun annuncio a cui si intende rispondere. OFFERTE DI LAVORO SPORTELLO LAVORO Agenzia per il lavoro di Voghera Cerca: OSS/ ASA/ INFERMIERI Sede di lavoro: strutture operanti nel settore socio assistenziale Pavia e provincia, Alessandria e provincia Requisiti: - Qualifica di OSS o ASA o INFERMIERI - Patente di guida B, automuniti - Disponibilità immediata - Disponibili su 3 turni Si offre: contratto in somministrazione a tempo determinato per gestione emergenza COVID19 Per candidarsi invia la tua -

Comuni Serviti Da Pavia Acque Comune Acquedotto Fognatura
Comuni serviti da Pavia Acque Comune Acquedotto Fognatura ALAGNA SERVITO SERVITO ALBAREDO ARNABOLDI SERVITO SERVITO ALBONESE SERVITO SERVITO ALBUZZANO SERVITO SERVITO ARENA PO SERVITO SERVITO BADIA PAVESE SERVITO SERVITO BAGNARIA SERVITO SERVITO BARBIANELLO SERVITO SERVITO BASCAPE' SERVITO SERVITO BASTIDA PANCARANA SERVITO SERVITO BATTUDA SERVITO SERVITO BELGIOIOSO SERVITO SERVITO BEREGUARDO SERVITO SERVITO BORGARELLO SERVITO SERVITO BORGO PRIOLO SERVITO SERVITO BORGO SAN SIRO SERVITO SERVITO BORGORATTO MORMOROLO SERVITO SERVITO BORNASCO SERVITO SERVITO BOSNASCO SERVITO SERVITO BRALLO DI PREGOLA SERVITO SERVITO BREME SERVITO SERVITO BRESSANA BOTTARONE SERVITO SERVITO BRONI SERVITO SERVITO CALVIGNANO SERVITO SERVITO CAMPOSPINOSO SERVITO SERVITO CANDIA LOMELLINA SERVITO SERVITO CANEVINO SERVITO SERVITO CANNETO PAVESE SERVITO SERVITO CARBONARA AL TICINO SERVITO SERVITO CASANOVA LONATI SERVITO SERVITO CASATISMA SERVITO SERVITO CASEI GEROLA SERVITO SERVITO CASORATE PRIMO SERVITO SERVITO CASSOLNOVO SERVITO SERVITO CASTANA SERVITO SERVITO CASTEGGIO SERVITO SERVITO CASTELLETTO DI BRANDUZZO SERVITO SERVITO CASTELLO D'AGOGNA SERVITO SERVITO CASTELNOVETTO SERVITO SERVITO CAVA MANARA SERVITO SERVITO CECIMA SERVITO SERVITO CERANOVA SERVITO SERVITO CERETTO LOMELLINA SERVITO SERVITO CERGNAGO SERVITO SERVITO CERTOSA DI PAVIA SERVITO SERVITO CERVESINA SERVITO SERVITO CHIGNOLO PO SERVITO SERVITO CIGOGNOLA SERVITO SERVITO Comune Acquedotto Fognatura CILAVEGNA GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE SERVITO CODEVILLA SERVITO SERVITO CONFIENZA SERVITO SERVITO COPIANO -

COMUNE DI VOGHERA Provincia Di Pavia PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE
COMUNE DI VOGHERA Provincia di Pavia PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI (D.G.R. N. 4138/2020) ANNO 2021. FINALITÀ Il presente bando disciplina l’erogazione del buono sociale finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare e/o le prestazioni di personale di assistenza regolarmente impiegato, secondo quanto previsto dalla D.G.R. N. 4138/2020 (Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità 2020 esercizio 2021). DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO ALLA MISURA Sono destinatari del buono sociale le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti: - di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale; - in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell’indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. n. 508/1988; - con i seguenti valori massimi ISEE di riferimento: sociosanitario fino a un massimo di € 25.000,00 e ISEE ordinario in caso di minori fino a un massimo di € 40.000,00. Possono presentare domanda per l’ottenimento del buono sociale le persone residenti nei Comuni di Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Casei Gerola, Cecima, Codevilla, Colli Verdi, Corana, Cornale e Bastida, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano Terme, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Val di Nizza, Varzi, Voghera, Zavattarello. -

Voghera Varzi
GREENWAY V O I G RZ HERA • VA Voghera - Varzi Voghera Varzi UNA VIA VERDE VERSO L’APPENNINO con il contributo di Crediti Greenway Voghera - Varzi: una via verde verso l’Appennino • Guida al percorso è un progetto della Provincia di Pavia in collaborazione con la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese e Legambiente Lombardia, con il contributo di Fondazione Cariplo e di Regione Lombardia. Progetto editoriale, grafica, testi, impaginazione e stampa: Bell&Tany, Voghera, bell-tany.it. Finito di stampare nel mese di giugno 2021. ©Provincia di Pavia 2021 ©Bell&Tany 2021 Ogni diritto riservato. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è severamente vietata. www.provincia.pv.it www.visitpavia.com www.greenwayvogheravarzi.it Questa guida è stata realizzata, nel rispetto dell’ambiente, con carta riciclata. alla scoperta dell’ OLTREPÒ PAVESE 2044 0053 AT / 11 / 002 GREENWAY V O I G RZ HERA • VA Voghera - Varzi Esplorando Camminando Pedalando Gustando alla scoperta dell’ OLTREPÒ PAVESE 2 La Greenway Voghera - Varzi è pronta. Un sogno lungo 33 chilometri cominciato quando sognare non costava nulla. Quando pensare di recuperare la vecchia linea ferroviaria sembrava un’idea romantica, bella e suggestiva ma tanto improbabile. Eppure ce l’abbiamo fatta. Con pazienza, ostinazione e tanta forza di volontà. Se è vero, come scrive Eleanor Roosevelt, “che il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni” allora noi oggi consegniamo all’Oltrepò un piccolo pezzo per sperare in un futuro diverso e migliore. Scoprire il territorio, vivere le bellezze naturali, condividere il piacere della buona tavola, farsi conquistare dal silenzio di luoghi inaspettati e magici, stare insieme agli amici sperando che il tempo non passi mai. -

Ronde Della Val Di Nizza
REGIONI 2a Tappa · 2ème Etape · 2nd Stage TROFEOIIBBD CONCESSIONARI E SUCCURSALE COPPADELLA PROVINCIA DI PAVIA banca del monbe ~di Pauia SALICE TERME 18-20 MAGGIO 1984 ..~~~g~:l 'dO! le '\.~;:' II"f'P .!l7fl Ca /.na I re o PARTENZA DEPART START ARRI VO ARRIVEE ARAI AL PROVE SP ECIALI EPREU VES DE CLASSEMENT SPECIAL STAGES Dalla Grande Carta da Torino e Milano alla Riviera ligu 1: 200.000 del Touring Club Italiano. Rioroduzione autorizzata 2a TAPPA - 19-20 MAGGIO 1984 Tempi Mediah Orar, Tempi ~ediah Orar. Dist Dist PROVE Dist Dist. PROVE C,O, LOCALITÀ fra i fra i teor. C.O. LOCALITÀ fra i fra i teor, parz, progr, SPECIALI parz, progr. SPECIALI C,O, C.O. conc.n.l C.O. C.O. cone.n.l 1 SALICE TERME (Part.) 22.01 Start P.S. G/l S' 7.32 ASS.PROD. Tovazza VINI DOC Start P.S, A/l S' 2206 P.S. A / l 16 ROMAGNESE 12 361 18' 38.77 7.S0 CANN ETO p Pozzolgroppo LANCIA Godiasco ALTAUTO Start P.S. H/l S' 7.SS P.S, H/l Ponte Nizza PAVIA Casa Matti Comune 2 PRENDOMINO 26 26 3S' 43,11 22.41 Passo Penice di S. Pietro Casasco Menconico S' 22.46 PS. B/l Start P.S. B/l Varzi (AREA O'ASSISyNZj) Sanguignano SABA 17 VARZI Stab, Zincor 27 388 SO' 31.32 8.4S Languzzano VERNICI Fortunago Portalbera 18 VARZI I 1 I 389 S' 8.S0 Schizzola Start P.S. F/2 Str. x Pietragavina S' 8.SS fOCO STOP Rocca Susella 19 ZAVATTARELLO 13 402 18' 41 .00 9.13 VOGHERA Nazzano - 67 SO' 48,96 23.36 Start P.S. -

Regione Lombardia
REGIONE LOMBARDIA - ELENCO COMUNI PROGETTO BANDA ULTRA LARGA Provincia Comune Nome Comune 2019 Stato Firma della convenzione Bergamo Adrara San Martino Adrara San Martino SI Bergamo Adrara San Rocco Adrara San Rocco SI Bergamo Albano Sant'Alessandro Albano Sant'Alessandro SI Bergamo Albino Albino SI Bergamo Algua Algua SI Bergamo Almè Almè SI Bergamo Almenno San Bartolomeo Almenno San Bartolomeo SI Bergamo Almenno San Salvatore Almenno San Salvatore copertura > 95% SI Bergamo Alzano Lombardo Alzano Lombardo copertura > 95% SI Bergamo Ambivere Ambivere SI Bergamo Antegnate Antegnate NO Bergamo Arcene Arcene SI Bergamo Ardesio Ardesio SI Bergamo Arzago d'Adda Arzago d'Adda SI Bergamo Averara Averara SI Bergamo Aviatico Aviatico NO Bergamo Azzano San Paolo Azzano San Paolo SI Bergamo Azzone Azzone SI Bergamo Bagnatica Bagnatica NO Bergamo Barbata Barbata SI Bergamo Bariano Bariano copertura > 95% NO Bergamo Barzana Barzana SI Bergamo Bedulita Bedulita SI Bergamo Berbenno Berbenno SI Bergamo Bergamo Bergamo NO Bergamo Berzo San Fermo Berzo San Fermo SI Bergamo Bianzano Bianzano SI Bergamo Blello Blello SI Bergamo Bolgare Bolgare NO Bergamo Boltiere Boltiere copertura > 95% SI Bergamo Bonate Sopra Bonate Sopra SI Bergamo Bonate Sotto Bonate Sotto NO Bergamo Borgo di Terzo Borgo di Terzo SI Bergamo Bossico Bossico SI Bergamo Bottanuco Bottanuco SI Bergamo Bracca Bracca SI Bergamo Branzi Branzi SI Bergamo Brembate Brembate copertura > 95% NO Bergamo Brembate di Sopra Brembate di Sopra SI Bergamo Brignano Gera d'Adda Brignano Gera d'Adda SI Bergamo