5 Terenzio Zocchi ROCCASPINALVETI E FRAINE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

AMELIO PEZZETTA Via Monteperalba 34 – 34149 Trieste; E-Mail: [email protected]
Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Trieste 58 2016 57/83 XII 2016 ISSN: 0335-1576 LE ORCHIDACEAE DELLA PROVINCIA DI CHIETI (ABRUZZO) AMELIO PEZZETTA Via Monteperalba 34 – 34149 Trieste; e-mail: [email protected] Riassunto – Il territorio della provincia di Chieti (regione Abruzzo) misura 2.592 km² e occupa da nord a sud l'area com- presa tra le valli dei fiumi Pescara e Trigno, mentre da sud-ovest a nord-ovest lo spartiacque di vari massicci montuosi lo separa da altre province. Nel complesso è caratterizzato da una grande eterogeneità ambientale che consente l'attec- chimento di molte specie vegetali. Nel presente lavoro è riportato l’elenco floristico di tutte le Orchidacee comprendenti 88 taxa e 21 ibridi. A sua volta l'analisi corologica evidenzia la prevalenza degli elementi mediterranei seguita da quelli eurasiatici. Parole chiave: Chieti, Orchidaceae, check-list provinciale, elementi floristici. Abstract – The province of Chieti (Abruzzo Region) measuring 2,592 square kilometers and from north to south occupies the area between the valleys of the rivers Trigno and Pescara while from the south-west to north-west the watershed of several mountain ranges separating it from other provinces. In the complex it is characterized by a great diversity envi- ronment that allows the engraftment of many plant species. In this paper it contains a list of all the Orchids flora including 88 taxa and 21 hybrids. In turn chorological analysis highlights the prevalence of Mediterranean elements followed by those Eurasian. Keywords: Chieti, Orchidaceae, provincial check-list, floristic contingents. 1. - Inquadramento dell'area d'indagine Il territorio della provincia di Chieti copre la superficie di 2.592 km², com- prende 104 comuni e la sua popolazione attuale e di circa 397000 abitanti. -

Convocazione Assemblea Ordinaria Dei Soci 08.01.2021
Protocollo n. 0SU/8772 del 30/12/2020 - Uscita Inviato esclusivamente tramite e-mail ai sensi Dell’art. 47, comma 1 del D.Lgs. 82/05. Non seguirà trasmissione dell’originale ai sensi dell’art. 45 del medesimo D.Lgs. Ai Soci BANCA POPOLARE DI LANCIANO [email protected] CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO [email protected] [email protected] CASSA DI RISPARMIO PROVINCIA DI CHIETI [email protected] e p.c. [email protected] C.C.I.A.A. CHIETI [email protected] COMUNE DI ALTINO [email protected] COMUNE DI ARCHI [email protected] COMUNE DI ATESSA [email protected] COMUNE DI ATRI [email protected] COMUNE DI AVEZZANO [email protected] COMUNE DI BOMBA [email protected] COMUNE DI BORRELLO [email protected] COMUNE DI CAMPLI [email protected] COMUNE DI CARPINETO SINELLO [email protected] 2 COMUNE DI CARUNCHIO [email protected] COMUNE DI CASAL BORDINO [email protected] COMUNE DI CASALANGUIDA [email protected] COMUNE DI CASOLI [email protected] COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE [email protected] COMUNE DI CASTEL DI SANGRO [email protected] COMUNE DI CASTEL FRENTANO [email protected] COMUNE DI CASTELGUIDONE [email protected] COMUNE DI CASTELLALTO [email protected] COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO -

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE SVILUPPO DEL TURISMO, POLITICHE CULTURALI Servizio Investimenti Pubblici, Politiche Turistiche - Ufficio Sostegno Alle Imprese
REGIONE ABRUZZO DIREZIONE SVILUPPO DEL TURISMO, POLITICHE CULTURALI Servizio Investimenti Pubblici, Politiche Turistiche - Ufficio Sostegno Alle Imprese L.R. 77/2000 - PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2010 - 2011 Elenco con esito estrazione delle pratiche spedite il giorno 16 aprile 2012 Esito Numero Denominazione Sede Comunità Estrazione Pratica Richiedente Legale Montana 1 0039 SOGEA SRL SILVI 2 0059 DINO'S DI BRUNA DI PANCRAZIO & C. S.A.S GIULIANOVA VITTORIA SAS DI DI TOMMASO CRISTIANO PESCARA 3 0330 & C. 4 0347 STEFANIA PEPE E C. S.A.S. ALBA ADRIATICA ALBERGO ANTAGOS DI RENISI MONTESILVANO 5 0351 SALVATORE E LUIGI S.A.S. BARRACUDA SAS DI DE MAGISTRIS ORTONA 6 0476 ASSUNTA & C. 7 0391 NACALUA S.R.L. CITTA' SANT'ANGELO 8 0533 OVERCOM GROUP SRL PESCARA 9 0006 IL BUCANEVE SRL ROCCARASO COSTA VERDE SAS DI BELMONTE SILVI 10 0047 GABRIELLA & C. ALBERGO RISTORANTE TERESA DI BETTI ISOLA DEL GRAN 11 0420 MARIO & C. SNC SASSO F.LLI BUSSOLI DI TIBERIO GIUSEPPINA & C. CASALBORDINO 12 0406 SAS ANTONUCCI ANTONIO CIVITELLA 13 0157 ALFEDENA 14 0142 CAMPING TAM TAM DI FERRI E. & C. ???????????????????? ORSA MAGGIORE SAS DI RABUFFO PESCARA 15 0175 NICOLINO & C. 16 0592 CAFFE' CARIBE SRL SAN SALVO NUOVO ALBERGO SAS DI BOCASSINI CHIETI 17 0328 NICOLA & C. 18 0057 CORSARI DEL MEDITERRANEO MONTESILVANO GENESIS S.R.L. ROSETO DEGLI 19 0344 ABRUZZI Pagina 1 di 26 Esito Numero Denominazione Sede Comunità Estrazione Pratica Richiedente Legale Montana 20 0086 L'INCONTRO DI DE FABIIS FILOMENA PALENA 21 0104 PAGNANI SERGIO PESCASSEROLI 22 0437 MANHATTAN SRL CASTEL DI SANGRO 23 0536 LIBERTY PRIVATE INVESTIMENT SRL CRECCHIO 24 0100 LANFALONI GAETANO MONTESILVANO 25 0507 MONASTERIO DI GIANLUCA SORDINI S.A.S. -

Actes Dont La Publication Est Une Condition De Leur Applicabilité)
30 . 9 . 88 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 270/ 1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) N° 2984/88 DE LA COMMISSION du 21 septembre 1988 fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1987/1988 en Italie, en Espagne et au Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que, compte tenu des donnees reçues, il y a lieu de fixer les rendements en Italie, en Espagne et au vu le traité instituant la Communauté économique euro Portugal comme indiqué en annexe I ; péenne, considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22 grasses, septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT : n0 2210/88 (2), vu le règlement (CEE) n0 2261 /84 du Conseil , du 17 Article premier juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive , et aux organisa 1 . En Italie, en Espagne et au Portugal, pour la tions de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le campagne 1987/ 1988 , les rendements en olives et en règlement (CEE) n° 892/88 (4), et notamment son article huile ainsi que les zones de production y afférentes sont 19 , fixés à l'annexe I. 2 . La délimitation des zones de production fait l'objet considérant que, aux fins de l'octroi de l'aide à la produc de l'annexe II . -

PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - (Art.1 - Comma 3 - Lett
REGIONE IL COMMISSARIO DELEGATO ABRUZZO Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione Abruzzo. Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2015 Tabella 2 PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - (art.1 - comma 3 - lett. c - OCDPC 256/2015) - PRIMA RIMODULAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI COME DA INTERVENTI STRUTTURALI PIANO DEGLI INTERVENTI APPROVATO PRIMA RIMODULAZIONE PROPOSTA TEMPI STIMATI DI TEMPI STIMATI DI LOCALIZZAZIONE PROV. DESCRIZIONE INTERVENTI STIMA INTERVENTI STIMA INTERVENTI REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE Interventi urgenti di consolidamento in località 1 CARPINETO DELLA NORA PE € 300.000,00 6 mesi € 295.000,00 6 mesi centro abitato Fratte C.da Solagne - Intervento di consolidamento e 2 CIVITAQUANA PE € 300.000,00 6 mesi € 295.000,00 6 mesi risanamento dell'intero versante Intervento di consolidamento su n.2 frane nella 3 PIETRANICO PE strada comunale denominata Internicola e in € 200.000,00 4 mesi € 195.000,00 4 mesi località Vasca C.da Colle Quinzio - Vestea. Primo intervento di 4 CIVITELLA CASANOVA PE consolidamento di versante per movimento € 900.000,00 12 mesi € 900.000,00 12 mesi franoso esteso e complesso Loc. Traino. Consolidamento del fronte di frana 5 VILLA CELIERA PE € 400.000,00 6 mesi € 390.000,00 6 mesi e ripristino danni Intervento di ripristino del collegamento 6 CORVARA PE interrotto per frana complessa su S.P. n. 53 € 400.000,00 8 mesi € 390.000,00 8 mesi Corvara - Pescosansonesco. Intervento di ripristino della sede stradale in 7 FARINDOLA PE € 200.000,00 2 mesi € 200.000,00 2 mesi località Macchie Realizzazione di gabbionate a monte e a valle 8 PENNE PE della sede stradale - drenaggi - muro su pali; € 350.000,00 6 mesi località Roccafinadamo Realizzazione di gabbionate a monte della sede 8 BIS PENNE PE stradale - muri su pali - impalcato su pali; Sc. -
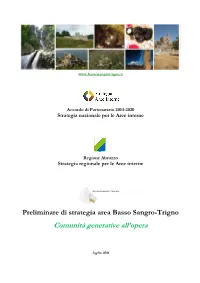
Comunità Generative All'opera
www.bassosangrotrigno.it Accordo di Partenariato 2014-2020 Strategia nazionale per le Aree interne Regione Abruzzo Strategia regionale per le Aree interne Basso Sangro-Trigno Preliminare di strategia area Basso Sangro-Trigno Comunità generative all’opera luglio 2016 Sommario 1. TERRITORIO INTERESSATO, IDEA GUIDA E FILIERA COGNITIVA ................................................................. 3 Chi siamo e da dove veniamo ........................................................................................................................ 3 Descrizione del Sistema Intercomunale Permanente ................................................................................... 4 Rapporto tra area progetto e area strategica ............................................................................................... 4 Descrizione dell’Idea guida ............................................................................................................................ 5 2. ASSOCIAZIONISMO DEI COMUNI ............................................................................................................... 8 Motivazione di scelte di condivisione di Funzioni e Servizi ........................................................................... 8 Altre forme Associative ............................................................................................................................... 10 3. SERVIZI ESSENZIALI .................................................................................................................................. -

21/07/2020 Pagina 1 Di 5 F.To IL SEGRETARIO GENERALE
21/07/2020 Il sottoscritto Michele De Vita Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara attesta che l’allegato elenco dei pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti nella provincia di Chieti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del decreto 9 agosto 2000, n. 316: <<Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480>> è stato affisso all’Albo di questa Camera dal giorno 21 Luglio 2020. F.to IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Michele De Vita) Pagina 1 di 5 21/07/2020 Prv. Stato Cognome Nome Codice fiscale Attivo/Cessato Prv Tipo Prog. Indirizzo Comune Res. Res. Res. FERRENTI SEGRETARIO COMUNALE CIVITELLA MESSER A CH C 3 VIA MAIELLA, 1 CH ANGELA DI CIVITELLA M.R. RAIMONDO FERRENTI SEGRETARIO COMUNALE A CH C 7 VIA MUNICIPIO, 1 FARA SAN MARTINO CH ANGELA DI FARA SAN MARTINO D'ALOIA ANNA SEGRETARIO COMUNALE A CH C 13 VIA VITT. EMANUELE CANOSA SANNITA CH MARIA DI CANOSA SANNITA FERRARI SEGRETARIO COMUNALE A CH C 14 P. MUNICIPIO, 5 TARANTA PELIGNA CH GIUSEPPE DI TARANTA PELIGNA D'ALOIA ANNA SEGRETARIO COMUNALE A CH C 15 CORSO ITALIA GIULIANO TEATINO CH MARIA DI GIULIANO TEATINO DE THOMASIS SEGRETARIO COMUNALE A CH C 23 VIA S. ROCCO ROCCAMONTEPIANO CH RAFFAELLA DI ROCCAMONTEPIANO CERASOLI SEGRETARIO COMUNALE FRANCAVILLA AL A CH C 24 P. S.DOMENICO, 1 CH NANDO DI FRANCAVILLA AL M. -

Espletamento Procedure Di Gara Risultanze
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento sulle reti idriche e fognarie nei Comuni dell’A.T.O n° 6 Chietino. GARE D'APPALTO Anno 2015 - ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA RISULTANZE PROVVISORIE n° Importo area Comuni I° classificata provvisoria II° classificata provvisoria ord complessivo Crecchio COLANTUONO GROUP srl di ADEZIO COSTRUZIONI di Ari 1 "A1" Ortona € 130.000,00 Tollo Tollo (CH) (Ch) Ari Arielli Canosa Sannita MOVIMENTO TERRA di Filetto COGEMA SRL Via Aterno, 397 2 "A2" Giuliano Teatino € 100.000,00 Giuseppe GallucciC.da S. Basile, Fraz. Brecciarola -Chieti Orsogna 45 Orsogna (Ch) Poggiofiorito Vacri Villamagna Casacanditella Casoli Civitella M Raimondo S.A.CE.B. srl di San Martino EDILIZIA CANDELORO di 3 "A3" Fara San Martino € 200.000,00 Guardiagrele sulla Marruccina (Ch) Torrevecchia Teatina (CH) San Martino sulla Maruccina Palombaro Pennapiedimonte Fossacesia Mozzagrogna Rocca San Giovanni SORMAN SRL di Fossacesia 4 "B1" € 100.000,00 Nasuti Nicola di Lanciano (CH) S. Eusanio del Sangro (CH) San Vito Chietino Santa Maria Imbaro Frisa CITI snc di Bellisario G&C di POINT Costruzioni di Di Antonio 5 "B2" Lanciano € 200.000,00 Treglio Lanciano Filippo Teramo Casalbordino Castelfrentano DI FLORIO geom C Lorenzo di VITULLI COSTRUZIONI di 6 "B3" Paglieta € 100.000,00 S. Eusanio del Sangro Paglieta (CH) Paglieta (CH) Torino di Sangro Altino Archi VERRATTI VINCENZO di Casoli 7 "B4" Atessa € 100.000,00 SAGAS srl di Offida (AP) Perano (CH) Villalfonsina Cupello ASFALTI TRIGNO srl di Vasto IPRESA MOLINO SRL DI -

3284961467 A872|7L26AL 3283808189 333689164S
A,SL LANCIANO VASTO CHIETI REPERIBILTTA' NOTTURNA (20.00/08.00) DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE REPERTBTL|TA' FESTTVA (08.00/08.00) SERVIZI VETERINARI SANITA' ANTMALE ffi MESE DI GIUGNO 2015 Attività Sarantite nei turni di pronta disponibilità: emergenza randagismo; randagi ed animali gravemente feriti; emergenze epidemiche; focolai di malattie infettive; movimentazioni nazionali ed internazionali non derogabili; attività di Polizia Veterinaria e di polizia Giudiziaria. LTSTA CS&IUNI MACROAREA CHIETI ARt, ARIELLI, BUCCHIANICO, CANOSA SANNtTA, CASACANDTTELLA, CASALTNCONTRADA, CHlETt, CRECCHIO, FARA FTLORUM PETRI, FARA SAN MARTINO, FILEfiO, FRANCAVILLA, GIULIANO TEATINO, GUARDIAGRELE, MIGLIANICO, ORSOGNA, ORTONA, i PENNAPIEDIMoNTE, poccloFtoRtro, pREToRo, RAplNo, RtpA TEAT|NA, RoccAMoNTEptANo, sAN GtovANNt rEATtNo, |sl@ToRREVEccHlATEATlNA,VAcRl,VlLLAMAGNA. LISTA CSIIIIUNI MACROAREA LANCIAT** ALTINO, ARCHI, ATESSA, BOMBA, BORRELLO, CASOLI, CASTEL FRENTANO, CIVITALUPARELLA, CIVITELLA MESSER RAIMONDO, COLLEDIMACINÉ, COLLEDIMEZZO, FALLO, FOSSACESIA, FRISA, GAMBERALE, GESSOPALENA, LAMA DEI PELIGNI, IANCIANO, LETTOPALENA, MONTEBELLO SUL SANGRO, MONTEFERRANTE, MONTELAPIANO, MONTENERODOMO, MOZZAGROGNA, PAGLIETA, PALENA, PALOMBARO, PENNADOMOI PERANO' PIETRAFERRAZZANA' PIZZOFERRATO, qUADRI' ROCCA sAN GIOVANNI, ROCCASCALEGNA, ROIO DEL SANGRO, ROSELLO, SAN VITO CHIETINO, SANTA MARIA IMBARO, SANT'EUSANIO DEL SANGRO, TARANTA PELIGNA, TORRICELL.A PELIGNA, TREGLIO, VILLA SANTA MARIA TISTA 6g6;U* MACROARSA SASTO IMACROAETA CARPINETO SINELLO, CARUNCHIO, CASALANGUIDA, -

Itinerari Di Sacro E Natura Nella Provincia Di Chieti Picciano Cappelle Sul Tavo
Itinerari di Sacro e Natura nella Provincia di Chieti Picciano Cappelle sul Tavo Collecorvino Spoltore Pescara Pretaro 0 10 km Loreto Aprutino Moscufo Sambuceto Francavilla al Mare San Giovanni Teatino Torremontanara N A14 PESCARA SUD Pianella Cerratina FRANCAVILLA AL MARE Stazione di Tollo PESCARA OVEST Torrevecchia Teatina CHIETI Villanova Lido Riccio Chieti Scalo Savini Castelferrato S. Salvatore O E Cepagatti Miglianico 11 Ortona Villa 1 Ripa Teatina San Tommaso ro Villa Badessa o o Tollo Villa t F Villareia n e San Nicola le ChietiA m CHIETI u e i ORTONA SS 16 m F A25 iu Villamagna Punta di Acquabella S F a ar Collesecco Carpineto sc Civitaquana Nocciano Pe Brecciarola Villa della Nora e E 90 m SS 5 Grande Villa u Casino Rosciano Fi San Rocco S. Leonardo Vezzani San Vito Chietino Bucchianico Villa La percezione che da sempre l’uomo ha avuto della realtà è quella di un nesso inscin- Marina di San Vito Cugnoli Casalincontrada Giuliano Villa Tucci Torre Teatino Villa Alanno Vacri Rogatti 2 Ari dibile tra “sacro e natura”, quel che di misterioso che solo oggi sta perdendo quella Villa Caldari S. Apollinare SS 81 Colle Spaccato 10 Canosa Sannita Mancini Villa San Giovanni o n Corvara i r t l LANCIANO San Pietro Fe Punta del Cavalluccio suggestione e quel valore che ha distinto per millenni il cammino dell’umanità. Reginaldo e Semivicoli Crecchiot o en Puncichitti r rr La Penna o To Treglio M Terranova e Pescosansonesco t Frisa Rocca San Giovanni Viano n Fara Filiorum Petri Arielli e Il territorio della provincia di Chieti vanta tra le -

Comune Di Celenza Sul Trigno (CH)
Comune di Celenza sul Trigno Provincia di Chieti PIANO INDUSTRIALE OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO DI CELENZA SUL TRIGNO Luglio 2018 Realizzato da: Piano industriale per l’ottimizzazione della gestione integrata della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e altri servizi di igiene urbana sul territorio di Celenza sul Trigno Il presente elaborato progettuale è di proprietà dell’Amministrazione comunale di Celenza sul Trigno (provincia di Chieti). E’ vietata la riproduzione del presente documento se non espressamente autorizzato 2 | P a g . Piano industriale per l’ottimizzazione della gestione integrata della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e altri servizi di igiene urbana sul territorio di Celenza sul Trigno Sommario 1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 1.1 Premessa............................................................................................... 5 1.2 La normativa nazionale ........................................................................... 7 1.3 La normativa regionale .......................................................................... 10 1.4 Gli aggiornamenti comunitari –nuovi obiettivi vincolanti in materia di riduzione dei rifiuti ................................................................................................... 12 2. I MODELLI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI 2.1 Nozioni ............................................................................................... -

Scheda Progetto Per L'impiego Di Volontari in Servizio Civile in Italia Ente Caratteristiche Progetto
(Allegato 1) SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA ENTE 1) Ente proponente il progetto: Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno Sinello 2) Codice di accreditamento: NZ 02847 3) Albo e classe di iscrizione: Albo Regione Abruzzo 3 CARATTERISTICHE PROGETTO 4) Titolo del progetto: Sistema Informativo Territoriale Trigno Sinello 5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): Ambiente – Salvaguardia del suolo e dissesto idrogeologico – C/7 6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: L’Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno Sinello si è costituita nel 1999, tramite convenzione, da 54 Comuni del comprensorio Trigno-Sinello ricadenti nelle province di Chieti, Campobasso e Isernia per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali: Sportello Unico (DPR 447/98 e s.m.i.) per unificare e snellire le procedure tecnico- amministrative e dare informazioni sulle caratteristiche dell’area Rete telematica per sviluppare servizi Fiscalità locale e Sistema informativo Territoriale Programmi di intervento e altri strumenti e procedure per la gestione unitaria di tutti e ogni altro procedimento amministrativo funzionale allo sviluppo dell’area. E’ governata dal Comitato dei Sindaci dove sono rappresentati tutti i sottoscrittori della convenzione con pari rappresentanza. Le decisioni del Comitato sono vincolanti per il Comune Capofila (San Salvo) che svolge la funzione di rappresentanza e di gestione delle risorse finanziarie. L’Associazione non si sostituisce ai Comuni o altri Enti nelle funzioni tradizionali già consolidate salvo attività che richiedono specifica professionalità ed economia di scala.