Apollod.] 3.5.5 (41 W.)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ovid: the Poems of Exile (Tristia, Ex Ponto, Ibis)
Ovid: The Poems Of Exile (Tristia, Ex Ponto, Ibis) Home Download Translated by A. S. Kline 2003 All Rights Reserved This work may be freely reproduced, stored, and transmitted, electronically or otherwise, for any non-commercial purpose. 2 Contents Tristia Book I.................................................................. 11 Book TI.I:1-68 The Poet to His Book: Its Nature ........... 11 Book TI.I:70-128 The Poet to His Book: His Works...... 14 Book TI.II:1-74 The Journey: Storm at Sea.................... 17 Book TI.II:75-110 The Journey: The Destination........... 21 Book TI.III:1-46 The Final Night in Rome: Preparation 23 Book TI.III:47-102 The Final Night in Rome: Departure25 Book TI.IV:1-28 Troubled Waters.................................. 28 Book TI.V:1-44 Loyalty in Friendship ........................... 30 Book TI.V:45-84 His Odyssey........................................ 32 Book TI.VI:1-36 His Wife: Her Immortality .................. 34 Book TI.VII:1-40 His Portrait: The Metamorphoses ...... 37 Book TI.VIII:1-50 A Friend’s Treachery........................ 39 Book TI.IX:1-66 A Faithful Friend................................. 41 Book TI.X:1-50 Ovid’s Journey to Tomis ...................... 44 Book TI.XI:1-44 Ovid’s Apology for the Work ............. 46 Tristia Book II................................................................. 48 Book TII:1-43 His Plea: His Poetry................................ 48 Book TII:43-76 His Plea: His Loyalty............................ 50 Book TII:77-120 His Plea: His ‘Fault’............................ 53 Book TII:120-154 His Plea: The Sentence ..................... 55 Book TII:155-206 His Plea: His Prayer.......................... 57 Book TII:207-252 His Plea: ‘Carmen et Error’............... 59 Book TII:253-312 His Plea: His Defence ...................... -

|||GET||| Callimachus and His Critics 1St Edition
CALLIMACHUS AND HIS CRITICS 1ST EDITION DOWNLOAD FREE Alan Cameron | 9780691606125 | | | | | Reading Callimachus through comics Associated with Sicily and Cos, Theocritus was among the Callimachus and His Critics 1st edition Hellenistic poets, and his residence in Alexandria most likely belongs between the s and the s. One of Odysseus' crew, who had been left on their shore, was subsequently killed. To interpret the oracle which he received, he went to consult Pittheus of Troezen. The Lighthouse was built between Greene Providence College Haut de page. His was not the city described by Strabo, who was writing at the end of the first century CE, but a city in the process of being built: high levels of immigration, dynamic physical changes, and rapid growth would have persisted during his lifetime. It is a pivotal moment when the Callimachean narrator abstains from providing the aetia of well-known Athenian traditions, and gives his attention instead to the more mysterious traditions of Icus. So far as Delete Cancel Save. Heracles apparently killed and ate a bull being used for plowing. Although Callimachus himself was never head of the Library, his composition of the Pinakes and the breadth of his poetic and prose intertexts testifies to his active engagement with this new textual mode of thinking. Hueber,p. Facebook Twitter. The few indications we have suggest that Callimachus is poised to tell the well-attested story of the mother and son. Athenian Ideas about Citizenship and the Division b The answer recounts Minos in the act of sacrificing to the Graces learning about the death of his son Androgeos. -

Chapter 2 Investigates the Extended Catalogue of Curses in Ovid’S Ibis in Relation to Both the Mythographic Tradition and Ovid’S Own Poetic Corpus
UC Berkeley UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations Title Mythic Recursions: Doubling and Variation in the Mythological Works of Ovid and Valerius Flaccus Permalink https://escholarship.org/uc/item/11r709mb Author Krasne, Darcy Anne Publication Date 2011 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California Mythic Recursions: Doubling and Variation in the Mythological Works of Ovid and Valerius Flaccus by Darcy Anne Krasne A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Classics in the Graduate Division of the University Of California, Berkeley Committee in charge: Professor Ellen Oliensis, Chair Professor Anthony Bulloch Professor Christopher Hallett Professor John Lindow Professor Andrew Zissos Spring 2011 Mythic Recursions: Doubling and Variation in the Mythological Works of Ovid and Valerius Flaccus Copyright 2011 by Darcy Anne Krasne 1 Abstract Mythic Recursions: Doubling and Variation in the Mythological Works of Ovid and Valerius Flaccus by Darcy Anne Krasne Doctor of Philosophy in Classics University of California, Berkeley Professor Ellen Oliensis, Chair This dissertation explores the ways Latin poetry reworks the mythological tradition of which it itself is a part. I approach this broad topic primarily from the angle of mythological variation— that is, the competing and sometimes contradictory versions of individual myths which are an inherent component of the Greek and Roman mythological system. In Greece, myths and their variants played an important role in interfacing religion with politics. Through three “case studies” on the works of Ovid and Valerius Flaccus, I demonstrate different ways in which Roman poets, too, could utilize the pluralities of the tradition for their own poetic and political ends. -
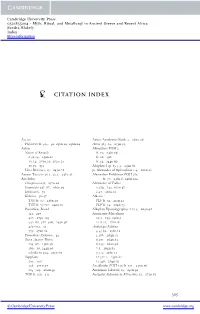
N Citation Index
Cambridge University Press 0521855004 - Myth, Ritual, and Metallurgy in Ancient Greece and Recent Africa Sandra Blakely Index More information N CITATION INDEX Accius Aetius Amidemus Book 2, 262n.26 Philoctetes fr. 525, 50, 236n.19, 236n.24 Aetna 363–65, 273n.99 Aelian Akousilaos FGH 2 Nature of Animals fr. 20, 236n.19 6.58.24, 239n.82 fr. 26, 198 10.14, 261n.20, 262n.23 fr. 34, 244n.90 10.40, 154 Alciphro I ep. 15 .5.3, 239n.82 Varia Historia 5.19, 243n.78 ps-Alexander of Aphrodisias 1.4, 262n.25 Aeneas Tacticus 20.3, 32.5, 241n.21 Alexandros Polyhistor FGH 273 Aeschylus fr. 77, 236n.8, 246n.124 Choephoroi 631, 237n.26 Alexander of Tralles Eumenides 937–87, 260n.39 2.579, 143, 262n.37 Isthmiastai, 50 2.47, 261n.16 Kabeiroi, 36–37 Alkaios TGF fr. 97, 236n.19 PLF fr. 34, 251n.22 TGF fr. 95–97, 240n.18 PLF fr. 14, 264n.73 Prometheus Bound Alkiphro Epistolographus 1.15 .5, 265n.98 133, 207 Ammianus Marcelinus 457, 273n.103 22.9, 193, 236n.6 442–68, 478–506, 245n.97 22.8.21, 272n.82 482–512, 53 Anthologia Palatina 715, 272n.82 4.33.89, 258n.12 Prometheus Pyrkaieus, 49 5.166, 264n.73 Seven Against Thebes 6.301, 264n.83 103–07, 238n.56 6.245, 260n.46 560, 50, 244n.90 7.8, 264n.83 scholia to 304, 253n.69 9.1.2, 258n.12 Suppliants 11.321.2, 239n.82 291, 198 11.346, 264n.83 548, 271n.47 Antikleides FGH 140 fr. -

Download PDF Datastream
Disruptive Verse: Hyperbole and the Hyperbolic Persona in Ovid’s Exile Poetry By Rachel Severynse Philbrick B.A., Cornell University, 2007 Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Department of Classics at Brown University PROVIDENCE, RHODE ISLAND MAY 2016 © Copyright 2016 by Rachel S. Philbrick This dissertation by Rachel S. Philbrick is accepted in its present form by the Department of Classics as satisfying the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. Date _____________________ ___________________________________ Joseph Reed, Advisor Recommended to the Graduate Council Date _____________________ ___________________________________ Johanna Hanink, Reader Date _____________________ ___________________________________ Pura Nieto Hernandez, Reader Approved by the Graduate Council Date _____________________ ___________________________________ Peter M. Weber, Dean of Graduate School iii Curriculum Vitae Rachel Severynse Philbrick was born on May 25, 1985, in Boston, Massachusetts. She grew up in Cambridge, Massachusetts, with her parents and older sister, and attended high school at Commonwealth School in Boston’s Back Bay neighborhood. As an undergraduate, she attended Cornell University, graduating in 2007 with highest honors, having earned a B.A. in Latin and a B.A. in Biology and Society. Following graduation, she taught science at Kramer Middle School in Washington, D.C., before enrolling at the University of Kentucky in August 2009, where she earned a Master’s degree in Classics in 2011. That fall, she entered the doctoral program at Brown University in the Department of Classics. In the fall of 2016, he will join the Department of Classics at Georgetown University as a Visiting Assistant Professor. iv Acknowledgements It is no exaggeration to say that this dissertation would not have been possible without the support of countless people. -
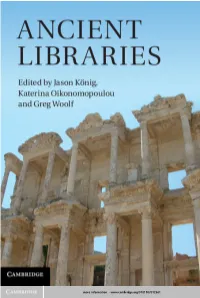
Ancient Libraries
more information - www.cambridge.org/9781107012561 Ancient Libraries The circulation of books was the motor of classical civilisation. But books were both expensive and rare, and so libraries – private and public, royal and civic – played key roles in articulating intellectual life. This collection, written by an international team of scholars, presents a fundamental reassessment of how ancient libraries came into being, how they were organised and how they were used. Drawing on papy- rology and archaeology, and on accounts written by those who read and wrote in them, it presents new research on reading cultures, on book collecting and on the origins of monumental library buildings. Many of the traditional stories told about ancient libraries are chal- lenged. Few were really enormous, none was designed as a research centre and occasional conflagrations do not explain the loss of most ancient texts. But the central place of libraries in Greco-Roman culture emerges more clearly than ever. jason konig¨ is Senior Lecturer in Greek at the University of St Andrews. He works broadly on the Greek literature and culture of the Roman Empire. He is author of Athletics and Literature in the Roman Empire (2005) and Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture (2012), and editor, jointly with Tim Whitmarsh, of Ordering Knowledge in the Roman Empire (2007). katerina oikonomopoulou is a postdoctoral research fellow for the programme ‘Medicine of the Mind, Philosophy of the Body – Discourses of Health and Well-Being in the Ancient World’ at the Humboldt-Universitat¨ zu Berlin. -

The Oxyrhynchus Papyri
LIBRARY Brigham Young University ^:^. Ace. 196S:^# ..: ?A No. - -. s 7 THE OXYRHYNCHUS PAPYRI PART VII HUNT ^ 3315 EGYPT EXPLORATION FUND GRAECO-ROMAN BRANCH THE OXYRHYNCHUS PAPYRI PART VII EDITED WITH TRANSLATIONS AND NOTES ARTHUR S. HUNT, D.Litt. HON. PH.D. KOF.NIGSBERG ; HON. LITT.D. DUBLIN ; HON. LL.D. GRAZ LECTURER IN PAPYROLOGY IN THE UNIVERSITY OF OXFORD, AND FELLOW OF QUEEN'S COLLEGE CORRESPONDING MEMHER OF THE ROYAL BAVARIAN ACADEMY OF SCIENCES WITH SIX PLATES LONDON SOLD AT The Offices of the EGYPT EXPLORATION FUND, 37 Great Russell St., W.C. AND 527 Tremont Temple, Boston, Mass., U.S.A. KEGAN PAUL, TRENCH, TRUBNER & CO., Dryden House, Gerrard St., W. BERNARD QUARITCH, Grafton St., New Bond St., W. ASHER & CO., 13 Bedford St., Covent Garden, W.C, and 56 Unter den Linden, Berlin AND HENRY FROWDE, Amen Corner, E.C, and 29-35 West 32ND Street, New York, U.S.A. I 9 10 All righls reserved OXFORD HORACE HART, PRINTER TO THE UNIVERSITY PREFACE The great majority of the papyri published in the following pages, including the chief literary pieces, were discovered in the season of 1905-6; a few come from the finds of the years 1903 and 1904, and one or two in the non-literary section from those of 1897. In editing these texts I have unhappily lacked the co-operation of the friend and colleague with whom I have worked in partnership since the foundation of the Graeco-Roman Branch. The effects of his absence are, I fear, likely to be apparent to the readers of this book not only in its somewhat reduced size, which on the present occasion corresponds with our advertised intentions more closely than has frequently been the case. -

Chapter 2 Investigates the Extended Catalogue of Curses in Ovid’S Ibis in Relation to Both the Mythographic Tradition and Ovid’S Own Poetic Corpus
Mythic Recursions: Doubling and Variation in the Mythological Works of Ovid and Valerius Flaccus by Darcy Anne Krasne A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Classics in the Graduate Division of the University Of California, Berkeley Committee in charge: Professor Ellen Oliensis, Chair Professor Anthony Bulloch Professor Christopher Hallett Professor John Lindow Professor Andrew Zissos Spring 2011 Mythic Recursions: Doubling and Variation in the Mythological Works of Ovid and Valerius Flaccus Copyright 2011 by Darcy Anne Krasne 1 Abstract Mythic Recursions: Doubling and Variation in the Mythological Works of Ovid and Valerius Flaccus by Darcy Anne Krasne Doctor of Philosophy in Classics University of California, Berkeley Professor Ellen Oliensis, Chair This dissertation explores the ways Latin poetry reworks the mythological tradition of which it itself is a part. I approach this broad topic primarily from the angle of mythological variation— that is, the competing and sometimes contradictory versions of individual myths which are an inherent component of the Greek and Roman mythological system. In Greece, myths and their variants played an important role in interfacing religion with politics. Through three “case studies” on the works of Ovid and Valerius Flaccus, I demonstrate different ways in which Roman poets, too, could utilize the pluralities of the tradition for their own poetic and political ends. Combining close reading with both focused and synoptic views of mythology, my methods present an approach to mythological poetry that comes squarely to terms with mythic variation as a significant textual strategy. The result is a version of intertextuality where the “text” at issue is, in effect, the complete body of myth.