Le Ricerche Archeo Isbn
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Umbria from the Iron Age to the Augustan Era
UMBRIA FROM THE IRON AGE TO THE AUGUSTAN ERA PhD Guy Jolyon Bradley University College London BieC ILONOIK.] ProQuest Number: 10055445 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest 10055445 Published by ProQuest LLC(2016). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 Abstract This thesis compares Umbria before and after the Roman conquest in order to assess the impact of the imposition of Roman control over this area of central Italy. There are four sections specifically on Umbria and two more general chapters of introduction and conclusion. The introductory chapter examines the most important issues for the history of the Italian regions in this period and the extent to which they are relevant to Umbria, given the type of evidence that survives. The chapter focuses on the concept of state formation, and the information about it provided by evidence for urbanisation, coinage, and the creation of treaties. The second chapter looks at the archaeological and other available evidence for the history of Umbria before the Roman conquest, and maps the beginnings of the formation of the state through the growth in social complexity, urbanisation and the emergence of cult places. -

The Long-Term Influence of Pre-Unification Borders in Italy
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna Conference Paper Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long- Term Influence of pre-Unification Borders in Italy 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna (2014) : Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long-Term Influence of pre-Unification Borders in Italy, 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/124400 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. -

The Burial of the Urban Poor in Italy in the Late Republic and Early Empire
Death, disposal and the destitute: The burial of the urban poor in Italy in the late Republic and early Empire Emma-Jayne Graham Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy Department of Archaeology University of Sheffield December 2004 IMAGING SERVICES NORTH Boston Spa, Wetherby West Yorkshire, LS23 7BQ www.bl.uk The following have been excluded from this digital copy at the request of the university: Fig 12 on page 24 Fig 16 on page 61 Fig 24 on page 162 Fig 25 on page 163 Fig 26 on page 164 Fig 28 on page 168 Fig 30on page 170 Fig 31 on page 173 Abstract Recent studies of Roman funerary practices have demonstrated that these activities were a vital component of urban social and religious processes. These investigations have, however, largely privileged the importance of these activities to the upper levels of society. Attempts to examine the responses of the lower classes to death, and its consequent demands for disposal and commemoration, have focused on the activities of freedmen and slaves anxious to establish or maintain their social position. The free poor, living on the edge of subsistence, are often disregarded and believed to have been unceremoniously discarded within anonymous mass graves (puticuli) such as those discovered at Rome by Lanciani in the late nineteenth century. This thesis re-examines the archaeological and historical evidence for the funerary practices of the urban poor in Italy within their appropriate social, legal and religious context. The thesis attempts to demonstrate that the desire for commemoration and the need to provide legitimate burial were strong at all social levels and linked to several factors common to all social strata. -

Distretto Sociale Della Bassa Sabina Ambito Territoriale Ri 2
DISTRETTO SOCIALE DELLA BASSA SABINA AMBITO TERRITORIALE RI 2 Comuni di: Cantalupo in Sabina, Casperia, Collevecchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci Sabino, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone. Ente capofila: COMUNE DI POGGIO MIRTETO prot. n. 9658 del 10 luglio 2017 Deliberazione della Giunta del Comune capofila di Poggio Mirteto n. 74 del 30 maggio 2017 Determinazione del responsabile dell’Ufficio di Piano n. 62 del 7 luglio 2017 AVVISO PUBBLICO per la formazione di due elenchi di accreditamento (short list) di psicologi e sociologi esperti cui conferire incarichi di collaborazione per le attività connesse all’attuazione dei fini istituzionali del Comune di Poggio Mirteto in qualità di capofila del Distretto sociale della Bassa Sabina – Ambito territoriale n. 2 della provincia di Rieti. Articolo 1. Soggetto promotore Comune di Poggio Mirteto in qualità di capofila del Distretto sociale della Bassa Sabina – Ambito Territoriale RI/2, C.F. 00094100575, sede legale: Piazza Martiri della Libertà, 40 02047 Poggio Mirteto - RI Articolo 2. Oggetto dell’avviso pubblico Il Comun di Poggio Mirteto, per lo svolgimento delle attività connesse all’attuazione dei fini istituzionali relativi all’esercizio delle funzioni di Ente capofila del Distretto sociale della Bassa Sabina ambito territoriale RI/2, intende procedere alla formazione di elenchi di professionisti cui conferire eventuali incarichi di collaborazione -

Rieti Seggi Primarie Regionali
ELEZIONI PRIMARIE 1 DICEMBRE 2018 - UBICAZIONE SEGGI PROVINCIA DI RIETI COMUNI SEGGI ELETTORI DI, SEZIONI UBICAZIONE SEGGIO Accumoli NO POSTA - Amatrice NO POSTA , Antrodoco 1 ANTRODOCO - CASTEL S. ANGELO -MICIGLIANO-BORGOVELINO SEDE PD Ascrea NO CASEL DI TORA , Belmonte 1 BELMONTE-TORRICELLA GAZEBO PIAZZA ROMA Borbona NO POSTA - Borgorose 1 BORGOROSE USI CIVICI CORVARO Borgo Velino NO ANTRODOCO , CANTALICE-POGGIO BUSTONE-RIVODUTRI-LABRO-MORRO-COLLI SUL Cantalice 1 VELINO CENTRO SOCIO CULTURALE AMULIO TEMPERANZA Cantalupo NO FORANO - Casaprota NO POGGIO MOIANO 2 OSTERIA NUOVA - Casperia NO FORANO - CASTEL DI TORA-COLLE DI TORA-ROCCA SINIBALDA-ASCREA- PAGANICO- Castel di Tora 1 COLLALTO-COLLEGIOVE-NESPOLO-TURANIA FARMACIA Castel S. Angelo NO ANTRODOCO - Castelnuovo di F. NO POGGIO MOIANO 2 OSTERIA NUOVA , CITTADUCALE 1 CITTADUCALE PIAZZA DEL POPOLO - SEDE PD Cittareale NO POSTA - Collalto NO CASTEL DI TORA , Colle di Tora NO CASTEL DI TORA , Collegiove NO CASTEL DI TORA - Collevecchio NO MAGLIANO , Colli sul Velino NO CANTALICE - Concerviano NO RIETI 1 SEDE PD - COMUNI SEGGI ELETTORI DI, SEZIONI UBICAZIONE SEGGIO Configni NO COTTANELLO - Contigliano 1 CONTIGLIANO - GRECCIO -MONTE S. GIOVANNI SEDE PD - VIA MATTEOTTI Cottanello 1 COTTANELLO - MONTASOLA - CONFIGNI - VACONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA PALOMBARA Fara SABINA 1 1 TALOCCI SEZ 1-2-3-6-7-12 CIRCOLO PD TALOCCI Fara SABINA 2 1 PASSO CORSE SEZ. 4-5-8-9-10-11-13 VIA FRANCESCO SACCO PASSO CORESE Fiamignano 1 FIAMIGNANO-PESCOROCCHIANO-PETRELLA SEDE PRO LOCO Forano 1 FORANO - TORRI-CANTALUPO- SELCI - CASPERIA SEZIONE PD GAVIGNANO Frasso NO POGGIO MOIANO 2 OSTERIA NUOVA , Greccio NO CONTIGLIANO - Labro NO CANTALICE - Leonessa 1 LEONESSA HOTEL LA TORRE - VIALE F. -

Piano Territoriale Provinciale Generale Di Rieti
Provincia di Rieti PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE DI RIETI Progetto di Territorio Sabina (Indicazioni e prescrizioni) ● Sintesi beni puntuali ● Quadro di sintesi ZPS, SIC, Aree Naturali protette, zone a rischio idraulico e di frana 2008 1 prog SABINA Amministrazione Provinciale di Rieti Presidente: dott. Fabio Melilli ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO Assessore: arch. Roberto Giocondi Settore III - Assetto del Territorio Ufficio di Piano Dirigente - dott. Anna Maria Catino Responsabile Ufficio - arch. Tonino Cicconetti Consulenze specialistiche - arch. Gianni Celestini, geom. Alberto Capasso INTEGRAZIONI AL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE DELLA PROVINCIA DI RIETI già redatto dalla Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l'Ingegneria Comitato Scientifico: prof. Sergio Caldaretti, prof. Carlo Cellamare (coordinamento scientifico ed operativo), prof. Enzo Scandurra (responsabile scientifico) Gruppo di lavoro: ing. Giovanni Attili, prof. Sergio Caldaretti, arch. Giordana Castelli, prof. Carlo Cellamare, ing. Alessia Ferretti, prof. Enzo Scandurra RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE INTEGRAZIONI Elaborazione - luglio 2008 1 1 prog SABINA Progetto di territorio SABINA “UNA NUOVA PROSPETTIVA PER L’OLIO DELLA SABINA” Linee guida I mutamenti del territorio, attraverso la “Organizzazione del Processo Progettuale” oltre all’analisi fornita dal presente P.d.T., tengono conto in particolare delle norme di indirizzo e delle prescrizioni (norme prescrittive) individuate nelle NTA. Le “Linee -

Comune Localita' N°Civico Provincia Denominazione Indirizzo Tipologia Impianto Tipo Spazi Attivita'
COMUNE LOCALITA' N°CIVICO PROVINCIA DENOMINAZIONE INDIRIZZO TIPOLOGIA IMPIANTO TIPO SPAZI ATTIVITA' ACCUMOLI snc RI Calcetto SP18A Impianto monovalente all'aperto CALCIO A 5 ACCUMOLI RI Istituto Comprensivo STRADA COMUNALE DA ROCCASALLI AD ACCUMOLI Impianto monovalente al chiuso ATTIVITA' GINNICO MOTORIA ACCUMOLI FONTE DEL CAMPO RI Campo Calcetto SP18A Impianto monovalente all'aperto CALCIO A 5 ACCUMOLI RI Palestra Polivalente STRADA COMUNALE DA ROCCASALLI AD ACCUMOLI Impianto polivalente al chiuso PALLACANESTRO, PALLAVOLO CALCIO A 11, CALCIO A 5, CICLISMO, MOUNTAIN BIKE, GOLF, NUOTO, PALLAVOLO, PERCORSI VITA, PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE, TENNIS, AMATRICE RI Villaggio Sportivo Lo Scoiattolo STRADA STATALE PICENTE Impianto polivalente all'aperto e al chiuso TIRO CON L'ARCO AMATRICE 4 RI Polo Scolastico Verticalizzato VIA SATURNINO MUZI Impianto polivalente al chiuso ATTIVITA' GINNICO MOTORIA, PALLAVOLO AMATRICE RI Campo Tennis Lagozzo STRADA STATALE PICENTE Impianto monovalente all'aperto TENNIS AMATRICE snc RI Campi Calcio Comunali STRADA STATALE PICENTE Impianto monovalente all'aperto CALCIO A 11 AMATRICE RI Campo Tennis Preta PIAZZA DON GIACOMO NAPOLEONE Impianto monovalente all'aperto TENNIS AMATRICE RI Campo Calcio Sant'Angelo SP20 Impianto monovalente all'aperto CALCIO A 11 CALCIO A 5, PALLACANESTRO, PALLAVOLO, AMATRICE snc RI Palazzetto dello Sport STRADA STATALE PICENTE Impianto polivalente al chiuso TENNIS AMATRICE RI Campo Calcio Torrita VIA DELLE FONTANELLE Impianto monovalente all'aperto CALCIO A 5 AMATRICE RI Campo -

Archeologia E Modificazioni Ambientali Lungo Il Corso Del Fiume Velino Archaeology and Environmental Changes Along the Velino River
Mem. Descr. Carta Geol. d’It. XCVi (2014), pp. 169-188, figg. 22 Archeologia e modificazioni ambientali lungo il corso del fiume Velino Archaeology and environmental changes along the Velino river CAMerieri P. (*), MAttioli t. (**) riASSUnto - Gli autori analizzano l’evoluzione del paesaggio 1. - introdUzione della Conca Velina (rieti, lazio, italia centrale) nel periodo compreso tra l’età del bronzo e la romanizzazione. Partendo dalla correlazione dei dati ricavati dai sondaggi geologici e lo scopo di questa relazione è quello di proporre da una nuova lettura topografica e dell’assetto idrogeologico una lettura, in parte già presentata dagli scriventi in oc- dell’area, gli autori sostengono che l’antica linea di riva del casione di recenti incontri di studio ed esposizioni mu- bacino lacustre che occupava la Piana di rieti, il Canale di seali (CAMerieri, 2009a, 2009b; CAMerieri et alii, cds; repasto e l’area di Marmore variò nel corso dell’età del CAMerieri & de SAntiS, 2009; CArAnCini et alii, 2009), bronzo e dell’età del ferro tra le quote 365/367 metri s.l.m. e 375/376 metri s.l.m. influenzando lo sviluppo degli abitati riguardante l’evoluzione dell’ambiente e del paesaggio del perilacustri. Successivamente con la conquista del territorio Bacino di Rieti e dell’area della Cascata delle Marmore nel pe- da parte di MAnio CUrio dentAto si assiste al primo vero riodo compreso tra l’età del bronzo e la romanizzazione, intervento di regimentazione delle acque e bonifica della cioè nel lasso di tempo in cui si registra la prima sistema- piana della Conca di rieti. -
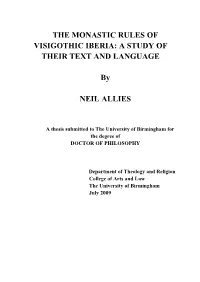
The Monastic Rules of Visigothic Iberia: a Study of Their Text and Language
THE MONASTIC RULES OF VISIGOTHIC IBERIA: A STUDY OF THEIR TEXT AND LANGUAGE By NEIL ALLIES A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Department of Theology and Religion College of Arts and Law The University of Birmingham July 2009 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Abstract This thesis is concerned with the monastic rules that were written in seventh century Iberia and the relationship that existed between them and their intended, contemporary, audience. It aims to investigate this relationship from three distinct, yet related, perspectives: physical, literary and philological. After establishing the historical and historiographical background of the texts, the thesis investigates firstly the presence of a monastic rule as a physical text and its role in a monastery and its relationship with issues of early medieval literacy. It then turns to look at the use of literary techniques and structures in the texts and their relationship with literary culture more generally at the time. Finally, the thesis turns to issues of the language that the monastic rules were written in and the relationship between the spoken and written registers not only of their authors, but also of their audiences. -

Sellers Rieti
RIETI Panorama Loc.tà Casali Tancia, 6 02040 Monte S. Giovanni in Sabina (RI) tel. 0765.333330 fax 0765.333019 Casale Tancia [email protected] www.casaletancia.com L'azienda, situata ad una The agriturism, at 750 altezza di circa 750 metri, è m.s.l., is situated in a valley collocata all'interno di una full of exceptional natural vallata ricca di straordinarie beauties. It is also favoured bellezze naturali, favorita by a good climate for walks anche da un clima ideale and excursions all year per passeggiate e gite in round. The complex has ogni periodo dell'anno. Il been totally restructured complesso è stato comple- and combines perfectly with tamente ristrutturato inte- the natural environment. grandosi perfettamente con The management is a fa- l'ambiente naturale. La con- mily run concern and all the duzione dell'attività è di tipo products are strictly home familiare ed i prodotti sono grown. rigorosamente di produzio- Love and care for each ne propria. L'amore e la cu- small detail make this place ra per ogni piccolo partico- both magically pleasant and lare rende questo posto friendly. magico e accogliente al RIETI tempo stesso. Camere/Bungalow/Appartamenti Accomodation Piazzole camper/roulotte Areas for camper and roulotte Ristorante & bar Distanza da/Distance from Restaurant & bar • Aereoporto/Airport km. Servizi • Treno/Railway km. Services • Autostrada/Motorway km. Sala meeting & congressi Conference & reception rooms Periodo di apertura / Opening time Attività di intrattenimento Enterteinment themes Sala degustazione Linee di Prodotto Tasting room Prodotti tipici Mare del Lazio Typical Products Città d’Arte Network Direttore Ambiente General manager Enogastronomia Congressuale AGRITURISMO/FARM HOLIDAY Vocabolo Palombara snc SP 48 Km 15.500 La Tacita 02040 Roccantica (RI) tel. -

DEATH in ROMAN MARCHE, ITALY: a COMPARATIVE STUDY of BURIAL RITUALS Presented by Antone R.E
DEATH IN ROMAN MARCHE, ITALY: A COMPARATIVE STUDY OF BURIAL RITUALS _______________________________________ A Thesis presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia _______________________________________________________ In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts _____________________________________________________ by ANTONE R.E. PIERUCCI Dr. Kathleen Warner Slane, Thesis Supervisor MAY 2014 The undersigned, appointed by the dean of the Graduate School, have examined the thesis entitled DEATH IN ROMAN MARCHE, ITALY: A COMPARATIVE STUDY OF BURIAL RITUALS presented by Antone R.E. Pierucci, a candidate for the degree of master of arts, and hereby certify that, in their opinion, it is worthy of acceptance. Professor Kathleen Warner Slane Professor Marcus Rautman Professor Carrie Duncan To my parents, for their support over the years. And for their support in the months to come as I languish on their couch eating fruit loops “looking for a job.” ACKNOWLEDGMENTS First and foremost I would like to thank the Department of Art History and Archaeology for the funding that allowed me to grow as a scholar and a professional these last two years; without the support this thesis would not have been possible. Secondly, I would like to thank my thesis Adviser, Dr. Kathleen Warner Slane, for the hours she spent discussing the topic with me and for the advice she provided along the way. The same goes for my committee members Dr. Rautman and Dr. Duncan for their careful reading of the manuscript and subsequent comments that helped produce the final document before you. And, of course, thanks must be given to my fellow graduate students, without whose helping hands and comforting shoulders (and the occasional beer) I would have long since lost touch with reality. -

The Ruin of the Roman Empire
7888888888889 u o u o u o u THE o u Ruin o u OF THE o u Roman o u o u EMPIRE o u o u o u o u jamesj . o’donnell o u o u o u o u o u o u o hjjjjjjjjjjjk This is Ann’s book contents Preface iv Overture 1 part i s theoderic’s world 1. Rome in 500: Looking Backward 47 2. The World That Might Have Been 107 part ii s justinian’s world 3. Being Justinian 177 4. Opportunities Lost 229 5. Wars Worse Than Civil 247 part iii s gregory’s world 6. Learning to Live Again 303 7. Constantinople Deflated: The Debris of Empire 342 8. The Last Consul 364 Epilogue 385 List of Roman Emperors 395 Notes 397 Further Reading 409 Credits and Permissions 411 Index 413 About the Author Other Books by James J. O’ Donnell Credits Cover Copyright About the Publisher preface An American soldier posted in Anbar province during the twilight war over the remains of Saddam’s Mesopotamian kingdom might have been surprised to learn he was defending the westernmost frontiers of the an- cient Persian empire against raiders, smugglers, and worse coming from the eastern reaches of the ancient Roman empire. This painful recycling of history should make him—and us—want to know what unhealable wound, what recurrent pathology, what cause too deep for journalists and politicians to discern draws men and women to their deaths again and again in such a place. The history of Rome, as has often been true in the past, has much to teach us.