Comune Di Riofreddo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Anno Scolastico 2018-19 LAZIO AMBITO 0013
Anno Scolastico 2018-19 LAZIO AMBITO 0013 - ROMA PROVINCIA Elenco Scuole I Grado Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto RMIC89000B IC V TIVOLI BAGNI RMMM89001C ORAZIO - TIVOLI NORMALE PIAZZA B. DELLA QUEVA TIVOLI RMIC8G0006 IC TIVOLI III - VILLA RMMM8G0017 SMS I.C. TIVOLI III NORMALE VIA LIBERTUCCI TIVOLI ADRIANA RMIC892003 I.C TIVOLI IV-VINCENZO RMMM892014 VINCENZO PACIFICI NORMALE VIA DELLA LEONINA TIVOLI RMMM892025 S. GREGORIO DA VIA BORGO PIO SNC SAN PACIFICI SASSOLA GREGORIO DA SASSOLA RMIC89300V IC TIVOLI II - TIVOLI RMMM89301X BACCELLI - TIVOLI NORMALE VIA DEI PINI 19 TIVOLI RMMM893021 SAN POLO DEI VIA I MAGGIO SNC SAN POLO CENTRO CAVALIERI DEI CAVALIERI RMIC8F600E TIVOLI I - TIVOLI CENTRO RMMM8F601G TIVOLI "EMILIO SEGRE'" NORMALE VIA DEL PARCO DI VILLA TIVOLI BRASCHI, 23 RMVC02000V CONVITTO NAZ."A.DI RMMM41900D S.M.S.ANNESSA C.N."A.DI NORMALE PIAZZA GARIBALDI N.1 TIVOLI SAVOIA,DUCA D'AOSTA" SAVOIA" RMIC8BF004 I.C.C.B. CONTE DI RMMM8BF015 C. B. CONTE DI CAVOUR NORMALE VIA PIO LA TORRE, SNC CASTEL CAVOUR MADAMA RMIC897006 DON LORENZO MILANI RMMM897017 DON LORENZO MILANI NORMALE VIA MARCO AURELIO GUIDONIA 02 MONTECELIO RMIC898002 LEONARDO DA VINCI RMMM898013 LEONARDO DA VINCI NORMALE VIA DOUHET GUIDONIA GUIDONIA 6 MONTECELIO RMIC89900T IC ALBERTO RMMM89901V T. MINNITI GUIDONIA NORMALE VIA TRENTO S.N.C. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2019
Ufficio del territorio di ROMA Data: 29/10/2020 Ora: 11.00.29 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2019 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 ALTO ANIENE MONTAGNA NORD OCCIDENTALE DEI LEPINI Comuni di: AFFILE, AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, ARCINAZZO Comuni di: CARPINETO ROMANO, GAVIGNANO, GORGA, ROMANO, ARSOLI, CAMERATA NUOVA, MANDELA, CANTERANO, MONTELANICO, SEGNI CAPRANICA PRENESTINA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CINETO ROMANO, GERANO, JENNE, LICENZA, MARANO EQUO, MONTEFLAVIO, PERCILE, RIOFREDDO, ROCCA CANTERANO, ROCCAGIOVINE, ROCCA SANTO STEFANO, ROIATE, ROVIANO, SAMBUCI, SAN POLO DEI CAVALIERI, SARACINESCO, SUBIACO, VALLEPIETRA, VALLINFREDA, VICOVARO, VIVARO ROMANO COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 5000,00 5000,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 5000,00 5000,00 BOSCO MISTO 4500,00 4500,00 CANNETO 5000,00 CASTAGNETO 17000,00 18000,00 FRUTTETO 27500,00 INCOLTO PRODUTTIVO 1500,00 ORTO 31000,00 29000,00 ORTO IRRIGUO 34000,00 31000,00 PASCOLO 5000,00 4000,00 PASCOLO ARBORATO 5000,00 4000,00 Pagina: 1 di 15 Ufficio del territorio di ROMA Data: 29/10/2020 Ora: 11.00.29 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2019 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 ALTO ANIENE MONTAGNA NORD OCCIDENTALE DEI LEPINI Comuni di: AFFILE, AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, ARCINAZZO Comuni di: CARPINETO ROMANO, GAVIGNANO, GORGA, ROMANO, ARSOLI, CAMERATA NUOVA, MANDELA, CANTERANO, MONTELANICO, SEGNI CAPRANICA PRENESTINA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CINETO ROMANO, GERANO, JENNE, LICENZA, MARANO EQUO, MONTEFLAVIO, PERCILE, RIOFREDDO, ROCCA CANTERANO, ROCCAGIOVINE, ROCCA SANTO STEFANO, ROIATE, ROVIANO, SAMBUCI, SAN POLO DEI CAVALIERI, SARACINESCO, SUBIACO, VALLEPIETRA, VALLINFREDA, VICOVARO, VIVARO ROMANO COLTURA Valore Sup. -

The Long-Term Influence of Pre-Unification Borders in Italy
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna Conference Paper Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long- Term Influence of pre-Unification Borders in Italy 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna (2014) : Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long-Term Influence of pre-Unification Borders in Italy, 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/124400 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. -

This Regulation Shall Be Binding in Its Entirety and Directly Applicable in All Member States
12. 8 . 91 Official Journal of the European Communities No L 223/ 1 I (Acts whose publication is obligatory) COMMISSION REGULATION (EEC) No 2396/91 of 29 July 1991 fixing for the 1990/91 marketing year the yields of olives and olive oil THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Having regard to the Treaty establishing the European Committee for Oils and Fats, Economic Community, Having regard to Council Regulation No 136/66/EEC of 22 September 1966 on the establishment of a common HAS ADOPTED THIS REGULATION : organization of the market in oils and fats ('), as last amended by Regulation (EEC) No 1720/91 (2) ; Article 1 Having regard to Council Regulation (EEC) No 2261 /84 of 17 July 1984 laying down general rules on the granting 1 . For the 1990/91 marketing year, yields of olives and of aid for the production of olive oil and of aid to olive oil olive oil and the relevant production zones shall be as producer organizations (3), as last amended by Regulation specified in Annex I hereto . (EEC) No 3500/90 (4), and in particular Article 19 thereof, 2. The production zones are defined in Annex II . Whereas Article 18 of Regulation (EEC) No 2261 /84 provides that yields of olives and olive oil should be fixed for each homogeneous production zone on the basis of Article 2 information supplied by the producer Member States ; This Regulation shall enter into force on the third day Whereas, in view of the information received, it is appro following its publication in the Official Journal of the priate to fix these yields as specified in Annex I hereto ; European Communities. -
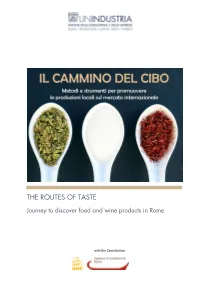
The Routes of Taste
THE ROUTES OF TASTE Journey to discover food and wine products in Rome with the Contribution THE ROUTES OF TASTE Journey to discover food and wine products in Rome with the Contribution The routes of taste ______________________________________ The project “Il Camino del Cibo” was realized with the contribution of the Rome Chamber of Commerce A special thanks for the collaboration to: Hotel Eden Hotel Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel Hotel St. Regis Rome Hotel Hassler This guide was completed in December 2020 The routes of taste Index Introduction 7 Typical traditional food products and quality marks 9 A. Fruit and vegetables, legumes and cereals 10 B. Fish, seafood and derivatives 18 C. Meat and cold cuts 19 D. Dairy products and cheeses 27 E. Fresh pasta, pastry and bakery products 32 F. Olive oil 46 G. Animal products 48 H. Soft drinks, spirits and liqueurs 48 I. Wine 49 Selection of the best traditional food producers 59 Food itineraries and recipes 71 Food itineraries 72 Recipes 78 Glossary 84 Sources 86 with the Contribution The routes of taste The routes of taste - Introduction Introduction Strengthening the ability to promote local production abroad from a system and network point of view can constitute the backbone of a territorial marketing plan that starts from its production potential, involving all the players in the supply chain. It is therefore a question of developing an "ecosystem" made up of hospitality, services, products, experiences, a “unicum” in which the global market can express great interest, increasingly adding to the paradigms of the past the new ones made possible by digitization. -

Elenco Codici Uffici Territoriali Dell'agenzia Delle Entrate
ROMA Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalle: • Direzione Provinciale I di ROMA articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di ROMA 1 - TRASTEVERE , ROMA 2 - AURELIO , ROMA 3 - SETTEBAGNI • Direzione Provinciale II di ROMA articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di ROMA 5 - TUSCOLANO , ROMA 6 - EUR TORRINO , ROMA 7 - ACILIA , POMEZIA • Direzione Provinciale III di ROMA articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di ROMA 4 - COLLATINO , ALBANO LAZIALE , TIVOLI , FRASCATI , PALESTRINA , VELLETRI Direzione Provinciale I di ROMA Sede Comune: ROMA Indirizzo: VIA IPPOLITO NIEVO 36 CAP: 00153 Telefono: 06/583191 Fax: 06/50763637 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] TK2 Municipi di Roma : I, III, XII, XIII, XIV, XV. Comuni : Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Fonte Nuova, Formello, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Mentana, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Trevignano Romano. Comune: ROMA Indirizzo: VIA IPPOLITO NIEVO 36 CAP: 00153 Telefono: 06/583191 Fax: 06/50763636 E-mail: [email protected] TK3 Indirizzo: VIA IPPOLITO NIEVO 36 CAP: 00153 Telefono: 06/583191 Fax: 06/50763635 E-mail: [email protected] TK3 Mappa della Direzione Provinciale I di -

Le Funzioni Operative Dell'agenzia Delle Entrate Sono Svolte Dalle
ROMA Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalle: • Direzione Provinciale I di ROMA articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di ROMA 1 - TRASTEVERE , ROMA 2 - AURELIO , ROMA 3 - SETTEBAGNI • Direzione Provinciale II di ROMA articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di ROMA 5 - TUSCOLANO , ROMA 6 - EUR TORRINO , ROMA 7 - ACILIA , POMEZIA • Direzione Provinciale III di ROMA articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di ROMA 4 - COLLATINO , ALBANO LAZIALE , TIVOLI , FRASCATI , PALESTRINA , VELLETRI Direzione Provinciale I di ROMA Sede Comune: ROMA Indirizzo: VIA IPPOLITO NIEVO 36 CAP: 00153 Telefono: 06/583191 Fax: 06/50763637 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] TK2 Municipi di Roma : I, III, XII, XIII, XIV, XV. Comuni : Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Fonte Nuova, Formello, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Mentana, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Trevignano Romano. Comune: ROMA Indirizzo: VIA IPPOLITO NIEVO 36 CAP: 00153 Telefono: 06/583191 Fax: 06/50763636 E-mail: [email protected] TK3 Indirizzo: VIA IPPOLITO NIEVO 36 CAP: 00153 Telefono: 06/583191 Fax: 06/50763635 E-mail: [email protected] TK3 Mappa della Direzione Provinciale I di -

Locandina Tivoli Rev3
Orari corse MEDANIENE servizio Unione comuni MedAniene sperimentale LINEA CAPOLINEA 1 SOSTA 2 SOSTA 3 SOSTA 4 SOSTA 5 SOSTA 6 SOSTA 7 SOSTA CAPOLINEA LINEA 1 - C.SA N° 1 ANTICOLI CINETO MANDELA Arsoli / Mandela (F.S.) ARSOLI ROVIANO CORRADO ROMANO (P5) SAMBUCI (FS) ORARIO PARTENZA/ARRIVO 06:35 06:45 06:55 07:05 07:09 LINEA 2 - C.SA N° 2 MADONNA C.DA LE C.DA SUBIACO H Arsoli / Subiaco (H) ARSOLI MOLETTE DELLA PACE SELVE VIGNOLE OSPEDALE SUBIACO (P1) ORARIO PARTENZA/ARRIVO 07:05 07:12 07:23 07:28 07:37 07:44 07:52 LINEA 1 - C.SA N° 3 MANDELA CINETO ANTICOLI Arsoli / Mandela (F.S.) SAMBUCI st.ne ROMANO (P5) CORRADO ROVIANO ARSOLI (P2) ORARIO PARTENZA/ARRIVO 07:15 07:18 07:23 07:33 07:44 LINEA 1 - C.SA N° 4 VIVARO Arsoli (H) / Arsoli (H) ARSOLI (P2) RIOFREDDO VALLINFREDA ROMANO ARSOLI (P2) ORARIO PARTENZA/ARRIVO 07:50 07:58 08:06 08:12 08:29 LINEA 2 - C.SA N° 5 SUBIACO H ROVIANO CINETO MANDELA Subiaco (H) / Mandela St.ne OSPEDALE ARSOLI (P3) ROMANO (P5) SAMBUCI st.ne ORARIO PARTENZA/ARRIVO 08:00 08:21 08:23 08:28 08:31 LINEA 2 - C.SA N° 6 MANDELA CINETO ANTICOLI Mandela (F.S.) / Arsoli SAMBUCI st.ne ROMANO (P5) CORRADO ROVIANO ARSOLI ORARIO PARTENZA/ARRIVO 08:50 08:53 09:03 09:13 09:24 LINEA 1 - C.SA N° 7 ANTICOLI CINETO MANDELA Arsoli / Mandela (F.S.) ARSOLI (P2) ROVIANO CORRADO ROMANO (P5) SAMBUCI (FS) ADO/BIV/ROVIANO BIV.)- P5 (CINETO ROMANO BV) ORARIO PARTENZA/ARRIVO 10:00 10:10 10:20 10:30 10:33 LINEA 1 - C.SA N° 8 MANDELA CINETO ANTICOLI Arsoli / Mandela (F.S.) SAMBUCI st.ne ROMANO (P5) CORRADO ROVIANO ARSOLI (P2) ORARIO PARTENZA/ARRIVO -

Tav. 31 Usi Civici
Inquadramento generale FIRENZE Mompeo Torricella in Sabina Casaprota Ascrea AREZZO ANCONA Rocca Sinibalda PISA MARCHE Frasso Sabino Monteleone Sabino SIENA Poggio Nativo MACERATA Toffia Castel di Tora TOSCANA PERUGIA FERMO Poggio Moiano Colle di Tora Ascrea UMBRIA Fara in Sabina Paganico Sabino GROSSETO Toffia TERNI TERAMO Nerola Scandriglia Pozzaglia Sabina Poggio Nativo VITERBO RIETI PESCARA Montorio Romano Turania ABRUZZO Monteflavio Orvinio LAZIO Moricone L'AQUILA CHIETI ROMA LAZIO Vivaro Romano Castel di Tora Percile Vallinfreda Poggio Moiano ISERNIA Palombara Sabina Licenza FROSINONE MOLISE LATINA ABRUZZO Mentana Roccagiovine Cineto Romano Riofreddo Colle di Tora San Polo dei Cavalieri Fara in Sabina CASERTA Mandela CAMPANIA Roviano Arsoli NAPOLI Marcellina Vicovaro Anticoli Corrado Guidonia Montecelio Saracinesco Sambuci Tivoli Agosta Castel Madama Tivoli Ciciliano Ascrea Base cartografica: IGM scala 1:25.000 Scala 1 : 25 000 Proiezione: UTM 33N - Datum: ED1950 Km 0 0,5 1 2 Legenda Nerola AL1im0it_e Cdeol Pnafirncoe N_aPtuararlec oR_egLiouncarlee dteilii Monti Lucretili CCoonmfinui ncoi_mLunaazliio_ED50_utm33 Usi Civici di cui è stato possibile reperire dati ufficiali tramite URseig_iocniev Licazi io ed Uffici comunali Usi Civici di cui non è stato possibile reperire dati ufficiali. UI dSaIt_i sConIoV sItCatIi _rePpeUritBi dBa LpIuCbbAlicZazIOionNi dEi A_AB.VEVN. EDETTI_PNRML Value Scandriglia Pozzaglia Sabina High : 255 Low : 0 Montelibretti Montorio Romano Orvinio Moricone Vivaro Romano Monteflavio Vallinfreda Percile Licenza -

CV Gizzi Carlo.Pdf
Carlo Gizzi Curriculum artistico-professionale Carlo Gizzi, insegnante, chitarrista, interprete, compositore, direttore, autore di metodi e sussidi, nato a Subiaco (RM) il 30.01.1958, in possesso del Diploma di Maturità Classica ottenuto nel 1977, si è diplomato in Chitarra nel 1988 presso il Conservatorio di Musica “A. Casella” (L'Aquila). Ha avuto incarichi di docenza in corsi di aggiornamento musicale per insegnanti: A.S. 1999/00 Guidonia I (RM) - tre ore 10.05.00 Guidonia I (RM) - tre ore 17.05.00 Convitto Tivoli (RM) - tre ore 20.06.00 A.S. 2001/02 Palestrina II (RM) - tre ore 19.04.02 Palestrina II (RM) - tre ore 03.05.02 A.S. 2002/03 Palestrina II (RM) - due ore 15.01.03 Palestrina II (RM) - due ore 29.01.03 Palestrina II (RM) - due ore 05.02.03 Palestrina II (RM) - due ore 19.02.03 Palestrina II (RM) - due ore 05.03.03 Palestrina II (RM) - due ore 19.03.03 Palestrina II (RM) - due ore 02.04.03 Palestrina II (RM) - due ore 16.04.03 Palestrina II (RM) - due ore 07.05.03 Palestrina II (RM) - due ore 21.05.03 A.S. 2003/04 Palestrina II (RM) - due ore 05.11.03 Palestrina II (RM) - due ore 12.11.03 Palestrina II (RM) - due ore 19.11.03 Palestrina II (RM) - due ore 26.11.03 Palestrina II (RM) - due ore 03.12.03 Palestrina II (RM) - due ore 10.12.03 Palestrina II (RM) - due ore 07.01.04 Palestrina II (RM) - due ore 14.01.04 Palestrina II (RM) - due ore 21.01.04 Palestrina II (RM) - due ore 28.01.04 Ha insegnato Educazione Musicale e Chitarra nelle scuole medie: A.S. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2018
Allegato a AGE.AGEDC001.REGISTRO INTERNO.0002492.17-02-2020-R Ufficio del territorio di ROMA Data: 11/02/2020 Ora: 14.35.29 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2018 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 ALTO ANIENE MONTAGNA NORD OCCIDENTALE DEI LEPINI Comuni di: AFFILE, AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, ARCINAZZO Comuni di: CARPINETO ROMANO, GAVIGNANO, GORGA, ROMANO, ARSOLI, CAMERATA NUOVA, MANDELA, CANTERANO, MONTELANICO, SEGNI CAPRANICA PRENESTINA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CINETO ROMANO, GERANO, JENNE, LICENZA, MARANO EQUO, MONTEFLAVIO, PERCILE, RIOFREDDO, ROCCA CANTERANO, ROCCAGIOVINE, ROCCA SANTO STEFANO, ROIATE, ROVIANO, SAMBUCI, SAN POLO DEI CAVALIERI, SARACINESCO, SUBIACO, VALLEPIETRA, VALLINFREDA, VICOVARO, VIVARO ROMANO COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 7000,00 7000,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 7000,00 7000,00 BOSCO MISTO 6000,00 6000,00 CANNETO 6000,00 CASTAGNETO 17000,00 18000,00 FRUTTETO 27500,00 INCOLTO PRODUTTIVO 2000,00 ORTO 31200,00 29000,00 ORTO IRRIGUO 34200,00 31200,00 PASCOLO 6000,00 5000,00 PASCOLO ARBORATO 6000,00 5000,00 Pagina: 1 di 15 Ufficio del territorio di ROMA Data: 11/02/2020 Ora: 14.35.29 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2018 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA -

Consulte Territoriali Ordine Consulenti Del Lavoro Di Roma Consulta Rappresentanti Municipi Roma Di Competenza Comuni Di Competenza
Consulte Territoriali Ordine Consulenti del Lavoro di Roma Consulta Rappresentanti Municipi Roma di competenza Comuni di competenza Civitavecchia, Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale I° Quadrante (ovest) Foschi Stefano (Presidente) I,XI,XII,XIII,XIV Monterano, Cerveteri, Fiumicino Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano Fiano Romano, Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Filacciano, onte Nuova, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Mentana , Monteflavio, II° Quadrante (nord) Germani Mariarita (Presidente) II,III,IV,XV Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina Tivoli, Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Colonna, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Gerano, Guidonia Montecelio, Gorga, Jenne, Labico, Licenza, Mandela, III°Quadrante (est) Magrini Enzo (Presidente) V,VI, VII Marano Equo, Marcellina, Montelanico, Olevano Romano, Palestrina, Percile, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roccagiovine, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Sambuci, San Cesareo, San Vito Romano, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, Valmontone, Zagarolo Pomezia, Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Colleferro, Frascati, Genzano di Roma,Grottaferrata, Lanuvio, IV°Quadrante (sud) Adriani Ruggiero (Presidente) VIII,IX,X Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Nettuno, Rocca di Papa, Rocca Priora, Segni, Velletri.