Vicenza Vicenza
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

HIAVALUTAZIONE DI IMPATTO SUL PATRIMONIO (Heritage Impact Assessment
VALUTAZIONE DI IMPATTO SUL PATRIMONIO (Heritage Impact Assessment - HIA) SITO PATRIMONIO MONDIALE “LA CITTÀ DI VICENZA E LE VILLE DEL PALLADIO HIA NEL VENETO” INDICE _____________________________________________________________________________________________________ 1. INTRODUZIONE _____________________________________________________________________________________________________ 2. APPROCCIO METODOLOGICO DELL’HERITAGE IMPACT ASSESSMENT 2.1. ECCEZIONALE VALORE UNIVERSALE DEL PATRIMONIO MONDIALE 2.2. METODOLOGIA HERITAGE IMPACT ASSESSMENT 2.3. FONTI DEI DATI _____________________________________________________________________________________________________ 3. VICENZA, STORIA E SVILUPPO 3.1. ANDREA PALLADIO E IL PAESAGGIO STORICO URBANO DI VICENZA 3.2. LE VILLE DEL PALLADIO E IL PAESAGGIO RURALE _____________________________________________________________________________________________________ 4. LA PROPRIETA DEL PATRIMONIO MONDIALE 4.1. LA PROPRIETÀ 4.2. ECCEZIONALE VALORE UNIVERSALE 4.3. TUTELA E GESTIONE 4.4.1. Leggi di tutela 4.4.2. Pianifi cazione territoriale e urbanisti ca 4.4.2.1. Nazionale 4.4.2.2. Regionale 4.4.2.3. Locale 4.4.3. Conservazione del patrimonio culturale e paesaggisti co 4.4.4. Tutela ambientale 4.4.5. Piano di Gesti one del Sito _____________________________________________________________________________________________________ 5. PROGETTI DI TRASFORMAZIONE 5.1. INTRODUZIONE 5.2. PROGETTI DI TRASFORMAZIONE 5.2.1. Insediamento militare Usa Setaf ‘Del Din’ e parco della pace 5.2.2. Insediamento di desti nazioni miste nell’area dell’ex Cotonifi cio Cotorossi 5.2.3. Progett o della linea ferroviaria AC di collegamento Milano-Venezia 5.2.4. Tangenziali di Vicenza 5.2.5. Progett o di riqualifi cazione dell’ex complesso ‘San Biagio’ 5.2.6. Previsione urbanisiti che del PI in prossimità di Villa Trissino Cricoli 5.3. PREVISIONI DI TRASFORMAZIONI _____________________________________________________________________________________________________ 6. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SULL’ ECCEZIONALE VALORE UNIVERSALE 6.1. -

Dal Centro Di Vicenza Al Lago Di Fimon
Passeggiandoinbicicletta.it In bicicletta dal Centro di Vicenza al Lago di Fimon Da vedere: VICENZA Il toponimo della bellissima Vicenza ha delle origini un po’ incerte: sembra e che il primo nome dato dai veneti alla città sia stato Berga, nome totalmente variato dai romani che la chiamarono Vicetia o Vincentia o Vicentia (forse dal nome della tribù che venne a colonizzarne il territorio). Vicenza è senza dubbio una fra le più antiche città del Veneto anche se la sua storia precedente la dominazione romana è poco nota; è possibile attribuire la sua fondazione agli Euganei molto prima che Roma conquistasse il Veneto (177-178 a.C.). Dopo gli Euganei vi furono i Paleoveneti e poi ancora i Galli che dominarono il territorio fino al 157 a.C., anno in cui subentrarono i Romani. Durante l'impero romano la città divenne ricca e prosperosa; alle bellezze naturali del luogo in cui sorgeva si aggiunsero bellezze artistiche: sono arrivati sino a noi i resti del teatro Berga, degli acquedotti ,della via Postumia, a dimostrazione della ricchezza della Vicenza romana (che fu anche sede temporanea dell'imperatore Teodosio). Dopo la caduta dell’impero e la successiva calata in Italia dei Barbari anche questa città conobbe la guerra e la distruzione e ritornò a fiorire solo con la venuta degli Ostrogoti e di Teodorico il Grande (493-526). Pace e tranquillità purtroppo non durarono a lungo: i Bizantini, infatti, conquistarono l’ Italia e solo dopo pochi anni i Longobardi conquistarono Vicenza, per essere poi soppiantati dai Franchi. Nel periodo vescovile (precedentemente all'era dei Comuni) Vicenza si risollevò perché i suoi vescovi lavorarono per tener lontane le varie famiglie feudali che la attorniavano: i signori di Marostica, di San Bonifacio, di Bassano ma dovette cedere di fronte ai signori più potenti: gli Ezzelini prima, i Carraresi, gli Scaligeri e i Visconti poi, sino a quando, nel 1404, la città si diede spontaneamente alla Repubblica di Venezia. -

La Città Di Vicenza E Le Ville Del Palladio Nel Veneto
La presente pubblicazione è stata realizzata con la collaborazione Vicenza con le sue 26 opere palladiane, 23 monumenti del centro storico e 3 ville Un progetto editoriale dei seguenti Enti: suburbane, è entrata a pieno titolo nel 1994 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Ufficio Unesco dell’Umanità. I monumenti palladiani hanno conferito alla realtà urbana nel suo complesso Comune di Vicenza Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto una singolare unicità, in forza della loro emergenza architettonica e in virtù delle Soprintendenze per i beni storici, artistici ed etnoantropologici relazioni che intercorrono tra tali opere e il loro intorno costruito. del Veneto Nel 1996 il riconoscimento dell’UNESCO è stato esteso ad altre 21 ville di Andrea Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici del Veneto Palladio sparse nel territorio veneto. NEL VENETO DI VICENZA E LE VILLE DEL PALLADIO LA CITTA’ Regione del Le relazioni di dialogo tra i monumenti palladiani e il paesaggio veneto costituiscono Veneto un dato forte ed emergente, la cui esemplarità assume titolo di valore universale. L’influenza dell’opera palladiana ha, infatti, determinato per i secoli successivi un riferimento irrinunciabile per l’architettura di tutto il mondo. Le ville venete costituiscono un patrimonio che nel suo insieme è testimonianza altissima di una civiltà e di una cultura – non solo ovviamente artistica e architettonica – da proteggere, da conservare, da valorizzare. Testi, fotografie, ricerca iconografica, Provincia di Provincia -

INTRODUCTION Hospital
INTRODUCTION Hospital Pratical Tips INTRODUCTION CONTENTS WELCOME A brief introduction to USAG Italy 01 | and Family and MWR. VICENZA FACILITIES Information about on-post 02-21 | facilities and services in Vicenza. VICENZA POST MAPS General maps of posts in Vicenza FACILITY INFORMATION 22-23 | with MWR facilities highlighted. A snapshot of everything Family 04 | and MWR offers in USAG Italy. ALL THINGS TRAVEL Information on licenses, traveling, 24-25 | passports and more. FURRY FRIENDS A glimpse of useful information 27 | and tidbits for pet owners. ITALIAN INFO USEFUL INFORMATION Helpful Italian words and phrases Find out helpful information about 28-29 | and local information/traditions. 24 | the community and more! CITIES, MAPS & MORE Get inspired to travel outside the 30-57 | gate with these guides and maps. DARBY FACILITIES Information about on-post 58-63 | facilities and services in Darby. DARBY ON-POST MAP CITY GUIDES A general map of Darby with See a snapshot of cities and places 59 | MWR facilities highlighted. 30 | in and around USAG Italy. Cover Image: Verona, Italy “Go To Guide” designed by: Family and MWR Marketing (Richard Gerke, Beatrice Giometto, Alyssa Olson) Advertising Disclaimer: No federal, DoD or Army endorsement is implied. Interested in advertising with us? Contact Family and MWR Marketing at 0444-61-7992 or at 338-726-4361. INTRODUCTION WELCOME! A WORD FROM USAG ITALY FAMILY AND MWR Welcome to U.S. Army Garrison Italy! USAG Italy is a community of service members, civilians, family members, and Italian military and civilian employees. These Army locations cover a broad region south of the Alps that include: Caserma Ederle, Caserma Del Din and satellite locations around Vicenza, as well as Camp Darby, located in Livorno on Italy’s western coast. -

Palladiano Nerario Immaginata L’Iti Ascoprire Accompagnare Vogliamo Piccola Vi Con Questa Guida Genio Dell’Architettura
le nostre guide e i siti www.discoverpalladio.org e www.vicenzae.org. e www.discoverpalladio.org siti i e guide nostre le www.palladio2008.info – www.cisapalladio.org – www.palladio2008.info www.vicenzae.org – www.vicenzabooking.com – www.vicenzae.org cenza, invitandovi a scoprire quindi l’itinerario delle ville attraverso attraverso ville delle l’itinerario quindi scoprire a invitandovi cenza, icenza V Camera di Commercio di Camera e.mail: [email protected] e.mail: - Vi di storico centro del immaginata nell’armonia palladiano nerario - l’iti scoprire a accompagnare vogliamo vi guida piccola questa Con ville della provincia, tutti attribuite al genio dell’architettura. dell’architettura. genio al attribuite tutti provincia, della ville del Patrimonio Mondiale 23 monumenti del suo centro storico e 16 16 e storico centro suo del monumenti 23 Mondiale Patrimonio del mente riconosciuta come la città del Palladio iscrivendo nella Lista Lista nella iscrivendo Palladio del città la come riconosciuta mente - universal è l’Unesco, decretato ha come Vicenza, certa: è cosa Una mitologico, comunque sovrannaturale. comunque mitologico, ad affidargli il nome di Palladio, fosse un angelo o un personaggio personaggio un o angelo un fosse Palladio, di nome il affidargli ad Ideazione e testi a cura di Vicenza è sicuramente ragione Gian Giorgio Trissino, il suo grande mentore, mentore, grande suo il Trissino, Giorgio Gian ragione sicuramente DI VICENZA DI PROVINCIA il luogo della morte e perfino il luogo della sua sepoltura. Ha avuto avuto Ha sepoltura. sua della luogo il perfino e morte della luogo il la residenza coniugale di Vicenza, i lineamenti del volto, le cause e e cause le volto, del lineamenti i Vicenza, di coniugale residenza la i natali. -

St. Mark's Basilica
W DISCOVER WITH US E OUR BEAUTIFUL TERRITORY. L O CLICK ON THE SHOTS AND GET V READY FOR THE VIRTUAL E JOURNEY WE HAVE CREATED V FOR YOU ! E N E T WE ARE HERE O A work by 3A and 3C ARENA OF VERONA In the first century A.C. under the empire of Augustus, the amphitheater hosted games, shows and gladiatorial fights. They were bloody spectacles, which our modern sensibility struggles to conceive, but which at the time fascinated the crowds. Curiosity: there is a legend about the construction of the Arena. A gentleman from Verona, condemned to death, proposed to the lords of the city to build in one night an immense building to show that contained all people of Verona, to have his life saved in return. La Traviata is an opera in three acts by Giuseppe Verdi created by a libretto of Francesco Maria Piave. It is based on The Lady of the Camelias, a play by Alexandre Dumas. It is considered as a part of a so-called "popular trilogy" by Verdi, together with Il trovatore and Rigoletto. Since 2002 ''l'opera regina'' of the Arena di Verona is Aida, conceived by the genius of Franco Zeffirelli. It recreates ancient Egypt in a scenic stage dominated by a large golden pyramid and embellished with beautiful costumes. SINGERS IN ARENA IL VOLO TIZIANO FERRO GIANNI MORANDI ADELE LAURA PAUSINI ONE OF THE WONDERS OF ITALY: THE GARDA LAKE The GARDA LAKE is the destination of many foreign tourists and it is the tourist area with the highest concentration of amusement parks in Italy. -

L'archivio Di Giangiorgio Zorzi Alla Biblioteca Bertoliana Di Vicenza
Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico Tesi di Laurea L’archivio di Giangiorgio Zorzi alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza Relatore Ch.ma Prof.ssa Dorit Raines Laureando Maria Ceresa Matricola 988351 Anno Accademico 2015 / 2016 Sommario Introduzione p.1 1. Nota biografica su Giangiorgio Zorzi p.3 2. Le carte Zorzi p.13 3. Struttura generale dell’archivio p.23 4. Inventario p.25 5. Indici p.169 Appendici a. Intervista a Fulvia Zorzi Giustiniani p.183 b. Titoli e onorificenze di Giangiorgio Zorzi p.187 c. Pubblicazioni e Istituti con i quali Giangiorgio Zorzi ha collaborato p.189 d. Corrispondenti di Giangiorgio Zorzi (1908-1969) p.191 e. Lettera di Giangiorgio Zorzi all’Accademia Olimpica (11 ottobre 1949) p.197 Bibliografia p.199 Introduzione Giangiorgio Zorzi, avvocato, letterato, archivista e paleografo, divenne nel corso del Novecento un punto di riferimento per gli studiosi di storia dell’arte moderna, in particolare vicentina. Studioso originale e prolifico, è ricordato per il suo enorme corpus di pubblicazioni palladiane, e fu tra i promotori del Centro Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio”. Il fondo archivistico, prodotto in sessant’anni di studi e pubblicazioni, venne donato alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza dalle figlie di Zorzi; esso testimonia il suo peculiare metodo di lavoro, il quale prevedeva un approccio alla ricerca che partisse sempre dalla raccolta di documenti e dati originali, al fine di ricostruire i lavori di Palladio prima di tutto secondo la veridicità storica, tenendo sempre conto del contesto culturale nel quale un dato progetto veniva realizzandosi. -

La Città Di Vicenza E Le Ville Del Palladio Nel Veneto
La presente pubblicazione è stata realizzata con la collaborazione Vicenza con le sue 26 opere palladiane, 23 monumenti del centro storico e 3 ville Un progetto editoriale dei seguenti Enti: suburbane, è entrata a pieno titolo nel 1994 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Ufficio Unesco dell’Umanità. I monumenti palladiani hanno conferito alla realtà urbana nel suo complesso Comune di Vicenza Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto una singolare unicità, in forza della loro emergenza architettonica e in virtù delle Soprintendenze per i beni storici, artistici ed etnoantropologici relazioni che intercorrono tra tali opere e il loro intorno costruito. del Veneto Nel 1996 il riconoscimento dell’UNESCO è stato esteso ad altre 21 ville di Andrea Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici del Veneto Palladio sparse nel territorio veneto. NEL VENETO DI VICENZA E LE VILLE DEL PALLADIO LA CITTA’ Regione del Le relazioni di dialogo tra i monumenti palladiani e il paesaggio veneto costituiscono Veneto un dato forte ed emergente, la cui esemplarità assume titolo di valore universale. L’influenza dell’opera palladiana ha, infatti, determinato per i secoli successivi un riferimento irrinunciabile per l’architettura di tutto il mondo. Le ville venete costituiscono un patrimonio che nel suo insieme è testimonianza altissima di una civiltà e di una cultura – non solo ovviamente artistica e architettonica – da proteggere, da conservare, da valorizzare. Testi, fotografie, ricerca iconografica, Provincia di Provincia -
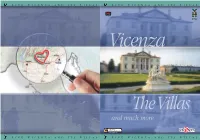
And Much More
L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS ENGLISH PROVINCIA DI VICENZA Vicenza TheVillas and much more L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS Vicenza... The Villas and much more This small structured guide to routes aims to be an instrument of easy consultation for those wishing to discover the Vicentine villas, combining their visit with the other offers of the rich territory: from museums to wine roads, from castles to typical productions. Here below you will not merely fi nd a list of villas since those which most represent the defi nition of tourist interest have been carefully selected. Every route is subdivided into two sections: “the villas” and “much more”, in order to indicate that besides the villas there are other attractions for the visitor. The villas in the fi rst section are generally usable, from the point of view of opening and accessibility to the visitor. 1 itinerary_1 Pedemontana Vicentina and High Vicentino itinerary_1 Pedemontana Vicentina and High Vicentino Romano d'Ezzelino Pove del Grappa Mussolente 12 BASSANO The Villas DEL GRAPPA Santorso Lonedo MAROSTICA Zugliano 11 7 2 - VillaRosà Ghellini, Villaverla Description 6 10 Nove SCHIO BREGANZE CartiglianoBegun in 1664 designed by Pizzocaro, the works were in- 1 CALDOGNO - VILLA CALDOGNO Sarcedo 14 terrupted in 1679, date engraved in two places of the main 2 VILLAVERLA - VILLA GHELLINI THIENE 13 3 VILLAVERLA - VILLA VERLATO PUTIN 8 9 façade, and never restarted because of the death of the archi- 4 MOLINA DI MALO - VILLA PORTO THIENE 4 15 Longa tect. -

Paolo Veroneses Art of Business
Paolo Veronese’s Art of Business: Painting, Investment, and the Studio as Social Nexus Author(s): John Garton Reviewed work(s): Source: Renaissance Quarterly, Vol. 65, No. 3 (Fall 2012), pp. 753-808 Published by: The University of Chicago Press on behalf of the Renaissance Society of America Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1086/668301 . Accessed: 02/10/2012 14:40 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. The University of Chicago Press and Renaissance Society of America are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Renaissance Quarterly. http://www.jstor.org Paolo Veronese’s Art of Business: Painting, Investment, and the Studio as Social Nexus* by J OHN G ARTON Despite the prominent career of Paolo (Caliari) Veronese (1528 –88), much remains to be discovered about his patrons and peers. Several letters written by the artist are presented here for the first time, and their recipient is identified as the humanist Marcantonio Gandino. The letters reference artworks, visitors to Veronese’s studio, and economic data pertaining to the painter. Analyzing the correspondence from a variety of methodological viewpoints reveals how Veronese fulfilled commissions, interacted with nobility, and invested his painterly profits in land on the Venetian terraferma. -

Private Palaces, Villas, and Gardens of Venice and the Veneto
Private Palaces, Villas, and Gardens of Venice and the Veneto Sponsored by Institute of Classical Architecture & Art ƒ Arranged by Pamela Huntington Darling, Exclusive Cultural Travel Programs Sunday, October 9 to Sunday, October 16, 2011 7 days and 7 nights Fascinating Venice and Veneto, priding a rich heritage of art, architecture, and décor, are ultimately unique. Beyond the usual tourist ventures, there is a secret Venice and Veneto, known to Venetians of nobility and the privileged few. As a participant of this exclusive program, you will have the opportunity to join an intimate group of discerning travelers and be invited by members of the esteemed cultural and social world of the Veneto and Venice to private visits, luncheons, cocktail receptions, and dinners in magnificent villas and palazzi of Venetian nobility, rarely opened to outside visitors, accompanied by a historian of the Venetian community. Following the 500th anniversary of the birth of the great Italian classical architect Andrea Palladio, we will enjoy seven days of private visits and receptions in the most important Palladian villas in the Veneto and in palazzi in Venice, with their proprietors, specially organized for you. We will observe the development of Venetian art, décor and architecture through its beginnings to the emergence of the Renaissance and the peak of Venetian heritage in the 16th and the 18th centuries. Countess Giuliana di Thiene, expert lecturer and member of Venetian nobility, will guide us throughout this unique cultural travel program to the Veneto region and to Venice. For the first three nights, we will stay in the picturesque, medieval town of Asolo, “city of a thousand landscapes”, set on gentle hills that inspired Titian and Giorgione, offering stunning views of the countryside. -

In Honor of Italy's 150Th Anniversary As a Country, Watch!
THE ITALIANIn honor of Italy’s 150th anniversary as a country, Watch! editors and CBS stars share their favorite places and raise their glasses to one of the O most bellissima places J B on the planet 86 AUGUST 2011 / WATCH! FdCW0811_086-092_SCR_Italian_V4.indd 86 6/29/11 8:58 AM ITALY ISN’T CALLED BEL PAESE— “the beautiful country”—for nothing. From renowned art and mouthwa- tering food to fast cars and outrageous fashion, Italy offers something for casual tourists and savvy world travelers alike. In honor of Italy’s 150th anniversary we dispatched three different writers to three different regions—Lombardy, the most populous and richest region in the country; Veneto, which boasts 60 million tourists a year; and Piedmont, which is 43 percent mountainous and nearly surrounded by the Alps—to uncover their favorite hotels, restaurants and, of course, adventures. And we asked one of our favorite CBS stars, Neil Patrick Harris of How I Met Your Mother, to share some highlights from his Watch! cover shoot in Rome and Venice. WATCH! / AUGUST 2011 87 FdCW0811_086-092_SCR_Italian_V4.indd 87 6/29/11 8:58 AM The Travel Issue Scaligero Castle, below left, is one of the best-preserved castles in Italy, while both the casks and vineyards at Bella Vista winery, below right, are sights to behold, too. GRAND PRIXFrom fast rides to fabulous food, here’s what makes LOMBARDY so unique By Mona Buehler BRESCIA ou’re in a cute 1930s Aston Martin, to begin the legendary drive south. Learn zipping through stone villages surrounded about Mille Miglia history from owners by glacial lakes, snow-capped mountains Maurella Musatti and Chiara Morandini yand hillsides fl ecked with olive groves and over homemade casonsèi at Trattoria lemon trees.