Fiume Cecina Da Berignone a Ponteginori “ 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Val Di Cecina
piano paesaggistico scheda d’ambito logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito ambito 13 val di cecina Comuni di: Bibbona (LI), Casale Marittimo (PI), Castagneto Carducci (LI), Castellina Marittima (PI), Castelnuovo di Val di Cecina (PI), Cecina (LI), Guardistallo (PI), Montecatini Val di Cecina (PI), Montescudaio (PI), Monteverdi Marittimo (PI), Pomarance (PI), Radicondoli (SI), Ripabella (PI), Volterra (PI) profilo dell’ambito 1. descrizione interpretativa 2. invarianti strutturali 3. interpretazione di sintesi 4. disciplina d’uso 5. informazioni relative al piano piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito val di cecina Montecatini Val di Cecina Bibbona Saline Volterra Cecina Pomarance Donoratico Castelnuovo Val di Cecina Bolgheri Monteverdi marittimo Castagnateto Carducci Profilo dell’ambito 1 p. 3 val di cecina Profilo dell’ambito p. 4 piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito val di cecina Il paesaggio costiero dell’ambito Val di Cecina è caratterizzato dall’incedere regolare delle forme, dal mare alle colline. La profonda fascia di “Costa a dune e cordoni” so- stiene una testimonianza, ben conservata, delle pinete litoranee. Immediatamente alle spalle, la fascia di Depressioni retrodunali, storiche ‘Maremme’, oggi in gran parte bonificate, ma ancora ospitanti l’eccellenza del Padule di Bolgheri. L’ambiente costiero è tuttavia caratterizzato dalla considerevole espansione edilizia legata al turismo balneare che, concen- trandosi dapprima nei centri sub-costieri di Cecina e Donoratico e nelle Marine, è poi diventato un fenomeno esteso nella forma di villaggi turistici e di campeggi. I centri urbani situati in posizione collinare a ridosso della pianura costiera hanno subito crescite contenute mantenendo il loro carattere di borghi, ma hanno perso importanza rispetto ai nuovi centri sviluppatisi sulla costa. -

Allo Stato Attuale, Delle 121 Centrali Previste, 32
Data prevista per la Data prevista dall'operatore Provincia Comune Località Nome Sede fine dei lavori per l'attivazione del servizio Arezzo Cavriglia CAVRIGLIA CAVRIGLIA 30/10/2013 giugno 2014 Arezzo Pian di Sco FAELLA FAELLA 30/10/2013 giugno 2014 Arezzo Pian di Sco PIAN DI SCO' PIAN DI SCO 30/10/2013 giugno 2014 Firenze Barberino Val d'Elsa MARCIALLA MARCIALLA connessa giugno 2014 Firenze Barberino Val d'Elsa VICO D'ELSA VICO D'ELSA connessa giugno 2014 Firenze Borgo San Lorenzo GREZZANO GREZZANO (FI) connessa giugno 2014 Firenze Borgo San Lorenzo LUCO DI MUGELLO LUCO DI MUGELLO connessa giugno 2013 Firenze Borgo San Lorenzo PANICAGLIA PANICAGLIA connessa giugno 2014 Firenze Cerreto Guidi Lazzeretto LAZZERETTO 2 connessa attivata Firenze Cerreto Guidi Stabbia STABBIA connessa attivata Firenze Certaldo FIANO FIANO (EMP) 30/11/2013 giugno 2014 Firenze Fucecchio Torre TORRE (EMP) connessa dicembre 2013 Firenze Greve in Chianti PASSO DEI PECORAI PASSO DEI PECORAI 30/06/2013 dicembre 2013 Firenze Impruneta Falciani FALCIANI 30/07/2013 giugno 2014 Firenze Impruneta POZZOLATICO POZZOLATICO 31/12/2013 giugno 2014 Firenze Montespertoli POPPIANO POPPIANO connessa giugno 2014 Firenze Pontassieve Pontassieve DOCCIA (FI) UTENTE connessa giugno 2014 Firenze Pontassieve S.BRIGIDA S. BRIGIDA (FI) 30/07/2013 dicembre 2013 Firenze Rignano sull'Arno BOMBONE BOMBONE connessa giugno 2014 Firenze San Casciano in Val di Pesa LA ROMOLA LA ROMOLA connessa giugno 2014 Firenze San Casciano in Val di Pesa MERCATALE V.P. MERCATALE connessa giugno 2013 Firenze San Casciano in Val di Pesa MONTEFIRIDOLFI MONTEFIRIDOLFI connessa giugno 2014 Firenze San Casciano in Val di Pesa S.PANCRAZIO S. -

BA022S Elenco Località Disagiate Aggiornato Al 10/12/2019 7:14:00 Pag
BA022S Elenco Località Disagiate Aggiornato al 10/12/2019 7:14:00 Pag. 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ABATEMARCO SA-2 ABAZIA DI SULMONA AQ-2 ABBADIA DI FIASTRA MC-2 ABBADIA DI MONTEPULCIANO SI-2 ABBADIA DI NARO PS-2 ABBADIA DI NARO PU-2 ABBADIA SAN SALVATORE SI-2 ABBATEGGIO PE-2 ABBAZIA DI MASIO AL-2 ABBIADIA DI MONTEPULCIANO SI-2 ABETINA VALLESANA SO-2 ABETONE PT-2 ABRIOLA PZ-2 ABTEI BZ-2 ACCADIA FG-2 ACCETTURA MT-2 ACCIAIOLO PI-2 ACCIANO AQ-2 ACCIAROLI SA-2 ACCUMOLI RI-2 ACERETO BZ-2 ACERNO SA-2 ACONE S. EUSTACHIO FI-2 ACQUABONA BL-2 ACQUACALDA ME-3 ACQUACANINA MC-2 ACQUAFONDATA FR-2 ACQUAFREDDA SV-2 ACQUALAGNA PS-2 ACQUALAGNA PU-2 ACQUAPARTITA FO-2 ACQUAPENDENTE VT-2 ACQUARA NA-2 ACQUARIA MO-2 ACQUARO VV-2 ACQUASANTA TERME AP-2 ACQUASANTA TERME AP-2 ACQUASERIA CO-2 ACQUAVELLA SA-2 ACQUAVENA SA-2 ACQUAVIVA SA-2 ACQUAVIVA SI-2 ACQUAVIVA SM-2 ACQUAVIVA D'ISERNIA IS-2 ACQUEDOLCI ME-2 ACRI CS-2 ACUTO FR-2 ADAMI CZ-2 ADRARA SAN MARTINO BG-2 ADRARA SAN ROCCO BG-2 AFERS BZ-2 AFFILE RM-2 AGAZZANO PC-2 AGEROLA NA-2 AGGIUS OT-2 AGIRA EN-2 AGLIANO AT-2 AGLIENTU OT-2 AGNANA RC-2 AGNANA CALABRA RC-2 AGNONE IS-2 AGNONE CILENTO SA-2 AGNOSINE BS-2 AGORDO BL-2 AGRA VA-2 AGRANO NO-2 AGRIANO PG-2 AHORNACH BZ-2 AHRNTAL BZ-2 AICA DI FIE' BZ-2 AIDONE EN-2 AIELLO CALABRO CS-2 AIETA CS-2 AILANO CE-2 AILOCHE BI-2 AIRETTA VB-2 AIROLE IM-2 ALA DI STURA TO-2 ALA' DEI SARDI OT-2 ALAGNA VALSESIA -
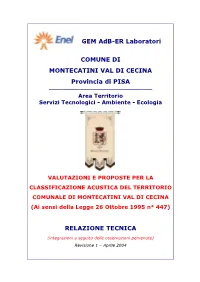
GEM Adb-ER Laboratori
GEM AdB-ER Laboratori COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA Provincia di PISA ____________________________________ Area Territorio Servizi Tecnologici - Ambiente - Ecologia VALUTAZIONI E PROPOSTE PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTECATINI VAL DI CECINA (Ai sensi della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447) RELAZIONE TECNICA (integrazioni a seguito delle osservazioni pervenute) Revisione 1 – Aprile 2004 Comune di MONTECATINI VAL DI CECINA GRUPPO DI LAVORO Acquisizione Dati e Programmazione sul territorio Arch. M. SILVESTRI - Direzione Settore Ambiente e Territorio Comune di MONTECATINI VAL DI CECINA Responsabile del procedimento di mappatura acustica Dott. Claudio DONATI - ENEL - LABORATORI Tecnico competente per le misure P.I. Massimo AMIDEI - ENEL - LABORATORI Elaborazioni Cartografiche P.I. Amerigo ROSSI - ENEL - LABORATORI Relazione Tecnica P.I. Massimo AMIDEI - ENEL - LABORATORI ENEL GEM AdB-ER COMUNE di LABORATORI MONTECATINI VAL DI CECINA P.zza Leopolda 56044 LARDERELLO (PI) ____________________ ____________________ Classificazione acustica del territorio – Comune di Montecatini Val di Cecina 2 Comune di MONTECATINI VAL DI CECINA SOMMARIO 1. PREMESSA 2. ELEMENTI SOGGETTI A MODIFICA Cartografia Zonizzazione acustica del territorio comunale: Tavola 1 – Carta 1:10.000 – Territorio Comunale parte I Tavola 2 – Carta 1:10.000 – Territorio Comunale parte II Tavola 3 – Carta di dettaglio Scala 1:2.000 · Montecatini Val di Cecina · frazioni Ponteginori, Sassa e Querceto Classificazione acustica del territorio – Comune di Montecatini Val di Cecina 3 Comune di MONTECATINI VAL DI CECINA 1. PREMESSA Il presente documento rappresenta la revisione alla prima stesura del “Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Montecatini Val di Cecina” realizzato, da ENEL GEM AdB-ER Laboratori, nel 2004. -

Polimetriche
TABELLE POLIMETRICHE CPT LINEA 10 PISA - TIRRENIA - LIVORNO Pisa *2,0 Porta a Mare *4,0 *2,0 Luicchio *4,0 *2,0 / La Vettola *6,0 *4,0 / *2,0 S. Piero 7,0 5,0 3,0 4,0 2,0 Bivio S. Piero 12,0 10,0 8,0 9,0 7,0 5,0 Marina di Pisa 16,8 14,8 12,8 13,8 11,8 9,8 4,8 Tirrenia 21,7 19,7 17,7 18,7 16,7 14,7 9,7 4,9 Calambrone 30,0 28,0 26,0 27,0 23,0 25,0 18,0 13,2 8,3 Livorno Note: * Tratta urbana CPT LINEA 50 CRESPINA - COLLESALVETTI - PISA Crespina 2,8 Tripalle 6,2 3,4 Fauglia 11,2 8,4 5,0 Collesalvetti 13,9 10,7 7,7 2,7 Vicarello 17,8 15,0 11,6 6,6 3,9 Arnaccio 23,3 20,5 17,1 12,1 9,4 5,5 Ospedaletto 27,1 24,3 20,9 15,9 13,2 9,3 3,8 Pisa CPT LINEA 51 ORCIANO - LORENZANA - COLLESALVETTI Orciano 7,1 Lorenzana 9,1 2,0 Laura 11,3 4,2 2,2 Acciaiolo 14,8 7,7 5,7 3,5 Torretta 12,8 5,7 3,7 \ \ Botteghino di Tripalle 16,2 9,1 7,1 \ \ 3,4 Fauglia 18,6 11,5 9,5 7,3 3,8 8,4 5,0 Collesalvetti CPT LINEA 70 PISA - GELLO - PONTASSERCHIO - MARINA DI VECCHIANO Pisa 5,8 Cascine di Gello 6,5 / Cottolengo 8,2 / 1,7 S. -

Orario Da E Per Volterra Scuole
1 ENTRATA X ISTITUTI DI VOLTERRA ALTA VALDICECINA BASSA VALDICECINA - MONTECATINI MONTEROTONDO 6,05 TRENO CECINA LUSTIGNANO 6,15 6,31 SERRAZZANO 6,25 LA SASSA 6,13 SASSO PISANO 6,20 CASINO DI TERRA 6,38 6,45 LA LECCIA 6,30 MICCIANO 6,35 BIVIO LECCIA 6,35 6,35 PONTEGINORI 6,53 6,55 CASTELNUOVO 6,32 LARDERELLO 6,45 6,45 MONTECATINI 7,15 MONTECERBOLI 6,50 6,50 LA BACCHETTONA 7,25 MONTECASTELLI 6,20 SALINE FS 7,07 7,10 LIBBIANO 6,30 MONTEGEMOLI 6,50 VOLTERRA I.S.A. 7,30 SAN DALMAZIO VOLTERRA P.ZA MARTIRI 7,35 7,45b POMARANCE 6,557,007,00 6,45 7,05 7,05 7,05 VILLAMAGNA - COLLE VAL D'ELSA SALINE 7,15 7,25 7,25 7,25 VOLTERRA P.ZA MARTIRI 7,35b 7,45b 7,45b 7,45b COLLE VAL D'ELSA 7,00 MONTEMICCIOLI BIVIO 7,27 VALDERA - LAJATICO- ORCIATICO VILLAMAGNA 7,15 PONTEDERA 6,24 6,24 PIAN DEI GELSI 7,32 SANTO PIETRO 6,43 VOLTERRA 7,50b 7,50b CAPANNOLI 6,48 6,50 6,50 SELVATELLE 6,55 6,55 TERRICCIOLA 6,50 b = IN P.ZA MARTIRI NAVETTA ORE 7,52 PER I.S.A. GHIZZANO 6,35 MONTELOPIO 6,23 FABBRICA 6,28 PECCIOLI 6,50 LA ROSA 7,00 6,55 6,55 7,00 7,00 LA STERZA 7,05 7,05 7,05 7,00 LAJATICO 7,10 7,05 SAN GIOVANNI 7,15 ORCIATICO 7,20 VOLTERRA I.S.A. -

Comunicato Ufficiale N. 42 Del 13/03/2019
Comunicato Ufficiale n. 42 del 13/03/2019 Stagione Sportiva 2018/2019 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. C.U. C.R.T. N.55 DEL 7/3/2019 Registrazione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche presso la nuova piattaforma del Registro 2.0 del C.O.N.I. Con riferimento all’oggetto, si rende noto che a far data dal 1° gennaio 2018, al fine di continuare ad accedere alla propria posizione, ogni Società dovrà effettuare nuovamente la registrazione, anche se già precedentemente registrata sulla piattaforma, acquisendo le nuove credenziali per i successivi accessi. Le Società, pertanto, avranno l’obbligo di accreditarsi sul nuovo sito del C.O.N.I., secondo le modalità ivi previste e specificate. 2. COMUNICAZIONI L.N.D. C.U. C.R.T. N.55 DEL 7/3/2019 REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – REGISTRO 2.0 Con riferimento agli adempimenti della FIGC nei confronti del CONI inerenti l’oggetto, si informa che a seguito di un incontro richiesto dalla scrivente Lega alla Segreteria Federale, quest’ultima – sentito nel merito il CONI – ha reso noto che le cosiddette “anomalie bloccanti” inerenti il caricamento dei tesserati e dello statuto sono in vigore dal 1° gennaio 2019. In proposito, si informa che è stata temporaneamente superata l’anomalia relativa ai tesserati, mentre per l’iscrizione al Registro CONI è necessaria produrre lo statuto societario vigente o lo statuto/atto costitutivo, unitamente alla data di registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate. Ciò stante, entro la prima settimana del mese di marzo p.v., il CED della LND renderà operativa una nuova funzionalità sul portale della LND nell’area riservata alle Società, che consentirà alle stesse di caricare tale documentazione, così da permettere la trasmigrazione del dato dal sistema della Lega a quello della FIGC che, da ultima, provvederà all’inoltro al CONI. -

Elenco Rivendite
Orari Titolare Ragione Sociale Comune Località Indirizzo Cap Prov Telefono Cellulare Fax Mattina Pomeriggio Continuato Chiusura Settore CONTI ANNA TABACCHI CONTI BIENTINA BIENTINA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II 42 56031 PI 0587 758128 0587 756659 7.00 - 13.00 15.00 - 20.00 Domenica Tabacchi GIANNINI PAOLO GIANNINI PAOLO EDICOLA TABACCHI BIENTINA BIENTINA VIA JACOPO DEL POLTA 55/A 56031 PI 0587 756377 0587 756377 7.30 - 13.00 15.30 - 20.00 Domenica Tabacchi GIANFALDONI MORENA KICCHI & TABACCHI DI GIANFALDONI M. BUTI BUTI VIA PIAVOLA 36 56032 PI 05877251433465394873 0587692068 8.00 - 13.00 16.00 - 20.00 Domenica Tabacchi LUPERINI DOMENICO TABACCHI ARTICOLI DA PESCA DA LUPERINI BUTI CASCINA DI BUTI VIA SARZANESE VALDERA 134 56032 PI 0587 724121 IDEM 6.30 - 13.30 15.30 - 19.30 Domenica Tabacchi ADAMI MASSIMO TABACCHERIA LA TORRE CALCI CALCI VIA BROGIOTTI 10 56011 PI 050 934006 050/934006 8.00 - 13.00 15.30 - 19.30 Domenica Tabacchi ARMANI RICCARDO IL GIORNALAIO DI ARMANI R.&C SAS CALCI CALCI PIAZZA CAIROLI 6 56011 PI 050934043 050934043 7.00 - 13.30 16.30 - 19.30 Dom. Pom. Edicola COLUCCI MARIA CALCI LA CORTE VIA B. BUOZZI 16 56011 PI 050 938784 8.30 - 13.00 16.00 - 20.00 Domenica Tabacchi DEL CARLO MICHELE BAR TABACCHI DEL CARLO CALCI LA GABELLA VIA LUNGOMONTE PROVINCIALE56011 20 PI 050 936095 050/939014 6.00 - 20.00 Domenica Tabacchi VUONO SANDRA CALCI CASTELMAGGIORE VIA DON MINZONI 7 56011 PI 050 939188 050 939188 8.00 - 13.00 16.00 - 20.00 Domenica Tabacchi CANEGALLO ENRICO CALCINAIA CALCINAIA PIAZZA MANIN 5 56012 PI 587489859 6.30 - 13.00 16.00 - 20.00 Dom. -

05-Rapetti 41-74
Atti Soc. tosc. Sci. nat., Mem., Serie A., 117-119 (2012) pagg. 41-74, figg. 25, tabb. 18; doi: 10.2424/ASTSN.M.2012.27 FRANCO RAPETTI (*), SEBASTIANO VITTORINI (†) NOTE ILLUSTRATIVE DELLA CARTA CLIMATICA DELLA TOSCANA Abstract - Explanatory notes on Tuscany Climatic Map. Climatic fea- termometro (Borchi & Macii, 1997) e costruito altri stru- tures of the Region Tuscany are outlined here, as an integration and menti meteorologici, quali il barometro, il pluviometro commentary on the Climatic Map edited on a scale of 1 to 250.000 (1956-1985). A brief profile of former meteorological and climatic e l’igrometro; verso la metà del Seicento tali attività studies about Tuscany is drawn, starting with the foundation of erano approdate a tentativi di misure sistematiche del- Meteorology at the Court of the Grand Duke Ferdinando II la pressione atmosferica e della temperatura dell’aria. de’Medicis. We also analyze a few significant synoptic panels deter- Nell’Archivio Meteorologico Centrale Italiano si riferi- mining the weather in Tuscany, with reference to the general circu- lation trends and Regional weather centers. Solar radiation, sea sur- sce infatti della presenza di due frammenti di misure face temperature and wind are analyzed. Air temperature, precipita- meteorologiche della metà del Seicento, raccolte a Pisa tion, number of cold and arid months are also taken into account, as e a Firenze per conto del Granduca Ferdinando II e well as exceptional thermal and pluviometric events. Thornthwaite’s del Principe Leopoldo de’Medici, che probabilmente hydro-climatic balance is developed and its parameters-such as po- rappresentano il primo esempio di raccolta di misure tential evaporation, deficit, surplus and outflow - are calculated. -

Pagina 1 Realizzazione Di Nuove Reti in Fibra Ottica Per La Connettività In
Realizzazione di nuove reti in fibra ottica per la connettività in Banda Larga – Modello A Stato Avanzamento Lavori al 17 Agosto 2018 Data prevista per Stato lavori Fibra Ottica n. Provincia Comune Località l'attivazione del servizio (a cura della Regione Toscana) (a cura dell'Operatore) 1 Arezzo Cavriglia Cavriglia connessa attivata 2 Arezzo Pian di Sco Faella connessa attivata 3 Arezzo Pian di Sco Pian Di Sco connessa attivata 4 Arezzo Poppi Moggiona connessa attivata 5 Arezzo Arezzo Frassineto connessa attivata 6 Arezzo Bibbiena Serravalle connessa attivata 7 Arezzo Bucine Pietraviva connessa attivata 8 Arezzo Capolona Castelluccio connessa attivata 9 Arezzo Castiglion Fiorentino Manciano connessa attivata 10 Arezzo Castiglion Fiorentino Montecchio connessa attivata 11 Arezzo Castiglion Fiorentino S. Cristina connessa attivata 12 Arezzo Cavriglia S. Barbara connessa attivata 13 Arezzo Chitignano Chitignano connessa attivata 14 Arezzo Chiusi della Verna Chiusi della Verna connessa attivata 15 Arezzo Chiusi della Verna Rimbocchi connessa attivata 16 Arezzo Civitella in Val di Chiana Ciggiano connessa attivata 17 Arezzo Cortona Pergo connessa attivata 18 Arezzo Cortona Tavarnelle connessa attivata 19 Arezzo Loro Ciuffenna Persignano connessa attivata 20 Arezzo Montevarchi Mercatale connessa attivata 21 Arezzo Ortignano Raggiolo Ortignano connessa attivata 22 Arezzo Poppi Badia Prataglia connessa attivata 23 Firenze Bagno a Ripoli S.Donato In Collina connessa attivata 24 Firenze Barberino Val d'Elsa Marcialla connessa attivata Pagina 1 -

Seggi Primarie Pd Pisa
Comune Seggi Sezioni elettorali Bientina Bientina: Sede PD, Piazzetta dell'Angiolo Tutte Buti Buti: Biblioteca Comunale Piazza Divisione Aqui 1,2,3 Cascine Di Buti: Centro Aggregazione Giovanile ex Scuolina Via Europa 4,56 Calci Circolo Arci La Pieve, Via Roma Tutte Calcinaia Calcinaia: Centro Polifunzionale Peppino Impastato, piazza Carlo Alberto 1,2,3,4 Fornacette: Circolo Pd via dell'Argine 5 5,6,7,8,9,10 Capannoli Capannoli: Teatro Comunale Via Roma 1,2,3 Santo Pietro Belvedere: Centro Sociale Via Vignoli 4 Casale Marittimo Teatro Comunale, Via Roma Tutte Casciana Terme Casa del Popolo via XX Settembre 14 Tutte Cascina Cascina Scuola Pesenti Via Aldo Moro 9,10,12 Latignano Centro Sociale Via Risorgimento 11 Cascina C/O Pubblica Assistenza Viale Comaschi 1,2,3,4,5,6,7,8 San Frediano Circolo Arci Piazza Guido Rossa 13,14,15,16 Sant'anna Circolo Arci “Abetone”, Via Tosco Romagnola 17,18 Navacchio Circolo Primavera Via T. Romagnola 20,21,22,23,24 San Lorenzo A Pagnatico Circolo Arci Via Stradiola 6,19,36 Zambra Circolo Arci Via Cammeo 29 Ripoli - San Sisto Circolo Arci Via San Sisto 33,34,35 Badia- Circolo Arci Via Toscoromagnola, Badia 25,26,27,28,30,31,32 Castelfranco di Sotto Castelfranco: Casa del popolo via Francesca sud 30 1,2,3,4,5,6,7,8 Orentano: Palazzina Comunale Piazza Roma 9,10,11 Castellina Marittima Biblioteca Comunale, Piazza Mazzini Tutte Castelnuovo Val di Cecina C/O Circolo Pd - Via Repubblica, 33 Tutte Chianni Circolo Pd via Farini 11 Tutte Crespina Crespina: Municipio, Sala Consiliare 1,4 Cenaia: Circolo Arci 2,3 Fauglia -

QUADRO CONOSCITIVO Aspetti Ambientali
COMUNE DI VOLTERRA · COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA PIANO STRUTTURALE COMUNE DI VOLTERRA QUADRO CONOSCITIVO aspetti ambientali TECNICI REDATTORI Ing. Luigi Bianchi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara, n.524 Ing. Lorenzo Tenerani Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara, n.631 Dott.sa Rosa Torre ambiente s.c. ecologia industriale ed igiene ambientale 0 SOMMARIO INTRODUZIONE ............................................................................................................... 3 1. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI PISA E LE FRAGILITÀ AMBIENTALI INDIVIDUATE SUL TERRITORIO .......................................... 8 2. SISTEMA ARIA ........................................................................................................... 13 2.1 INDICATORI DI STATO ....................................................................................................13 2.1.1 Qualità dell’aria ..................................................................................................13 2.2.2 Inquinamento acustico........................................................................................17 2.2 CRITICITÀ AMBIENTALI....................................................................................................23 3. SISTEMA ACQUA ........................................................................................................ 24 3.1 ACQUE SUPERFICIALI......................................................................................................24