Istituto Tecnico Agrario Licei: Ist
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sistemi Zootecnici E Pastorali Alpini Prof. Michele Corti
Sistemi zootecnici e pastorali alpini Prof. Michele Corti Dispensa del Corso Corso di laurea in : Tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio montano Introduzione L’importanza della zootecnia nella vita delle comunità alpine è legata ai vincoli imposti dal clima sulla possibilità di esercizio della attività agricola. Innanzitutto nelle Alpi il terreno agrario è scarso e poco produttivo. La zootecnia più di altre attività agricole si presta all’utilizzo di zone vegetative poste a diverse altitudini sfruttando risorse foraggere erbacee ma anche arbustive ed arboree. Dove l’uomo non è in grado di utilizzare le superfici coltivandole con piante alimentari il ruminante si inserisce come anello intermedio indispensabile di una catena trofica che nella veste di consumatore consente di convertire le risorse dei pascoli naturali ottenibili in condizioni nelle quali ogni attività agricola è preclusa in alimenti ad elevato valore biologico. Ciò vale per ambienti estremi per condizioni di temperatura e di piovosità come le steppe e le tundre alle quali si avvicinano come visto alcuni degli habitat della montagna alpina. Il ruolo fondamentale dell’allevamento animale nell’economia tradizionale delle comunità alpine è anche legato alla capacità degli animali di utilizzare una parte della produzione foraggera ottenibile durante il periodo vegetativo in modo differito consentendo all’uomo di alimentarsi con prodotti ricchi di principi nutritivi come le vitamine scarsamente presenti nei prodotti di origine vegetale conservati con le tecniche tradizionali. Parlare di agricoltura e di allevamento nei termini delle attività di tipo specializzato che ci sono più famigliari al giorno d’oggi appare inadeguato. Più adeguato risulta fare riferimento, nel caso dei sistemi produttivi dell’agricoltura di montagna al concetto di agropastoralismo che in qualche modo si avvicina al concetto tedesco di Alpwirtshaft . -

O041 Genotype by Environment Interactions and Response to Selection for Productive Traits in a Local Cattle Breed O042 Conservat
Italian Journal of Animal Science 2017; volume 16: supplement 1 ANIMAL BREEDING AND GENOMICS – GENETIC DIVERSITY two approaches. These results suggest the importance to include O041 G × E when local breeds are selected. Genotype by environment interactions and Acknowledgements response to selection for productive traits The research was funded by ANARE, Italy. in a local cattle breed Cristina Sartori1, Francesco Tiezzi2, Nadia Guzzo3, O042 Roberto Mantovani1 Conservation status and rates of 1Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse inbreeding of Italian autochthonous beef Naturali e Ambiente, University of Padova, Italy breeds 2 Department of Animal Science, NC State University, Raleigh, USA Maria Chiara Fabbri1, Christos Dadousis1, Stefano 3 Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, Biffani2,3, Riccardo Negrini3,4, Riccardo Bozzi1 University of Padova, Italy Contact: [email protected] 1Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, Sezione di Scienze Genotype by Environment interactions (G × E) happen when Animali, University of Firenze, Italy individuals have diverse adaptations to local conditions. This 2Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria, National Research study aimed to investigate G × E and response to selection (R) Council, Milano, Italy in dairy traits and somatic cells under the diverse environmental 3Associazione Italiana Allevatori, Roma, Italy conditions in which the local Rendena cattle breed is reared. 4Dipartimento di Scienze Animali, della Nutrizione e degli Target traits were milk, fat and protein yields (MY, FY, and PY; Alimenti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, Italy kg), fat and protein percentage (F% and P%), and somatic cell Contact: [email protected] score (SCS), routinely collected over 12 years as test day data of nearly 10,000 cows daughters of ~600 sires. -

Population Structure and Genetic Diversity of Italian Beef Breeds As a Tool for Planning Conservation and Selection Strategies
animals Article Population Structure and Genetic Diversity of Italian Beef Breeds as a Tool for Planning Conservation and Selection Strategies Maria Chiara Fabbri 1,*, Marcos Paulo Gonçalves de Rezende 2, Christos Dadousis 1 , Stefano Biffani 3 , Riccardo Negrini 4,5, Paulo Luiz Souza Carneiro 6 and Riccardo Bozzi 1 1 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, Università di Firenze, 50144 Firenze, Italy; christos.dadousis@unifi.it (C.D.); riccardo.bozzi@unifi.it (R.B.) 2 Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Piemontese, 12061 Carrù, Italy; [email protected] 3 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria, 20133 Milano, Italy; biff[email protected] 4 Associazione Italiana Allevatori, 00161 Roma, Italy; [email protected] 5 Istituto di Zootecnica, Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università Cattolica del S.Cuore, 29100 Piacenza, Italy 6 Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, Jequié, Bahia 45205-490, Brazil; [email protected] * Correspondence: mariachiara.fabbri@unifi.it Received: 20 August 2019; Accepted: 22 October 2019; Published: 29 October 2019 Simple Summary: The recent alarming reports on global climate change and the challenges facing the agricultural sector to meet the increase in meat consumption, impose research in biodiversity. An important genetic pool of local breeds might play a crucial role in the near future to address these challenges. Although Italy is considered as one of the richest countries in biodiversity, there are autochthonous cattle breeds under extinction. To safeguard biodiversity and increase genetic diversity within breeds, appropriate management tools must be developed. To achieve this, precise knowledge of the population structure and genetic diversity per breed are required. -

Le Razze Di Bovini Da Carne in Veneto
a cura del SETTORE STUDI ECONOMICI ottobre 2011 I dati della BANCA NAZIONALE dell’ANAGRAFE ZOOTECNICA del MINISTERO DELLA SALUTE istituita presso l’I.Z.S. ABRUZZO E MOLISE, sede di TERAMO INDICE INTRODUZIONE .......................................................................................................................... 2 PREMESSA ................................................................................................................................... 4 IL PATRIMONIO BOVINO ............................................................................................... 5 I DATI ISTAT ............................................................................................................................... 5 IL PATRIMONIO BOVINO VENETO ......................................................................... 8 I DATI DELL’ANAGRAFE BOVINA ......................................................................................... 8 LE RAZZE DA CARNE ............................................................................................................. 13 L’ANDAMENTO MENSILE DELLA NUMEROSITA’ ........................................................... 16 REDAZIONE .............................................................................................................................. 17 1 INTRODUZIONE Questo report di analisi è centrato principalmente sui dati disponibili presso la banca dati dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica del Ministero della Salute, consultabili liberamente e direttamente via internet. La -

Aziende Selezionate Per Prelievo Seme
Azione 8 Raccolta di materiale biologico e germoplasma Identificazione delle Aziende per il campionamento del seme Di seguito è riportato l’elenco totale delle aziende (n° = 120) in cui sono stati raccolti i dati di caratterizzazione morfologica per le razze Calvana, Pontremolese, Sarda, Sardo Bruna e Sardo Modicana. AUA RAZZA 4222117 Calvana 4225011 Calvana 4623136 Pontremolese 9121193 Sarda 9140581 Sarda 9140760 Sarda 9161866 Sarda 9161874 Sarda 9162398 Sarda 9165308 Sarda 9170938 Sarda 9210128 Sarda 9241012 Sarda 9241250 Sarda 9241269 Sarda 9241286 Sarda 9250721 Sarda 9250989 Sarda 9250990 Sarda 9261304 Sarda 9533103 Sarda 9120280 Sardo Bruna 9121105 Sardo Bruna 9121193 Sardo Bruna 9121196 Sardo Bruna 9121271 Sardo Bruna 9121286 Sardo Bruna 9121305 Sardo Bruna 9121824 Sardo Bruna 9122113 Sardo Bruna 9122131 Sardo Bruna 9122248 Sardo Bruna 9123374 Sardo Bruna 9140581 Sardo Bruna 9140599 Sardo Bruna 9140778 Sardo Bruna 9150512 Sardo Bruna 9151030 Sardo Bruna 9161866 Sardo Bruna 9161874 Sardo Bruna 9170334 Sardo Bruna 9170545 Sardo Bruna 9170938 Sardo Bruna 9171404 Sardo Bruna 9181107 Sardo Bruna 9181144 Sardo Bruna 9181146 Sardo Bruna 9191081 Sardo Bruna 9210128 Sardo Bruna 9230155 Sardo Bruna 9240369 Sardo Bruna 9240371 Sardo Bruna 9240457 Sardo Bruna 9240459 Sardo Bruna 9240671 Sardo Bruna 9240672 Sardo Bruna 9240687 Sardo Bruna 9241250 Sardo Bruna 9241254 Sardo Bruna 9241269 Sardo Bruna 9241277 Sardo Bruna 9241278 Sardo Bruna 9241286 Sardo Bruna 9241288 Sardo Bruna 9242604 Sardo Bruna 9242606 Sardo Bruna 9250810 Sardo Bruna 9250811 -

Country Report Italy 2011
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP) 21 st April 2011 ERFP Country report 2010 – 2011 COUNTRY: ITALY reported by: Giovanni Bittante Strategic Priority Area 1: Characterization, Inventory and Monitoring of Trends and Associated Risks The inventory of Italian animal genetic resources and the monitoring of trends and associated risks has been undertaken and summarized il the paper "Italian animal genetic resources in the Domestic Animal Diversity Information Systm of FAO" (Giovanni Bittante, 2011, Italian Journal of Animal Science,vol 10:e29, Annex 2). Several research activities on this topic have been carried out by Universities and Research Institutions. Among them see the important activity of ConSDABI (Annex 3). Strategic Priority Area 2: Sustainable Use and Development Beyond the systematic control of animals of Italian populations (herd books, pedigree registries, milk recording, type evaluation, etc.) made by the different associations of breeders, as outlined in Annex 2, several projects dealing with sustainable use, products valorisation and development has been carried out by national and local governments, agencies, breeders associations and consortia. Strategic Priority Area 3: Conservation (please give details for the most relevant institutions for national genebanks / cryopreservation in the table in Annex 1) In situ conservation activities are going on for almost all the Italian AnGR, while the project of a national virtual cryo-bank is not yet fully established, despite the intense work of the -

Report on the State of Animal Genetic Resources in Italy
Report on the State of Animal Genetic Resources in Italy English (Compact version) July 2005 Report on the State of Animal Genetic Resouces in Italy INTRODUCTION The authorization for the preparation of this Report on the State of Animal Genetic Resources in Italy has been extended in March 2001 following a communication from the Director General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO. The Ministry of Agricultural and Forestry Policies (MiPAF) has assigned the task of preparing this First Report to ConSDABI (Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative) under the direction of Prof. Donato Matassino. This Report, in synthesis, describes the current situation of animal genetic resources for food and agriculture and identifies the needs to implement their monitoring, conservation and utilization, their potential contribution to agriculture, nutrition and to sustainable and multifunctional rural development; it also analyzes the current capacity of the country for the management of these resources and describes the priorities that may be useful for international cooperation. 1 Report on the State of Animal Genetic Resouces in Italy CHAPTER 1 THE STATE OF BIODIVERSITY IN THE ANIMAL SECTOR IN ITALY 1.1. Italian agriculture, animal production systems and relative biodiversity 1.1.1. The country Italy has borders with France (west), Switzerland and Austria (north), Slovenia (east), and in its interior is found the Vatican State and San Marino. The country has 20 regions with 103 provinces and 8.101 municipalities (comuni). In 2003 it had 57, 3 million inhabitants on an area of 301.336 km2, and a mean density of 190 inhabitants / km2. -

Atlante Delle Razze Autoctone Bovini, Equini, Ovicaprini, Suini Allevati in Italia
00_Avanti_00_Avanti 15/07/19 10.26 Pagina I L'estratto contiene pagine non in sequenza Atlante delle razze autoctone Bovini, Equini, Ovicaprini, Suini allevati in Italia Daniele Bigi e Alessio Zanon 00_Avanti_00_Avanti 20/12/19 15.51 Pagina II L'estratto contiene pagine non in sequenza 1a edizione: novembre 2008 2a edizione: gennaio 2020 In copertina: Asino Romagnolo (A. Zanon, RARE); Scrofa Casertana (V. Peretti, RARE); Cavallo Salernitano (V. Peretti, RARE); Vacca Piemontese con vitello (R. Fortina, RARE); Capra Alpina Comune (L. Brambilla, RARE). © Copyright 2020 by “Edagricole – Edizioni Agricole di New Business Media S.r.l.”, Via Eritrea, 21 – 20157 Milano Redazione: Piazza G. Galilei, 6 – 40123 Bologna Vendite: tel. 051/6575833; fax 051/6575999 email: [email protected] – www.edagricole.it 5561 Proprietà letteraria riservata - printed in Italy La riproduzione con qualsiasi processo di duplicazione delle pubblicazioni tutelate dal diritto d’autore è vietata e penalmente perseguibile (art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633). Quest’opera è protetta ai sensi della legge sul diritto d’autore e delle Convenzioni internazionali per la protezione del diritto d’autore (Convenzione di Berna, Convenzione di Ginevra). Nessuna parte di questa pubblicazione può quindi essere riprodotta, memoriz- zata o trasmessa con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (fotomeccanica, fotocopia, elettronica, ecc.) senza l’autorizzazione scritta dell’editore. In ogni caso di riproduzione abusiva si procederà d’ufficio a norma di legge. Progetto -

Download Full
Proceedings of the World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, 11. 236 A genome-wide perspective on the population structure of Italian cattle breeds S. Mastrangelo1*, E. Ciani2, P. Ajmone Marsan3, A. Bagnato4, L. Battaglini5, R. Bozzi6, A. Carta7, G. Catillo8, M. Cassandro9, S. Casu7, R. Ciampolini10, P. Crepaldi4, M. D’Andrea11, R. Di Gerlando1, L. Fontanesi12, M. Longeri4, N.P.P Macciotta13, R. Mantovani9, D. Marletta14, D. Matassino15, M. Mele16, G. Pagnacco4, C. Pieramati17, B. Portolano1, F.M. Sarti18, M. Tolone1 & Fabio Pilla11 1University of Palermo, Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, 90128 Palermo, Italy 2University of Bari, Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Biofarmaceutica, 70124 Bari, Italy 3University of Sacro Cuore, Istituto di Zootecnia, 20122 Piacenza, Italy 4University of Milano, Dipartimento di Medicina Veterinaria, 20133 Milano, Italy 5University of Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari, 10095 Grugliasco, Italy 6University of Firenze, Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente, 50144 Firenze, Italy 7Agris Sardegna, Unità di Ricerca di Genetica e Biotecnologie, 07100 Sassari, Italy 8CREA, CREA Research Centre for Animal Production and Acquaculture, 00015 Monterotondo, Italy 9University of Padova, Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente, 35020 Legnaro, Italy 10University of Pisa, Dipartimento di Scienze Veterinarie, 56100 Pisa, Italy 11University of Molise, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e -
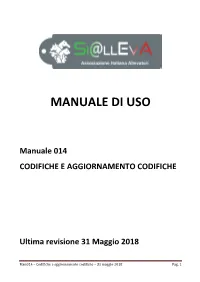
Codifiche E Aggiornamento Codifiche
MANUALE DI USO Manuale 014 CODIFICHE E AGGIORNAMENTO CODIFICHE Ultima revisione 31 Maggio 2018 Man014 – Codifiche e aggiornamento codifiche – 31 maggio 2018 Pag. 1 CODIFICHE Le codifiche sono tutti i codici che vengono utilizzati nel programma per definire le caratteristiche dell’informazione. I codici sono spesso utilizzati nelle liste al posto della descrizione estesa. Le codifiche sono registrate nel Data Base centrale e vengono salvate in locale dal programma per velocizzare la consultazione e l’utilizzo del software. Le codifiche non subiscono generalmente modifiche e vengono aggiornate ad ogni aggiornamento del programma. Qualora si dovesse procedere ad un aggiornamento nel Data Base centrale di alcune codifiche (ad esempio se si aggiungono Patologie mancanti), l’utente può procedere manualmente cliccando su Aggiorna Codifiche nel menu in alto a sinistra. Indice Codifiche incluse nel documento: RAZZE DIFFICOLTA’ AL PARTO STATI RIPRODUTTIVI CODICI EVENTI PATOLOGIE METODI DI CONTROLLO FUNZIONALE Man014 – Codifiche e aggiornamento codifiche – 31 maggio 2018 Pag. 2 RAZZE Specie Razza Specie Razza Cod Descrizione Cod Descrizione Cod Descrizione Cod Descrizione ND Non Definito ND Non definito AT Tuxer 70 Bufalo Mediterraneo AY Ayrshire 70 BUFALI Z0 Bufalo Meticcio BA Blonde d'Aquitaine Z1 Bufalo Murrah CZ Cserwona Polska -2 Rotbunte (importato) DX Dexter -1 Rotbunte (discendenza) GR Guernsey 00 Meticcia GW Galloway 01 Bruna HE Hereford 02 Frisona Italiana HL Highland 03 Valdostana Pezzata Rossa HS Hérens (Heringer ) 04 Pezzata Rossa Italiana -

Università Degli Studi Di Padova
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA Dipartimento di AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI RISORSE NATURALI E AMBIENTE - DAFNAE SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN: SCIENZE ANIMALI INDIRIZZO:GENETICA, BIODIVERSITA’, BIOSTATISTICA E BIOTECNOLOGIE CICLO: XXIV SVILUPPO DI METODI PER LA GESTIONE DI RAZZE AUTOCTONE ITALIANE Direttore della Scuola: Ch.mo Prof. Martino Cassandro Coordinatore d’indirizzo: Ch.mo Prof. Roberto Mantovani Supervisore: Ch.mo Prof. Roberto Mantovani Dottorando: Manolo Cappelloni A Luca 2 INDICE ABSTRACT ......................................................................................................................................................... 5 RIASSUNTO ....................................................................................................................................................... 7 1. INTRODUZIONE ........................................................................................................................................... 10 1.1 IL RUOLO DEI CONTROLLI FUNZIONALI SUL PATRIMONIO ZOOTECNICO NAZIONALE. .......................... 10 1.2 I METODI UFFICIALI DI CONTROLLO FUNZIONALE E LA GESTIONE DEL DATO. ....................................... 13 1.3 L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI SPECIE E RAZZA ................................................................................. 14 1.4 LE DIFFERENZE TRA LIBRO GENEALOGICO E REGISTRO ANAGRAFICO. ................................................... 17 1.5 LE ATTIVITÀ INERENTI LA GESTIONE DEL REGISTRO ANAGRAFICO. ....................................................... -

TJAS Cover.Indd
22nd Congress of Animal Science and Production Association ANIMAL BREEDING AND GENETICS - ADAPTATION STRATEGIES loci for tick burden and T. parva parva infection, respectively. body measurements data and showed that Sonok is signifi- By exploring a region of 25 kbp around the significant loci, cantly larger than Karapan (p<.05) in all dimensions. two genes were identified as putatively involved into local Exterior traits like body color patterns, dewlap, hump or back- adaptation for ECF: PRKG1 (Protein kinase, cGMP-dependent, line were analized using v2 which also showed significant type I) and SLA2 (Src-like-adaptor 2). PRKG1 is an inflamma- differences (p<.05) between the two sub-populations. tory response-related gene already described as associated Principal Component Analysis was used to visualize the with tick resistance in indigenous South African cattle. SLA2 underlying pattern of body measurements data. We could see is involved with lymphocyte proliferation regulatory pathways, separate clusters between the Sonok and the Karapan where which are known to be modified by T. parva parva infection. the first two PC explained 67% and 16% of the total variance. Additionally, a preliminary ancestry analysis of the highlighted These results allow discriminating the Sonok from the candidate regions showed a mixed sanga (African taurine x Karapan by means of body measurements and exterior traits. zebu) and zebuine origin for PRKG1 region, and a prevalent sanga origin for SLA2 region. Acknowledgements Acknowledgements The research was funded by Directorate General of Higher Education, Ministry of Research, Technology and Higher The research was funded by the European project NEXTGEN, Education, Republic of Indonesia.