Scarica Saggio EGISTO LANCEROTTO
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Villa Pisani E Le Mostre Di Arte Contemporanea
Corso di Laurea in Lettere Tesi di Laurea in Storia dell’Arte Contemporanea Villa Pisani e le mostre di Arte Contemporanea Relatore Ch. Prof. Nico Stringa Laureando Cristina Zara Matricola 741387 Anno Accademico 2012 / 2013 A Paride, Gianluca e Filippo; a mia madre e mio padre; a Chiara e a tutte le mie amiche. INDICE Capitolo 1 ........................................................................................................................................................................................................................... 6 Villa Pisani, la Versailles del Veneto ...................................................................................................................... 7 Capitolo 2 .......................................................................................................................................................................................................................14 Villa e Museo: due mondi a confronto ...........................................................................................................15 Capitolo 3 .......................................................................................................................................................................................................................17 Villa Pisani, il museo che cerca una nuova vita .............................................................................18 3.1 Mostre autonome ...................................................................................................................................................................19 -

Figura 1. Giacomo Casa, Allegoria Dell'unità D'italia, 1866-67. Collezione Privata
Figura 1. Giacomo Casa, Allegoria dell’Unità d’Italia, 1866-67. Collezione privata Venezia 1868: l’anno di Ca’ Foscari a cura di Nico Stringa e Stefania Portinari A partire dal 1868: nota sulla nuova pittura a Venezia Parte prima Nico Stringa (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Abstract Even 19th century had its ’68, particularly in Venice, where, without sensational episodes but with as much relevance, as regards the artistic situation, as what happened a century later, a series of events, if seen even if only in their apparently casual conse- quential and then overlapping, attests to a total value objectively unusual and rich in subsequent implications, ordered in the direction of a general renewal. Two years after the plebiscite that sanctioned the entry of Venice and Veneto into the Kingdom of Italy, many signs provide the clarification of an overall picture of great momentum due in large part to the contribution of a new generation of Venetians. The establishment of the Royal Higher School of Commerce at Ca’ Foscari, a prelude to the establishment of one of the major university centres of research and higher education, contributed to the rebirth and revival of Venice and its image, in stark contrast with the myth, never extinguished, of a city ‘inevitably’ linked to its never-ending end, to its endless twilight. Keywords Venice. Pietro Selvatico Estense. Fine Art Academy of Venice. Strenna Veneziana. Ermolao Antonio Paoletti. Guglielmo Stella. Tommaso Locatelli. Emanuele Antonio Cicogna. Federico Zandomeneghi. Domenico Bresolin. -

L'armonia Del Vero. Vita E Paesaggi Tra Terre E Acque
L’armonia del vero. vita e paesaggi tra terre e acque LUIsA TURChI pOpOLANE E DAME , TRA CONTEMpORANEITà E NOsTALgIA DEL sETTECENTO . DALLA FINzIONE AL vERO NELLE sCENE DI gENERE n’incessante, instancabile ricerca del vero . È avendo come «ispirazione e consigliera la natura, nello sforzo costante e con - Utinuo per trovare nell’armonia delle linee e dei colori, quei misteriosi vincoli che legano le anime alla materia dell’Univer - so» 1, come asserisce nel 1901 un pittore quale Beppe Ciardi, proveniente da una famiglia di artisti - si pensi al padre guglielmo e alla sorella Emma -, che si può penetrare nell’essenza dei rapporti fra l’umano e il divino, attraverso il linguaggio visivo dell’arte. Tra Ottocento e Novecento, pur provenendo dalle aule accademiche, i pittori veneti si aprono al realismo studiato non tanto sui libri e sui modelli quanto per le strade e nell’ambiente naturale dove vivono, giorno per giorno. secondo gli ideali propugnati da pietro selvatico Estense, segretario dell’Accademia di Belle Arti di venezia che nel suo di - scorso annuale Sulla convenienza di trattare in pittura soggetti tolti alla vita contemporanea (1850) 2 invita gli allievi a rivolgersi alle rap - presentazioni del vero , sostenendo «argomenti attinti alla vita d’oggigiorno» senza perdere di vista il bello morale che lì si ritrova, si sviluppa così la pittura di genere, che eleva popolani e popolane al rango di personaggi principali dei dipinti. Attori e attrici tra contemporaneità e nostalgia del settecento, che mai cessa nelle sue declinazioni d’ispirazione carnevalesca o di teatro. se già Léopold Robert (1794-1835) aveva dipinto La partenza dei pescatori dell’Adriatico (Neuchâtel, Musée d’Art et d’histoire) 3, un antesignano «studio ideale di un umile costume» che univa il decoro alla fedeltà al vero, tela esposta nel 1834 a palazzo pi - sani di venezia, tesa a mettere in luce esempi di insigne carità, gli artisti enfatizzano nelle loro opere soprattutto piaghe sociali come il vagabondaggio e l’elemosina dei mendicanti, o la rappresentazione di orfani e derelitti. -

Eugenio Scomparini
Massimo De Grassi Eugenio Scomparini INIZIATIVE CULTURALI spa Fondazione CRTrieste Utilizzo colori Pantone asterisco rosso: Pantone 187 ic: Pantone 443 Fondazione CRTrieste: Pantone 443 Collana d’Arte della Fondazione CRTrieste Curatore Giuseppe Pavanello MASSIMO DE GRASSI, Eugenio Scomparini Nono volume della collana Prima edizione: dicembre 2007 Volumi pubblicati ANGELA TIZIANA CATALDI, Guido Sambo, 1999 DANIELA MUGITTU, Bruno Croatto, 2000 GIANFRANCO SGUBBI, Adolfo Levier, 2001 NICOLETTA ZAR, Giorgio Carmelich, 2002 CLAUDIA RAGAZZONI, Gino Parin, 2003 GIANFRANCO SGUBBI, Glauco Cambon, 2004 FRANCA MARRI, Vito Timmel, 2005 MATTEO GARDONIO, Giuseppe Barison, 2006 P ROGETTO GRAFICO Portare a termine quest’opera non sarebbe Studio Mark, Trieste stato possibile senza la cortese disponibilità dei proprietari delle opere - molti dei quali F OTOGRAFIE hanno preferito mantenere l’anonimato - Paolo Bonassi e dei responsabili delle istituzioni triestine: S TA M PA Curia Vescovile, Civici Musei di Storia ed Arte, Arti Grafiche Friulane/IMOCO, Feletto Umberto (UD) Civico Museo Revoltella, Biblioteca Civica, per conto di LINT Editoriale, Trieste Archivio Storico del Comune, Dipartimento di Storia e Storia dell’Arte dell’Università degli Studi. Ed inoltre: Musei Provinciali di Gorizia, INAIL sede di Trieste, Assicurazioni Generali, RAS. A tutti, la nostra viva gratitudine. Stampato in Italia / Printed in Italy Il nostro grazie, infine, a quanti hanno È vietata la riproduzione anche parziale dato una mano nelle ricerche: © 2007, Fondazione CRTrieste Marisa Bianco Fiorin, Consuelo Cercenà, Isbn 978-88-901667-8-5 Nicoletta Comar, Franco Firmiani, Matteo Gardonio, Maria Beatrice Giorio, Diego Gomiero, Beatrice Malusà, Furio Princivalli, Laura Safred, In copertina: Melita Sciucca, Serena Skerl Del Conte, E. SCOMPARINI, L’Industria, particolare [cat. -
OMAGGIO AI TITO Opere Scelte Di Ettore Tito
OMAGGIO AI TITO opere scelte di Ettore Tito C M C M Y K Y K Questa pubblicazione è stata stampata in occasione della mostra Omaggio ai Tito. Opere scelte di Ettore, Luigi, Pietro Giuseppe Tito. 5 - 25 Settembre 2003 Villa Nazionale Pisani Stra - Ve Manifestazione promossa da BANCA DEL VENEZIANO in partecipazione con MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI MUSEO DI VILLA NAZIONALE PISANI in collaborazione con SEI - SISTEMI DI SICUREZZA - PADOVA Progetto espositivo a cura di Anna Maria Tito Flavia Fricano Federica Luser C M C M Y K Y K Da un’idea di Matteo Mazzato Organizzazione Trart Progetto grafico Trart Testi di Federica Luser Matteo Mazzato Prefazione di Virginia Baradel Guglielmo Monti Fotografie di Matteo De Fina Un doveroso ringraziamento a tutti i prestatori e in particolare a Galleria Internazionale d'Arte Moderna - Ca' Pesaro Venezia Un caloroso ringraziamento per l'affettuosa partecipazione a Virginia Baradel Paolo Smali Cecilia Tito Lucia Tito Finito di stampare presso le Grafiche Editoriali “La Press” nel mese di agosto 2003 © Copyright e diritti di pubblicazione riservati Banca del Veneziano - Edizioni Trart (Dolo - Trieste) C M C M Y K Y K C M C M Y K Y K Pagina precedente: La Sarabanda, 1934 Olio su tavola - cm 182x105 - Mira, Banca del Veneziano LA BANCA DEL VENEZIANO, nel quarantesimo anno della sua fondazione ha il piacere di presentare la mostra Omaggio ai Tito. La mostra è un'occasione per evidenziare, nel segno della continuità e nel rispetto dei valori in cui crediamo fermamente, il profondo radicamento nella comunità locale che da sempre contraddistingue la Banca del Veneziano, l'antica Cassa Rurale e Artigiana, e che ha fedelmente accompagnato l'impegno della nostra istituzione, anche nella cultura. -

Cartella Stampa Favretto
GIACOMO FAVRETTO (1849 – 1887) Venice fascination and seduction Venice, Museo Correr 31st July – 21st November 2010 Owing to the quality of his painting, his highly original development, the similarity with the works of other artists close to him or with contemporaries, the Venetian Giacomo Favretto (1849-1887) is one of the most important masters of the Italian Nineteenth century. A true “innovator" of the Venetian school during the second half of the century, he both revived and modernised the unique aspects of great Veneto tradition – from Longhi to Tiepolo – that had been abandoned in the first half of the Nineteenth century in favour of paintings of history and landscape. In his short but intense career, Favretto was to become a hugely successful painter. He died prematurely in 1887, leaving unfinished on his easel Modern Stroll that might have represented a possible Venetian form of the most modern international trends although it was not until 1895 that the Biennale was to be founded in Venice. This is the first modern day exhibition to be dedicated to Favretto since 1899. Co-produced with the Chiostro del Bramante in Rome as is only right, it has also come to Venice as a more extensive edition with outstanding unpublished works. There are around eighty works on display. They include the entire range of Favretto’s artistic production, presenting masterpieces that once belonged to the collections of the King of Italy and remarkable works that were, until now, unknown to the public, from museums or private collections. However, the exhibition also pays particular attention to Favretto's relations and comparisons with other protagonists of Veneto painting during that period, including Ettore Tito, Alessandro Milesi, Guglielmo Ciardi, Luigi Nono …. -
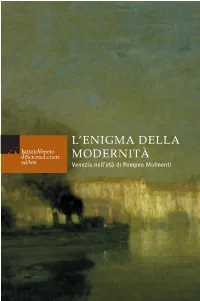
Documento1, Page 1-2 @ Normalize
L’ENIGMA DELLA MODERNITÀ Venezia nell’età di Pompeo Molmenti ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI L’ENIGMA DELLA MODERNITÀ Venezia nell’età di Pompeo Molmenti a cura di GIUSEPPE PAVANELLO VENEZIA 2006 ISBN 88-88143-62-9 Il volume riporta le relazioni presentate al Convegno di studio promosso dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti nel 150° anniversario della nascita di Pompeo Molmenti Venezia, 17 e 18 ottobre 2002 © Copyright Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti – Venezia 30124 Venezia – Campo S. Stefano 2945 Tel. 041 2407711-Telefax 041 5210598 [email protected] www.istitutoveneto.it INDICE Presentazione . Pag. VII GIUSEPPE PAVANELLO Introduzione . » IX GIUSEPPE GULLINO Molmenti e l’Istituto Veneto . » 3 GIANDOMENICO ROMANELLI Venezia nella vita privata. L’ideologia della venezianità . » 19 ANCO MARZIO MUTTERLE Il letterato . » 27 GIUSEPPE PAVANELLO Lo storico dell’arte veneziana . » 57 NICO STRINGA «Ogni eccesso è una follia»: Molmenti e la critica d’arte . » 97 MONICA DONAGLIO Il politico . » 129 MASSIMO FAVILLA «Delendae Venetiae». La città e le sue trasformazioni dal XIX al XX secolo . » 165 ALVISE ZORZI Molmenti e l’idea di Venezia . » 227 GIANCARLO LANG «Questo sacro alla pace intimo nido»: Molmenti e il suo lago . » 239 Indice dei nomi . » 265 PRESENTAZIONE Il 17 e 18 ottobre 2002 l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti celebrò, con un convegno, il 150° anniversario della nascita di Pompeo Gherardo Molmenti (1852-1928), con l’intendimento di rendere il giu- sto omaggio a un illustre cittadino veneziano, che fu eminente studio- so, giornalista, letterato, uomo politico e – non ultimo – socio dell’Isti- tuto Veneto dal 1889 e suo presidente negli anni 1914-1916. -

Acta2014-1.Pdf
ACCADEMIA DEI CONCORDI DI ROVIGO Acta Concordium n. 30 - gennaio 2014 ROVIGO PRESSO LA SEDE DELLA ACCADEMIA «Acta Concordium» - n. 30 - Supplemento a «Concordi», n. 1/2014 CONCORDI - TRIMESTRALE DEI CONCORDI DI ROVIGO Autorizzazione Tribunale di Rovigo N° 3766 10/92 R.Stampa Proprietario: Fondazione Concordi Editore: Accademia dei Concordi Redazione: Enrico Zerbinati Direttore responsabile: Anna De Pascalis Realizzazione grafica: Nicola Artosi Stampa: Sit S.r.l - Società Industrie Tipolitografiche - Dosson di Casier (TV) © Accademia dei Concordi - Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 45100 Rovigo Tel. 0425.27991 - Fax 0425.27993 - Web www.concordi.it ISSN 1121-8568 INDICE ANTONELLO NAVE, Luciano Nezzo (1856-1903). Un pittore badiese tra Venezia e Urbino . Pag. 7 ROBERTA REALI, L’omaggio di Giovanni Biasin alla poetica verista della Scuola napoletana: il d’après “Impressione di un quadro di Di Chirico” . » 37 ORETTA DE STEFANI, SEVERINO MORA, Jole Petrowna Bellonzi in Migliorini. Una maestra “femminista” ante litteram a Fiesso Umbertiano . » 49 ANNA SPATA, Un patto tra generazioni e tra istituzioni per non dimenticare il passato, per costruire il futuro, per 71 comprendere il presente attraverso la lettura. » LUCIANO NEZZO (1856-1903) UN PITTORE BADIESE TRA VENEZIA E URBINO Antonello Nave Luciano Nezzo nacque il 17 settembre 1856 a Badia Polesine, in contrada San Rocco, da Francesco e Barbara Lendinaro1. Alla fine degli anni Sessanta frequentò la scuola tecnica comunale, dove mise in evidenza le sue attitudini per il disegno e fece i primi passi nella pratica d’arte sotto la guida dell’ingegnere Marco Vallerini. Grazie al sostegno di Carlo dal Fiume, facoltoso possidente e sindaco del paese2, nel 1870 il ragazzo poté trasferirsi a Venezia per continuare i suoi studi presso l’istituto di belle arti e lì fu allievo del trevigiano Pompeo Marino Molmenti, che svolgeva da un ventennio il suo magistero e aveva già formato artisti destinati al successo, quali Giacomo Favretto, Luigi Nono ed Ettore Tito. -

Rivista Di Studi Ungheresi
Eszter Csillag – Paolo Serafini Giacomo Favretto E Tamás Szana. Collezionisti E artisti tra Italia E UngHeria La prima metà dell’Ottocento, nella storia ungherese, prende il nome di “epoca delle riforme”. In questo periodo fra l’Italia settentrionale e l’Ungheria degli Asburgo, avviene uno scambio culturale intenso, che favorirà la presenza in Ungheria di Giacomo Favretto. L’assenza di un’Accademia di Belle Arti obbligava gli artisti a recarsi a Vienna, oppure a frequentare quella di Monaco. Sarà l’Arci- duca Antonio Giuseppe Asburgo, nipote dell’imperatrice Maria Teresa, diventato Palatino d’Ungheria nel 1795, a modificare la situazione. Egli chiama a Pest il suo protetto, il veneziano Giacomo Marastoni1, sotto la cui direzione fonda nel 1846 la Prima Accademia Ungherese di Pittura. Per provare a conoscere la frequenza e l’importanza degli scambi culturali con Venezia è opportuno seguire la storia e la carriera di alcune figure. Il pit- tore italiano Luigi Rostagni2 giunge in Ungheria dopo la Rivoluzione magiara del 1848-493 con l’aiuto e il finanziamento del Principe István Károlyi. Insegna qui disegno e un suo allievo, Nándor Rákosi4, è particolarmente interessante per il 1 Giacomo Marastoni, pittore di origine italiana, figlio di Antonio Marastoni. Nel 1834 da Vienna si reca a Pozsony e da lì nel 1836 a Pest. Accanto a Miklós Barabás è uno dei ritrattisti più fecondi della sua epoca, e alla mostra del 1840 presenta venticinque ritratti. Il suo dipingere legge- ro, i colori caldi, la composizione armonica gli conferiscono popolarità. Nel 1846 fonda la prima Accademia ungherese di Pittura, primo ente promotore della formazione artistica magiara.