Def Thoracicus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
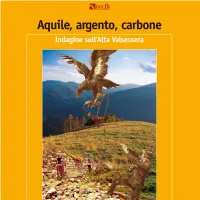
Aquile, Argento, Carbone Indagine Sull'alta Valsessera
Aquile, argento, carbone Indagine sull’Alta Valsessera catalogo a cura di GIOVANNI VACHINO “Fabbrica della ruota”, Pray Biellese - 2007 © DocBi - Centro Studi Biellesi 2007 via Marconi 26a, 13900 Biella www.docbi.it [email protected] grafica: DocBi - Centro Studi Biellesi in collaborazione con Eventi & Progetti Comunicazione copertina: Fabrizio Lava editing: Marcello Vaudano dtp: Mauro Lampo fotografie: Archivio Antropologia Alpina, Lucio Bordignon, Nicola Carrera, Archivio DocBi - Centro Studi Biellesi, Giuseppe Fabbris, Franco Grosso, Fabrizio Lava, Franco Lorenzini, Piero Monari, Cristina Natoli, Carlo Negri, Matteo Negro, Archivio Tiziano Pascutto, Alfonso Sella, Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, Piergiorgio Turri, Domenico Ubertalli, Giovanni Vachino, Archivio Enzo Vercella Baglione si ringraziano: Clerico Ballada, Carlo Bozzalla Pret, Danilo Craveia, Giuseppe Fabbris, Luigi Ghiardo, Roberto Ghiardo, Cristina Grosso, Franco Seletto, Sergio Trivero, Domenico Ubertalli, Marco Ubertalli, Gianni Valz Blin, Michele Venerato, Maurizio Vignazia Antropologia Alpina, Archivio di Stato di Biella, Archivio Storico del Comune di Trivero, Archivio di Stato di Torino, Comune di Pettinengo, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, Ermenegildo Zegna Holditalia spa si ringrazia il SITA-Provincia di Biella per la fornitura della cartografia di base stampa: Arti Grafiche Biellesi - Candelo (BI) Aquile, argento, carbone Indagine sull’Alta Valsessera Lucio Bordignon L’avifauna nidificante A distanza di un decennio, il DocBi mi ha affidato l’incarico Metodi di ripetere il censimento effettuato negli anni 1992-94. Lo scopo era quello di verificare se vi fossero stati cambiamenti Il territorio dell’Alta Valsessera è stato suddiviso in 101 set- significativi rispetto alla ricerca passata per quanto riguarda tori di 1 kmq ciascuno. -

Biellese, Terra Di Telai DOSSIER PRINCIPALE
[Digitare il testo] DOSSIER PRINCIPALE BIELLESE , PIANO DI SVILUPPO 2011 TERRA DI TELAI Biellese, terra di telai Parco diffuso del paesaggio industriale e della tradizione tessile. INDICE 1. TERRITORIO DI RIFERIMENTO A.1 inquadramento geografico generale del Biellese A.2 inquadramento demografico generale del Biellese B.1 Focus sul territorio interessato dal Progetto B.2 Specifiche del territorio interessato dal progetto rispetto al resto del territorio provinciale: paesi, Comunità montane. Musei, santuari 2. IL PROGETTO 2.1 Descrizione del progetto 2.2 Composizione del partenariato, reti e sinergie: pubblico e privato insieme per il territorio 2.3 Cronoprogramma 2.4 Quadri economici 1 BIELLESE , PIANO DI SVILUPPO 2011 TERRA DI TELAI Sezione 1 Caratteristiche del territorio di riferimento Provincia di Biella Abitanti al 31.12.2009 n. 186.698 Montagna 41% collina 43% pianura 16% 2 BIELLESE , PIANO DI SVILUPPO 2011 TERRA DI TELAI 3 BIELLESE , PIANO DI SVILUPPO 2011 TERRA DI TELAI A.1 Inquadramento geografico generale del Biellese Rilievi montagnosi sistemi vallivi : con i rilievi del monte Mars ad ovest (2600 m) e del monte Barone a nord-est (2044 m), l'arco montano racchiude a nord-ovest il territorio della provincia, presentando valori paesaggistici significativi e importanti valori di naturalità. Al limite settentrionale, l'alta Valle Sessera presenta la più ampia estensione di aree naturali e semi-naturali di tutta la provincia, con particolari caratterizzazioni vegetazionali per l'estensione del bosco e le varietà botaniche e faunistiche. Articolati a ventaglio attorno alla città di Biella e, più ad oriente, lungo l'asse pedemontano, i sistemi vallivi del biellese si caratterizzano per l'elevato livello di insediamento secondo modelli assai articolati. -
Sentieri Del Biellese Per L’Anno 2014
Sentieri del Biellese per l’anno 2014 proposti dalla Consociazione Amici dei Sentieri del Biellese NOTIZIARIO N. 31 MAGGIO 2014 Alpe Fontana Alpe la Tura Antico Albergo Mombarone Cappella Madonna della Neve alla Sella di Rosazza Cascata dell’Argentera Cascata dell’Irogna Redentore Colma-Mombarone Gita Casb al Cavajone Gita Casb al Lago Pistono Nuovo Rifugio Pianetti La giovane margara Mulattiera nei pressi di Desate Lago della Vecchia Lame del Sesia Le 5 croci al Pian della Ceva La Sella di Rosazza Locanda Piana del Ponte Lungo la mulattiera della Gragliasca Messa all’Alpe Finestre Molino Pianelli Panorama dall’Alpe Sette Fontane Pecore al pascolo Piane di Piedicavallo Ponte della Cua, Piedicavallo Rifugio Renata Rifugio Alpe Ponasca Rifugio Coda Rifugio Mombarone Rifugio Rosazza Rifugio Rivetti Rifugio Rosei San Giovannino San Grato, Quittengo Sommario Presentazione ............................................................... 2 Attività CASB .............................................................. 3 Ricordo di Leonardo .................................................... 5 I primi rifugi del CAI .................................................. 7 Storia del Bivacco sul Monte Bo .................................. 9 Traversata delle Alpi Biellesi ......................................... 11 Alta Via Alpi Biellesi .................................................... 16 Il Rifugio Rivetti ......................................................... 19 Dal Rifugio Rivetti al Lago della Vecchia ..................... 21 Il Rifugio della -

Geologic Map of the Southern Ivrea-Verbano Zone, Northwestern Italy
•usGsscience for a changing world Geologic Map of the Southern Ivrea-Verbano Zone, Northwestern Italy By James E. Quick,1 Silvano Sinigoi,2 Arthur W. Snoke,3 Thomas J. Kalakay,3 Adriano Mayer,2 and Gabriella Peressini2·4 Pamphlet to accompany Geologic Investigations Series Map I- 2776 1U. S. Geological Survey, Reston, VA 20192- 0002. 2Uni versita di Trieste, via Weiss 8, 341 27 Trieste, ltalia. 3Uni versity of Wyoming, Larami e, WY 8207 1- 3006. 4Max-Planck-lnstitut ft.ir Chemi e, J.J. Becherweg 27, 55 128 Mainz, Germany. 2003 U.S. Department of the Interi or U.S. Geological Survey COVER: View of the Ponte della Gula, an ancient bridge spanning the Torrente Mastellone approximately 2 kilometers north of the village of Varallo. Diorite of Valsesia crops out beneath the bridge. Photograph by ADstudia, Silvana Ferraris, photographer, Pizza Calderini, 3-13019 Varallo Sesia ([email protected]) INTRODUCTION REGIONAL SETTING The intrusion of mantle-derived magma into the deep conti The Ivrea-Verbano Zone (fig. 1) is a tectonically bounded sliver nental crust, a process commonly referred to as magmatic of plutonic and high-temperature, high-pressure metamorphic underplating, is thought to be important in shaping crustal com rocks in the southern Alps of northwestern Italy (Mehnert, position and structure. However, most evidence for this process 1975; Fountain, 1976). To the northwest, it is faulted against is indirect. High P-wave velocities and seismic-reflection profiles the basement of the Austro-Alpine Domain by the lnsubric Line, reveal that much of the deep continental crust is dense and a major suture zone that separates the European and Apulian strongly layered, consistent with the presence of layered mafic plates (Schmid and others, 1987; Nicolas and others, 1990). -

Bocchetto Sessera
SORPRENDENTI ALPI BIELLESI ASTONISHING BIELLA ALPS www.alpibiellesi.eu TERRITORY Monte Mars Oasi Zegna 2.600 m Monte Mucrone 2.335 m Monte Rosso Monte Marca Monte Barone Colma di Mombarone Punta della Balma Cima di Bo 1.616 m 2.044 m 2.371 m Monte Camino 2.556 m Monte Bechit Monte Tovo Punta del Cravile Cima dell’Asnas Monticchio Rocca dell’Argimonia Monte Rovella Monte Rosa Piramide Vincent Punta Gnifetti Dufourspitze Netro Graglia Sordevolo Oropa Burcina Rosazza Tavigliano Cossato Portula Campiglia Cervo Biella Candelo Bielmonte Trivero Coggiola Sostegno Veglio Piatto Collina della Serra Andorno Micca Brughiera Valle dell’Elvo Valle Oropa Valle Cervo Val Sessera e Valle Strona Come arrivare How to reach A8 Milano-Laghi A4 Milano-Torino A5 Torino-Aosta A26 Genova-Gravellona USCITE/EXITS USCITE/EXIT USCITA/EXIT Santhià Quincinetto Romagnano Sesia Carisio 2 TERRITORIO TERRITORY Monte Mars Oasi Zegna 2.600 m Monte Mucrone 2.335 m Monte Rosso Monte Marca Monte Barone Colma di Mombarone Punta della Balma Cima di Bo 1.616 m 2.044 m 2.371 m Monte Camino 2.556 m Monte Bechit Monte Tovo Punta del Cravile Cima dell’Asnas Monticchio Rocca dell’Argimonia Monte Rovella Monte Rosa Piramide Vincent Punta Gnifetti Dufourspitze Netro Graglia Sordevolo Oropa Burcina Rosazza Tavigliano Cossato Portula Campiglia Cervo Biella Candelo Bielmonte Trivero Coggiola Sostegno Veglio Piatto Collina della Serra Andorno Micca Brughiera Valle dell’Elvo Valle Oropa Valle Cervo Val Sessera e Valle Strona Caselle Santhià-Biella Linate Novara-Biella Malpensa www.alpibiellesi.eu TERRITORIO TERRITORY 3 TERRITORY Sorprendenti ALPI BIELLESI Le Alpi Biellesi, con vette anche fino ai 2.000 mt, inPiemonte costituiscono un gruppo montuoso situato nella zona sud-orientale delle Alpi Pennine è caratteriz- zato dalla linea Insubrica, una frattura geologica provocata dallo scontro tra due antichi continenti (paleo-Africa e paleo-Europa) che attraversa tutto l’arco alpino. -

Rifu Gio A. Rive
Andorno Micca Andorno Comune di Comune La storia del rifugio “Alfredo Rivetti” Inquadramento geografico delle Alpi Biellesi Fiori qua e là... Valle del Cervo - La Bürsch La - Cervo del Valle Il C.A.I. di Biella già nel 1880 curò l’ampliamento della mulattiera da Piedicavallo alla Mologna; nel Le montagne che delimitano verso settentrione il Biellese costituiscono l’ampia termina zione di uno Salendo al Rifugio Rivetti da Piedicavallo, lungo la mulattiera, molteplici sono gli ambienti la cui Comunità Montana Comunità 1909 iniziò ad accantonare fondi per la costruzione di un rifugio, disegnato da Lincoln Valz Blin. dei maggiori contrafforti che si dipartono dal gruppo del Monte Rosa. Questa dorsale ha origine dalla atmosfera ci pervade: dapprima il villaggio con i suoi vicoli stretti e pieni di luci e ombre improvvise, Grazie ad un nuovo progetto, nel dopoguerra il 3 luglio 1921 s’inaugurò a monte dell’Alpe Pianel, Piramide Vincent e nel primo tratto separa la valle di Gressoney (o del Lys) dalla Valsesia, allungandosi con i suoi muri robusti di buon granito; poi il bosco, col torrente che rumoreggia in basso; quindi Sezione di Biella di Sezione a quota 1850 m, il rifugio dedicato ad Alfredo Rivetti, morto tragicamente, travolto da una valanga in direzione Sud con andamento pressochè rettilineo fi no alla Punta Tre Vescovi (2501 m), vetta, posta il terreno tipico della montagna biellese, con l’alternarsi degli ammassi di grosse pietre e dei magri CLUB ALPINO ITALIANO ITALIANO ALPINO CLUB con l’amico Giovanni Edelmann, il 23 dicembre 1911, nei pressi della Mologna Grande. -

I Sentieri Della Libertà
i luoghi della memoria ENRICO PAGANO I sentieri della libertà Itinerari biellesi della Resistenza Descrizione del territorio fenomeni di immigrazione dall’area vene- ta negli anni trenta, da una fascia che com- Il territorio della provincia di Biella si prende le aree di confine a settentrione e a estende per circa 30 km da ovest a est e per occidente a vocazione artigianale e prima- 40 km da nord a sud; confina a nord e a ria, interessata da fenomeni migratori ver- nord-est con la Valsesia; il limite orienta- so Francia, Svizzera e l’area torinese; la le, nella parte rimanente, attraversa il terri- pianura irrigua e le vaste zone di baraggia, torio della Baraggia vercellese; a ovest il di non uniformi strutture economiche e confine lambisce il territorio di Gressoney, sociali, sono state influenzate storicamen- in Valle d’Aosta, e il Canavese; il confine te dalle vicende agrarie del Vercellese. meridionale, di carattere amministrativo, è Al centro di questo sistema è Biella, il posto nella pianura risicola, lungo una li- capoluogo, che ha sviluppato una vocazio- nea parallela al tratto dell’autostrada Tori- ne economica industriale di rilievo, unita no-Milano compreso tra i caselli di Santhià ad una notevole caratterizzazione terziaria. e Balocco. Oggi la provincia di Biella si caratterizza All’interno di quest’area, oltre alla parte per l’economia articolata, in cui la voca- pianeggiante, si possono distinguere, nel zione industriale e terziaria si accompagna senso longitudinale, un settore orientale, allo sviluppo del turismo ambientale e re- occupato dalla valle Sessera e dalla valle ligioso, particolarmente incentrato sul ri- Mosso, uno centrale, che comprende la valle chiamo del distretto balneare del lago di del Cervo e la conca di Oropa che sovrasta Viverone, delle aree protette, quali i parchi il capoluogo, e uno occidentale, in cui si della Bessa, della Burcina, delle Baragge trovano la valle dell’Elvo e la Serra. -

PFA Sessera Relazione Versione Approvata
SETTORE GESTIONE PROPRIETÀ FORESTALI REGIONALI E VIVAISTICHE SETTORE POLITICHE FORESTALI PROPRIETA’ DEMANIALE REGIONALE DELLA “VAL SESSERA” (Province di Biella e Vercelli) PIANO FORESTALE AZIENDALE 2004 - 2013 P.S.R. Regionale 2000-2006 Azione T, misura T2 Lavoro realizzato da Corso Casale, 476 - 10132 TORINO www.ipla.org - [email protected] 1 2 IPLA S.p.A. Corso Casale 476 10132 - TORINO Tel.: 011-8998933; e-mail: ipla.org www.ipla.org e-mail: [email protected] Coordinamento Paolo Camerano Indagine catastale Giuseppe Bertetti Rilievi forestali e descrizione particellare Paolo Camerano, Fabio Giannetti, Franco Gottero, Cristina Grieco Impostazione gestionale Pier Giorgio Terzuolo Aspetti naturalistici Roberto Sindaco Viabilità forestale e protezione dagli incendi Franco Gottero Allestimento cartografie di piano Susanna Gramaglia I dati cartografici e dendrometrici di base, per la redazione del presente Piano, sono stati rilevati dal Gruppo di lavoro incaricato della redazione del Piano Forestale Territoriale dell’Area Forestale n. 41. Alta e Bassa Valle Cervo, Valle Mosso, Valle Sessera, Prealpi Biellesi, coordinato dalla Dott.sa Forestale Roberta Benetti (STUDIO GESTER). 3 INDICE INTRODUZIONE...............................................................................................................................7 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....................................................................9 1.1 Norme forestali e paesistiche, accordi internazionali.................................................................