Al Tempo Di Verdi Di Marcello Conati
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Komponist Und Dirigent: Verdi Und Mariani Skladatelj in Dirigent: Verdi in Mariani
M. WALTER • KOMPONIST UND DIRIGENT ... UDK 78.071.1Verdi:78.071.2Mariani DOI: 10.4312/mz.51.1.69-84 Michael Walter Oddelek za muzikologijo, Univerza v Gradcu Department for Musicology, University of Graz Komponist und Dirigent: Verdi und Mariani Skladatelj in dirigent: Verdi in Mariani Prejeto: 2. februar 2015 Received: 2nd February 2015 Sprejeto: 31. marec 2015 Accepted: 31st March 2015 Ključne besede: Giuseppe Verdi, Angelo Mariani, Keywords: Giuseppe Verdi, Angelo Mariani, Pietro Pietro Romani, direttore d’orchestra, maestro con- Romani, Direttore d’orchestra, Maestro concerta- certatore, dirigent tore, Dirigent IZVLEČEK ABSTRACT Zelo verjetno je, da je Verdi vodil vaje – kot mae- It is very likely that Verdi rehearsed the vocal stro concertatore – za péte dele svoje prve opere parts of his first opera Oberto (1839) as maestro Oberto (1839). Vendar pa ni imel vpliva na prvo concertatore. However, he had no influence on the uprizoritev, saj je to vodil prvi violinist oz. direttore first performance, since the performances were d’orchestra. V štiridesetih letih 19. stoletja, zlasti s led by the first violinist or direttore d’orchestra. Pietrom Romanijem in Angelom Marianijem, se In the 1840s began, especially with Pietro Romani je začel pojavljati pojem sodobnega dirigenta, ki and Angelo Mariani, the emergence of the modern je združil obe funkciji (maestro concertatore in conductor, who combined the maestro concerta- direttore d’orchestra) v eni osebi. Verdi je menil, da tore and direttore d’orchestra in one single person. je takšen dirigent najbolj primeren za postavljanje In Verdi’s opinion such a conductor was the best njegovih del. Toda Verdi je bil kaj kmalu razočaran, way to realize his scores. -

Giacomo Zucchi
Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” Direttore onorario M° Riccardo Muti Presidente Dott.ssa Marida Dentamaro Direttore M° Gianpaolo Schiavo Direttore amministrativo Dott.ssa Anna Maria Sforza Produzione artistica del Conservatorio “Niccolò Piccinni” Referenti del progetto: Paolo Messa, Maurizio Lomartire Équipe del progetto: Paolo Messa, Maurizio Lomartire, Pasquale Lepore, Federico Biscione Un sentito ringraziamento al M° Vincenzo Anselmi per aver contribuito ad incrementare il repertorio per ensemble di viole. INTRODUZIONE È stato sufficiente un solo anno di assenza per far sentire, a noi docenti e ai nostri allievi, la sua mancanza. Fortunatamente il positivo riscontro ottenuto dalle edizioni 2014 e 2015 ha consentito che il nostro Conservatorio accogliesse nuovamente il progetto ViolaFest nell’ambito delle attività di produzione artistica e di ricerca. Al pari delle precedenti edizioni e, come sempre, in sinergia con l’Associazione Italiana della Viola (AIV), il ViolaFest si pone l’obiettivo della promozione e diffusione della viola, del suo repertorio e della sua didattica attraverso una serie di eventi - Masterclass, concerti, tavole rotonde - che mirano principalmente all’aggregazione tra studenti, strumentisti e docenti di viola affermati in ambito nazionale e internazionale. In linea con questa impostazione, l’edizione 2017, intitolata “La Viola Italiana”, vedrà la partecipazione di Anna Serova e Luca Sanzò, solisti di celebrata fama, e di Alessandro Cusatelli, compositore che al nostro strumento ha dedicato un concerto già entrato a pieno diritto nel grande repertorio violistico. L’ argomento scelto come traccia per quest’anno ci darà, fra l’altro, l’allettante opportunità di condividere con pubblico e colleghi la sorpresa che abbiamo provato nel recupero di composizioni cadute nell’oblio e che invece meriterebbero, come tantissime altre opere del repertorio strumentale dell’800 e ‘900 italiano ancora sepolte nella polvere delle biblioteche, una assai più dignitosa considerazione. -

Giuseppe V Erdi | Messa Da R Equiem | Dimanche 15 No Vembre
DIMANCHE 15 NOVEMBRE – 20H Giuseppe Verdi Messa da Requiem Orchestra e Coro del Teatro alla Scala Daniel Barenboim, direction Barbara Frittoli, soprano Sonia Ganassi, mezzo-soprano Jonas Kaufmann, ténor Kwangchul Youn, basse | dimanche 15 novembre Bruno Casoni, chef de chœur Messa da Requiem Messa | Fin du concert vers 21h30. Giuseppe Verdi Verdi Giuseppe Giuseppe Verdi (1813-1901) Messa da Requiem, pour soli, chœur mixte et orchestre 1. Requiem e Kyrie (chœur, solistes) 2. Dies iræ (chœur) – Tuba mirum (chœur, basse) – Liber scriptus (mezzo–soprano, chœur) – Quid sum miser (soprano, mezzo-soprano, ténor) – Rex tremendae (solistes, chœur) – Recordare (soprano, mezzo-soprano) – Ingemisco (ténor) – Confutatis (basse) – Lacrimosa (solistes, chœur) 3. Offertorium (solistes) 4. Sanctus (double chœur) 5. Agnus Dei (soprano, mezzo-soprano, chœur) 6. Lux æterna (mezzo-soprano, ténor, basse) 7. Libera me (soprano, chœur) Composition : 1873-1874. Création : le 22 mai 1874 en l’église San Marco de Milan sous la direction du compositeur. Durée : environ 1h25. Lorsque meurt Rossini, le 13 novembre 1868, Verdi se montre très touché. Il lance auprès de son éditeur, Tito Ricordi, l’idée d’un Requiem à sa mémoire écrit par dix sommités musicales italiennes et exécuté le jour anniversaire de sa disparition, en son fief de Bologne. Lui-même s’octroie le finale, le Libera me. La Messe pour Rossini est composée, mais diverses raisons font échouer son exécution. Elle vivra cependant au travers de la Messa da Requiem, dans laquelle Verdi reprend tout naturellement le fragment inutilisé. Dès l’abandon du projet de la Messe pour Rossini, Verdi envisage d’écrire un Requiem. -

From the Glicibarifono to the Bass Clarinet.Pdf
From the Glicibarifono to the Bass Clarinet: A Chapter in the History of Orchestration in Italy* Fabrizio Della Seta From the very beginnings of opera, the work of the theatre composer was carried out in close contact with, if not founded upon, the performer. At least until half-way through the nineteenth century, a composer would be judged in large part on his ability to make best use of the vocal resources of the singers for whom he was writing in a given season, to model his music on their individual qualities in the same way as (in terms of an often- repeated image) a tailor models the suit to the contours of his client's body, or (to use a more noble comparison) as a sculptor exploits the particular material characteristics of a block of marble. Even Verdi at the time of his greatest prestige, when he was in a position to impose his dramatic ideas in an almost dictatorial manner, drew inspiration from the abilities of respected performers, e.g. from Teresa Stolz for Aida or Giuseppina Pasqua for Falstaff. To a less decisive extent, but according to a concept similar in every respect, the same principle had been applied to the instrumental aspect of opera since the early decades of the eighteenth century, when the orchestra began to assume growing importance in the structure of a work. Often the presence in the theatre orchestra of a gifted instrumentalist would lead the composer to assign to him a prominent solo, almost always as if competing with voice as an obbligato part, and there were cases in which instrumentalist and composer coincided, as happened in certain operas by Handel. -

Spielpraxis Der Saiteninstrumente in Der Romantik Bericht Des Symposiums in Bern, 18.–19
Spielpraxis der Saiteninstrumente in der Romantik Bericht des Symposiums in Bern, 18.–19. November 2006 Herausgegeben von Claudio Bacciagaluppi, Roman Brotbeck und Anselm Gerhard Edition Argus Diese PDF-Version ist seitenidentisch mit dem gedruckten Buch, das 2011 in der Edition Argus erschienen ist. Für die PDF-Version gelten dieselben Urheber- und Nutzungsrechte wie für das gedruckte Buch. Dies gilt insbesondere für Abbildungen und Notenbeispiele. Das heißt: Sie dürfen aus der PDF-Version zitieren, wenn Sie die im wissenschaftlichen Bereich üblichen Urheberangaben machen. Für die Nutzung von Abbildungen und Notenbeispielen müssen Sie gegebenenfalls die Erlaubnis der Rechteinhaber einholen. Musikforschung der Hochschule der Künste Bern Herausgegeben von Roman Brotbeck Band 3 Spielpraxis der Saiteninstrumente in der Romantik Bericht des Symposiums in Bern, 18.–19. November 2006 Herausgegeben von Claudio Bacciagaluppi, Roman Brotbeck und Anselm Gerhard Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung Inhalt Vorwort 7 Daniel Leech-Wilkinson Early recorded violin playing: evidence for what? 9 Marianne Rônez Pierre Baillot, ein Geiger an der Schwelle zum 19. Jahrhundert. Ein Vergleich seiner Violinschulen von 1803 und 1835 23 Rudolf Hopfner Nicolaus von Sawicki – Paganinis Geigenbauer in Wien 58 Robin Stowell Henryk Wieniawski: »the true successor« of Nicolò Paganini? A comparative assessment of the two virtuosos with particular reference to their caprices 70 Heinz Rellstab und Anselm Gerhard »Möglichst zugleicherklingend« – »trotz unsäglicher Mühe«. Kontroversen um das Akkordspiel auf der Geige im langen 19. Jahrhundert 91 Beatrix Borchard Programmgestaltung und Imagebildung als Teil der Aufführungspraxis: Joseph Joachim 106 Renato Meucci Changes in the role of the leader in 19th-century Italian orchestras 122 Claudio Bacciagaluppi Die »Pflicht« des Cellisten und der Generalbaß in der Romantik 138 Lucio A. -

Monografia Capitolo I
Capitolo I I PRIMI ANNI DI FORMAZIONE : L’ AMBIENTE MUSICALE BRESCIANO Sempre il primo capitolo è il più difficile da scrivere nella biografia di un artista, poiché è quello in cui si vorrebbe indagare sulle origini di un talento, se non talvolta di una genialità, che si mostrerà pienamente solo con gli sviluppi futuri: come se si cercasse la scintilla primigenia di un cammino spirituale in realtà individuabile solo una volta percorso, e si volesse identificarne una sia pur esile traccia proprio là dove esso ha avuto inizio. Questo è lo scopo di ogni ricerca riguardante i primi passi di coloro che poi ci hanno lasciato testimonianze per se stesse eloquenti. Poiché però indagare sui più reconditi meccanismi della creatività e della fantasia umana è ancora impresa troppo ardua per le conoscenze e gli strumenti in nostro possesso, per lo più ci si limita a studiare quali siano stati gli aspetti esteriori, le situazioni contingenti che hanno condizionato la crescita e l’evolversi di quel cammino, cercando di trovare in esse plausibili spiegazioni. Nel considerare la creazione di ogni espressione artistica, o comunque di ogni manifestazione dello spirito umano, qualunque essa sia, è in realtà sempre difficile valutare veramente quanto siano stati determinanti i condizionamenti dell’ambiente esterno, e quanto si tratti del frutto di un’interiorità autosufficiente che trova in se stessa motivi e spunti per manifestare la propria creatività; cioè quanto sia frutto di acquisizioni culturali e quanto sia invece come si suol dire ‘innato’, insito nella natura stessa della mente creatrice. Certo il concetto di ‘ispirazione’, tanto amato dai romantici, oggi non gode più di tanta fortuna, e gli studi critici si sforzano di dare alle manifestazioni artistiche spiegazioni sempre più razionali, cercandole nelle vicende storiche, nel gioco dei rapporti culturali, nelle occasioni contingenti, nei dati biografici 1. -
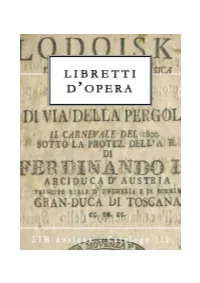
LIBRETTI-111.Pdf
1. Giulio Alary ! 1! 1. Giulio Alary (Mantova 1814 - Parigi 1891) Rosmunda. Melodramma tragico in due atti da rappresentarsi nell’I. e R. Teatro dei sigg. Accademici Immobili in via della Pergola la primavera del 1840. Firenze, G. Galletti [1840]. 24 pp. in-16. Libretto di Cassiano Zaccagnini. Elenco completo degli orchestrali, addetti ai lavori e interpreti (Giuseppina Strepponi nel ruolo di Rosmunda). Prima edizione con gli interpreti della prima rappresentazione, andata in scena il 10 giugno 1840. Cop. edit. con ex-libris Pieri Gerini applicato al piatto sup. Catalogo al piatto inf. Ottimo esemplare, parzialmente intonso. € 120 2. Franco Alfano (Napoli 1875 - Sanremo 1954) Risurrezione. Dramma in quattro atti tratto dal romanzo di Leone Tolstoi. Parole di Cesare Hanau. Musica di Frank Alfano. Milano, Teatro alla Scala, stagione 1905- 06. Milano, Ricordi, T.S. 1906. Prima rappresentazione: Torino, Teatro Vittorio Emanuele, 30 novembre 1904. 50 pp. in-8. Dorso consunto, ma buono. € 20 3. Franco Alfano (Posillipo 1876 - Sanremo 1954) Risurrezione. Dramma in quattro atti tratto dal romanzo di Leone Tolstoi. Parole di Cesare Hanau. Milano, Ricordi [TS: 2/33].Prima rappresentazione: Torino, Teatro Vittorio Emanuele, 30 novembre 1904. Cop. edit. a colori. 46 pp. in-12. Piccole mancanze all’ang. sup. sx delle prime pagine, peraltro buon esemplare. € 10 4. Ferdinando Asioli (Modena 1822 - Modena 1905) Maria de’ Ricci. Melodramma in tre atti di Giovanni Battista Fantuzzi musicato dal Maestro Ferdinando Asioli da rappresentarsi all’I. R. Teatro alla Scala nella stagione di carnevale 1858-59. Milano, tipografia di Paolo Ripamonti Carpano, 1859. 28 pp. in-8. Prima Edizione. -

The First Three Years of 'Trovatore'
Verdi Forum Number 15 Article 3 1-1-1987 The irsF t Three Years of 'Trovatore' Martin Chusid New York University Thomas G. Kaufman Follow this and additional works at: http://scholarship.richmond.edu/vf Part of the Musicology Commons Recommended Citation Chusid, Martin and Kaufman, Thomas G. (1987) "The irF st Three Years of 'Trovatore'," Verdi Forum: No. 15, Article 3. Available at: http://scholarship.richmond.edu/vf/vol1/iss15/3 This Article is brought to you for free and open access by UR Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in Verdi Forum by an authorized administrator of UR Scholarship Repository. For more information, please contact [email protected]. The irsF t Three Years of 'Trovatore' Keywords Giuseppe Verdi, Il trovatore This article is available in Verdi Forum: http://scholarship.richmond.edu/vf/vol1/iss15/3 The First Three Years of TROVATORE: A List of Staalngs from 19 January 1853 to 18 January 1856 Martin Chusid and Thomas Kaufman As Pierluigi Petrobelli suggests in the 19 January 1853 to 18 January 1856. first essay of this issue, studies in the A remarkable feature of many of the reception and diffusion of Verdi's operas are earliest stagings of Trovatore is the large relatively few and far between. Several number of individual performances in a have been undertaken by Marcello Conati: single season. At the Teatro Carlo Felice in 19th century stagings of Stiffelio (Quaderno Genoa, for example, during the Carnival 3 of the Istituto di Studi Verdiani, Parma, Lent Season beginning 26 December 1853, 1968); stagings of Aida from 1871-1881 there were fully 38 performances directed (Quaderno 4, 1971); "A chronology of the from the chair of the principal violinist, first performances of Rigoletto" (Bollettino 9 Angelo Mariani, then still playing the violin of the same Institute, 1982); and "Prime while leading the orchestra. -
![Produzione, Ricezione E Consumo Della Musica [Storia Dei Sistemi Produttivi Musicali] (Michele Girardi)](https://docslib.b-cdn.net/cover/2041/produzione-ricezione-e-consumo-della-musica-storia-dei-sistemi-produttivi-musicali-michele-girardi-7032041.webp)
Produzione, Ricezione E Consumo Della Musica [Storia Dei Sistemi Produttivi Musicali] (Michele Girardi)
Produzione, ricezione e consumo della musica [Storia dei sistemi produttivi musicali] (Michele Girardi) calendario e argomenti delle lezioni (aula 0D, lunedì, martedì, mercoledì, 15.45-17.15) settembre 2018 lunedì 23 1. Introduzione al corso 1 – 2 Un teatro è il cuore della città, esprime gusti e tendenze di chi vi ha abita, ed è quindi il centro pulsante della vita sociale. Nei suoi palchi si trattano affari, si fa politica, si conoscono persone nuove, si ospitano i viaggiatori, s’intrecciano amori, si mangia e beve, mentre nel foyer si gioca d’azzardo. In platea siedono (o stanno in piedi) servi dei nobili che stanno nei palchi e soldati, come si può vedere all’inizio di Senso (1954) dove viene ritratta la Fenice di Venezia, dovuto a un regista innamorato dell’opera, che tene- va alla descrizione fedele degli ambienti dei suoi film come LUCHINO VISCONTI – anche se non mancano gli anacronismi (la galleria dalla quale piovono i volantini antiaustriaci non esisteva ancora nel 1866, e in quell’anno il teatro era chiuso, in compenso il golfo mistico non era anco- ra nato). Siamo nei tempi in cui il repertorio in Italia non si era ancora formato (inizierà nella seconda metà dell’Ottocento), anche perché il pae- se restava diviso in comunità linguistiche, e il papato incombeva su gran parte della penisola. Mentre in Francia, dove il committente era lo Stato, anche se dopo la révolution la restaurazione aveva rimesso le cose appa- rentemente come stavano, la coscienza nazionale e l’impegno nell’allestimento dei lavori, avevano già tracciata la strada verso la mo- dernità. -

RICHARD WAGNER Born May 22, 1813 in Leipzig; Died February 13, 1883 in Venice
RICHARD WAGNER Born May 22, 1813 in Leipzig; died February 13, 1883 in Venice. Selections from Lohengrin (1845-1848) PREMIERE OF WORK: Weimar, August 28, 1850 Court Theater Franz Liszt, conductor APPROXIMATE DURATION: 18 minutes INSTRUMENTATION: three flutes, three oboes, English horn, three clarinets, bass clarinet, three bassoons, four horns, three trumpets, three trombones, tuba, timpani, percussion, harp and strings. Wagner based his libretto for Lohengrin on two 13th-century German sources — a poem by the knight Wolfram von Eschenbach (who appears as a character in Tannhäuser) and The Knight of the Swan by the Minnesinger (the German counterparts of the French troubadours) Conrad von Würzburg. In the opera, Lohengrin, son of Parsifal and a Knight of the Holy Grail, appears in 10th-century Antwerp to defend Elsa against a false accusation of murder. She is absolved of the charge, and Lohengrin consents to wed her on the condition that she does not inquire about his name or his past. After a magnificent marriage ceremony (the source of the familiar Wedding March — “Here Comes the Bride”), she asks the forbidden questions. Lohengrin reveals his name and his sacred mission to find the sacred chalice lost after it was used at the Last Supper, but leaves Elsa, who expires of her grief. The Prelude to Act III of Lohengrin is a brief burst of sunlight that serves as a foil to the pervasive seriousness of the work. It portrays the joy and expectation of Elsa and Lohengrin on the eve of their wedding. The Prelude is in a compact three-part form, beginning and ending with a jubilant, leaping theme in the low instruments that is heard nowhere else in the opera. -

Muzikološki Z B O R N I K L I
MUZIKOLOŠKI ZBORNIK MUSICOLOGICAL ANNUAL L I / 2 ZVEZEK/VOLUME L J U B L J A N A 2 0 1 5 MZ_2015_1_FINAL.indd 1 13.5.2015 12:44:22 Izdaja • Published by Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Glavni in odgovorni urednik • Editor-in-chief Jernej Weiss (Ljubljana) Asistentka uredništva • Assistant Editor Tjaša Ribizel (Ljubljana) Uredniški odbor • Editorial Board Matjaž Barbo (Ljubljana) Aleš Nagode (Ljubljana) Svanibor Pettan (Ljubljana) Leon Stefanija (Ljubljana) Andrej Rijavec (Ljubljana), častni urednik • honorary editor Mednarodni uredniški svet • International Advisory Board Michael Beckermann (Columbia University, USA) Nikša Gligo (University of Zagreb, Croatia) Robert S. Hatten (Indiana University, USA) David Hiley (University of Regensburg, Germany) Thomas Hochradner (Mozarteum Salzburg, Austria) Bruno Nettl (University of Illinois, USA) Helmut Loos (University of Leipzig, Germany) Jim Samson (Royal Holloway University of London, UK) Lubomír Spurný (Masaryk University Brno, Czech Republic) Katarina Tomašević (Serbian Academy of Sciences and Arts, Serbia) John Tyrrell (Cardiff University, UK) Michael Walter (University of Graz, Austria) Uredništvo • Editorial Address Oddelek za muzikologijo Filozofska fakulteta Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija e-mail: [email protected] http://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik Prevajanje • Translations Urban Šrimpf Cena posamezne številke • Single issue price 10 EUR Letna naročnina • Annual subscription 20 EUR Založila • Published by Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Za založbo • For the publisher Branka Kalenić Ramšak, dekanja Filozofske fakultete Tisk • Printed by Birografika Bori d.o.o., Ljubljana Naklada 300 izvodov • Printed in 300 copies Rokopise, publikacije za recenzije, korespondenco in naročila pošljite na naslov izdajatelja. Prispevki naj bodo opremljeni s kratkim povzetkom (200–300 besed), izvlečkom (do 50 besed), ključnimi besedami in kratkimi podatki o avtorju. -

Religión, Drama Y Espectáculo En I Lombardi Alla Prima Crociata De Verdi
Las Cruzadas, deconstruidas: religión, drama y espectáculo en I lombardi alla prima crociata de Verdi La extraordinaria carrera operística de Verdi se vio otra anécdota, Merelli invitó al compositor a que fuera él rodeada en un principio de unos cuantos enigmas, y las quien sugiriera sus propios honorarios por la nueva obra pruebas documentales conservadas apenas resultan (una historia que resulta tan deliciosa como poco plausible). suficientes para rastrear con claridad el ascenso a la fama del joven compositor en Milán. Entre otras cosas, no está Es muy poco lo que sabemos sobre la génesis y del todo claro por qué el empresario del Teatro alla Scala, el proceso creativo de la nueva ópera. Verdi volvió a Bartolomeo Merelli, se decidió a encargar una ópera en colaborar con Solera, que no sólo había escrito el libreto de 1839 a un compositor virtualmente desconocido. Y si Nabucco, sino que también había contribuido al de Oberto tenemos en cuenta que esa primera ópera, Oberto, conte y, quizás, a la revisión del de Un giorno di regno. Como di San Bonifacio, disfrutó de un éxito sólo moderado, no los dos se encontraban en la misma ciudad, y trabajando resulta fácil explicar por qué Merelli −según testimonios presumiblemente codo con codo, no se ha conservado biográficos posteriores y no verificados− contrató a Verdi ningún documento de su colaboración. Es muy posible que para que escribiera otras tres óperas para La Scala. La fuera Solera el encargado de elegir la fuente literaria para primera de aquellas tres óperas fue Un giorno di regno I lombardi alla prima crociata, un poema histórico a gran (1840), una opera buffa y un notorio fiasco en su momento.