Presentazionecorsi E Seminari 2008-2009
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

F:\DOC-VARI\PROGR\Pres Corsi\2006-07\Pres Corsi 06
INDICE DEI CORSI E SEMINARI [in ordine alfabetico per professori] Aletti Jean-Noël, S.J. [F.B.] TN5109 Problemi di teologia paolina EN5215 La lettera ai Filippesi. Approccio esegetico SN5108 Problemi di metodologia paolina Althann Robert, S.J. [F.O.] OA2203 Aramaico Targumico, corso introduttivo (B) OA1203 Aramaico biblico Arnold Leo, S.J. [F.O.] OR1101 Lingua e letteratura araba, corso introduttivo (A) OR2201 Lingua e letteratura araba, corso introduttivo (B) OR3101 Lingua e letteratura araba, corso superiore (C) OR4101 Lingua e letteratura araba, corso speciale Barbiero Gianni, S.D.B. [F.B.] EV2130 JHWH, Dio misericordioso e giusto: una lettura di Es 32–34 EV5228 Salmi scelti dal terzo libro del salterio (Sal 73–89) SV1218 La remissione dei debiti e la liberazione degli schiavi nell’Oriente Antico e nell’A.T. Bazyli½ki Stanis»aw, O.F.M.Conv. [F.B.– invit.] SM0102 Proseminario di metodologia (I sem.) SM0202 Proseminario di metodologia (II sem.) Bechard Dean, S.J. [F.B. – invit.] EN2134 The Lukan Journey Narrative (Lk 9,51– 19,44) Beutler Johannes, S.J. [F.B.] EV3226 Gv 18–21: Gesù ritorna al Padre SN5222 The Letter to Titus Biguzzi Giancarlo [F.B. – invit.] EN8120 «Il Trono, il rotolo e l’Agnello» (Ap 4,1–8,1) Pontificio Istituto Biblico – Corsi e seminari 2006-07 Bovati Pietro, S.J. [F.B.] MI1103 Ermeneutica biblica e metodi esegetici TV2201 Temi teologici del Deuteronomio SV4125 Testi scelti di Amos Crenshaw James L. [F.B. – invit.] EV5228 Ecclesiastes (Qoheleth) Dick Michael [F.B. – invit.] EV4130 The Book of the Twelve: Nahum, Zephaniah, Micah, and Jonah Di Luccio Giuseppe, S.J. -

Temple Israel Library
NEWELAZAR07252011 Introduction TEMPLE ISRAEL LIBRARY Is organized according to the Elazar Classification Scheme The Elazar classification scheme, first drafted in 1952 for use in the Library of the United Hebrew Schools of Detroit, Michigan, passed through several revisions and modifications and was originally published in 1962, The National Foundation for Jewish Culture assisting with the circulation of the incipient draft for comment and criticism. Wayne State University Libraries provided a grant-in-aid which prepared the manuscript for publication. The Second Edition, which was published in 1978, was revised on the basis of comments by the members of the Association of Jewish Libraries of Southern California. Rita B. Frischer and Rachel K. Glasser of Sinai Temple Blumenthal Library, and the Central Cataloging Service for Libraries of Judaica (CCS) in Los Angeles, assisted in the preparation and revision of the Third Edition. (See David H. Elazar, and Daniel J. Elazar, A Classification System for Libraries of Judaica, Northvale, N.J.: Jason Aronson Inc, 1997.) Its use has spread widely throughout the United States, Israel, and other parts of the Jewish world. Libraries of all kinds, in synagogues and community centers, in Hebrew schools. On college campuses and in research institutions, have adopted the scheme and worked with it. The system is structured around The following ten classes: 001-099 Bible and Biblical Studies 100-199 Classical Judaica: Halakhah and Midrash 200-299 Jewish Observance and Practice 300-399 Jewish Education 400-499 Hebrew, Jewish Languages and Sciences 500-599 Jewish Literature (including Fiction and Children‟s Literature) 600-699 The Jewish Community: Society and the Arts 700-799 Jewish History, Geography, Biography 800-899 Israel and Zionism 900-999 General Works ELAZAR CLASSIFICATION SYSTEM 001---099 Bible and Biblical Studies Torah, Apocrypha, Pseudepigrapha 001 Complete Bible .1 Art, Rare, Special Editions .2 Hebrew with translation .5 Polyglot Bibles .8 Combined “Old Testament” and “New Testament” The Holy Scriptures. -

JEWS, GOD, and HISTORY HISTORY REVISED and UPDATED EDITION REVISED and UPDATED EDI- Max I
Max I. Dimont OTHER BOOKS BY MAX I. DIMONT Appointment in Jerusalem The Indestructible Jews JEWS, GOD, AND The Jews in America The Amazing Adventures of the Jewish People JEWS, GOD, AND HISTORY HISTORY REVISED AND UPDATED EDITION REVISED AND UPDATED EDI- Max I. Dimont TION A MENTOR BOOK A MENTOR BOOK 1 2 A CIVILIZATION IS BORN, REACHES ITS MATURITY, Jews in America, The Amazing Adventures of the Jewish People, AND, DIES. THIS IS THE PATTERN OF HISTORY. SO IT and Appointment in Jerusalem, was born in Helsinki, Finland, WAS WITH THE BABYLONIANS, THE PERSIANS, THE RO- and came to the United States in 1930. He taught himself English MANS. WHY NOT THE JEWS? by reading Shakespeare's plays, the Bible, and American plays How have the Jews survived throughout four thousand years translated into Finnish. After serving in intelligence with the U.S. of human history? Why has this small' band of people continued Army during World War II, he worked in public relations and to exert such influence on so many civilizations? From their employee relations for Edison Brothers Stores in St. Louis. Fol- ranks have come Moses, Christ, Spinoza, Marx, Freud, Einstein. lowing the first publication of his bestselling Jews, God, and What is the vitality that flames among the Jewish people, con- History, he lectured extensively on Jewish history throughout the trary to every historical precedent? United States, Canada, South Africa, Brazil, and Finland until his Max Dimont asks and answers these questions in his en - death in 1992. grossing, trenchant survey, now completely revised and updated. -

Catalogue of the Bill Williams Library
CATALOGUE OF THE BILL WILLIAMS LIBRARY Created by Lawrence Rabone Edited by Marton Ribary Note on use: Titles are arranged in thematic sections given in bold after all entries. The section indicates the physical location of the individual entry in the collection. Catalogue of the Bill Williams Library Centre for Jewish Studies The University of Manchester A Abella, Irving M., and Harold Martin Troper. None Is Too Many: Canada and the Jews of Europe, 1933-1948. Toronto, Canada: Lester & Orpen Dennys, 1983. Jewish History: Britain. Abraham bar, Hayya. The Meditation of the Sad Soul. Translated by Geoffrey Wigoder. The Littman Library of Jewish Civilization. edited by David Goldstein and Louis Jacobs London: Routledge & Kegan Paul, 1969. Religion, Philosophy, Thought. Abrahams, Israel. The Book of Delight and Other Papers. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1912. Religion, Philosophy, Thought. ———. By-Paths in Hebraic Bookland. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1920. Religion, Philosophy, Thought. ———. Jewish Life in the Middle Ages. London: Macmillan & Co., 1896. General Jewish History. ———. A Short History of Jewish Literature: From the Fall of the Temple (70 C.E.) to the Era of Emancipation (1786 C.E.). London: T. Fisher Unwin, 1906. Literature. ———. Some Permanent Values in Judaism. Four Lectures. Oxford: Clarendon Press, 1924. Religion, Philosophy, Thought. Abrahams, Israel, and Claude G. Montefiore. Aspects of Judaism: Being Eighteen Sermons. London and New York: Macmillan, 1895. Religion, Philosophy, Thought. Abrahams, Israel, and Cecil Roth. Jewish Life in the Middle Ages. New Edition, Enlarged and Revised on the Basis of the Author's Material by Cecil Roth. ed. London: Edward Goldston, 1932. -
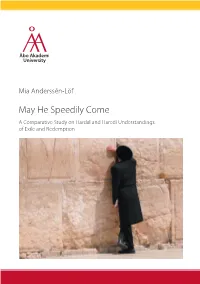
Mia Anderssén-Löf He Speedily Comemia | May – a Comparative Study on Hardal and Haredi | 2017 Understandings of Exile and Redemption
Mia Anderssén-Löf | May He Speedily Come – A Comparative Study on Hardal and Haredi Understandings of Exile and Redemption | 2017 and Haredi Study on Hardal – A Comparative | MayMia He Speedily Come Anderssén-Löf Mia Anderssén-Löf May He Speedily Come A Comparative Study on Hardal and Haredi Understandings of Exile and Redemption 9 789517 658799 ISBN 978-951-765-879-9 Mia Anderssén-Löf (born 1984) Master’s degree in Theology (2009) specializing in Jewish studies. Åbo Aka- demi University. Cover photo: ”At Western Wall” by JD Lasica, April 16, 2008, is licensed under CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ https://www.flickr.com/photos/jdlasica/ Åbo Akademi University Press Domkyrkogatan 2–4, FI-20500 Åbo, Finland Tel. +358 (0)2 215 4190 E-mail: [email protected] Sales and distribution: Åbo Akademi University Library Domkyrkogatan 2–4, FI-20500 Åbo, Finland Tel. +358 (0)2 -215 4190 E-mail: [email protected] MAY HE SPEEDILY COME May He Speedily Come A Comparative Study on Hardal and Haredi Understandings of Exile and Redemption Mia Anderssén-Löf Åbo Akademis förlag | Åbo Akademi University Press Åbo, Finland, 2017 CIP Cataloguing in Publication Anderssén-Löf, Mia. May he speedily come : a comparative study on Hardal and Haredi under- standings of exile and redemption / Mia Anderssén-Löf. - Åbo : Åbo Akademi University Press, 2017. Diss.: Åbo Akademi University. ISBN 978-951-765-879-9 ISBN 978-951-765-879-9 ISBN 978-951-765-880-5 (digital) Painosalama Oy Åbo 2017 Acknowledgments Conducting this study has been a long process, involving many people in different capacities. -

Who Were the Phoenicians ? Nissim
WHO WERE THE PHOENICIANS ? NISSIM. R. GANOR I II WHO WERE THE PHOENICIANS ? NISSIM R. GANOR KIP – Kotarim International Publishing LTD III WHO WERE THE PHOENICIANS? NISSIM R. GANOR © All rights reserved to the author No part of this book may be translated, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information, storage and retrieval systems, without written permission from the author. KIP - Kotarim International Publishing ltd www.kotarim.com Design: Daphna Ganor Rachel Shamir ISBN: 978-965-91415-2-4 Printed in Israel IV is book is dedicated to my friend, partner and spouse Magda, whose unlimited devotion and support made this research possible. To my late parents Avraham D. and Simcha Mizrachi Alehem Hashalom. And last, to my sons – Elon ,Ido and their families. V VI ACKNOWLEDGMENTS I would like to express my gratitude to the management and employees of the 'Eretz Israel' Museum library for all their assistance. Many thanks to the management of the Rockefeller Museum and specifically to Mrs. Cassuto. I would also like to extend my thanks to Mr. Regulant who helped me at different stages of my research. anks to Mr. Norbert Segal for the photographs he provided. Special thanks are due to Mr. Heineman, formerly the manager of the 'Eretz Israel' museum library, and to Mrs. Rebecca Twaig who both edited the English translation at different stages. To my granddaughter Daphna Ganor for her work and dedication on the graphics editing of this book and to my grandson Ori Ganor for his help with editing work. -
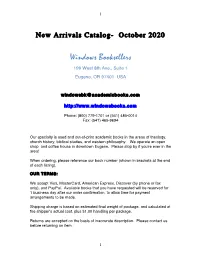
October-2020-Web-Catalog-1
1 New Arrivals Catalog- October 2020 Windows Booksellers 199 West 8th Ave., Suite 1 Eugene, OR 97401 USA [email protected] http://www.windowsbooks.com Phone: (800) 779-1701 or (541) 485-0014 Fax: (541) 465-9694 Our specialty is used and out-of-print academic books in the areas of theology, church history, biblical studies, and western philosophy. We operate an open shop and coffee house in downtown Eugene. Please stop by if you're ever in the area! When ordering, please reference our book number (shown in brackets at the end of each listing). OUR TERMS: We accept Visa, MasterCard, American Express, Discover (by phone or fax only), and PayPal. Available books that you have requested will be reserved for 1 business day after our order confirmation, to allow time for payment arrangements to be made. Shipping charge is based on estimated final weight of package, and calculated at the shipper's actual cost, plus $1.00 handling per package. Returns are accepted on the basis of inaccurate description. Please contact us before returning an item. 1 2 New Arrivals October 2020 Table of Contents Archaeology & Ancient Near East 3 Bibles 7 Biblical Interpretation 7 Church History 20 Classics 28 Commentaries- New Testament 29 Commentaries- Old Testament 35 Concise Commentaries 56 Devotional 57 Greek 58 Hebrew 61 History 74 History of Missions 76 Judaica 76 Literary Criticism 78 Literature 79 Ministry & Christian Living 79 New Testament 80 Old Testament 92 Philosophy 121 Poetry 126 Preaching 126 Reference 127 Sociology 130 Theology 131 World Religions 157 2 3 ARCHAEOLOGY & ANCIENT NEAR EAST Abegg, Martin, Jr., Peter Flint and Eugene Ulrich. -

Construction of Identity in Anglophone Israeli Literature
Representations & Reflections Studies in Anglophone Literatures and Cultures Volume 10 Edited by Uwe Baumann, MarionGymnich and Barbara Schmidt-Haberkamp Nadezˇda Rumjanceva Roots in the Air ConstructionofIdentity in Anglophone Israeli Literature With 2figures V&Runipress Bonn UniversityPress Bibliographic informationpublishedbythe Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available online:http://dnb.d-nb.de. ISSN 2198-5448 ISBN 978-3-8471-0429-2 ISBN 978-3-8470-0429-5 (E-Book) ISBN 978-3-7370-0429-9 (V&ReLibary) Yo ucan find alternativeeditionsofthis book and additionalmaterial on our website:www.v-r.de Publications of Bonn University Press are published by V& Runipress GmbH. Printed with the supportofthe Förderungs- und Beihilfefonds Wissenschaftder VG WORT / Gedruckt mit Unterstützung des Förderungs-undBeihilfefonds Wissenschaft der VG WORT. 2015byV&Runipress GmbH, 37079Goettingen,Germany All rights reserved. No partofthisworkmay be reproduced or utilized in anyformorbyany means, electronic or mechanical, including photocopying, recording,orany informationstorage andretrieval system, withoutprior written permissionfromthe publisher. Printed in Germany. Coverimage:Evyatar Dayan Printedand boundbyaHubert & Co,Göttingen. Printed on aging-resistantpaper. Contents 1. Introduction ............................... 9 2. Cultures in Flux and the Flexible Selves ................ 17 2.1. Identity,Hybridity, Transculturality .............. -

New Items – November 2015 Ebooks and Electronic Theses Are
New Items – November 2015 Ebooks and Electronic Theses are displayed as [electronic resource] Including books from previous years in special collections added to the Music Library Wilson, Beata E author. Characterization of predicting factors in posttraumatic growth among Holocaust survivors [electronic resource] : a qualitative study / by Beata E. Wilson. 2014 (002412044 ) Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Psychological aspects. Holocaust survivors -- Attitudes. Psychic trauma -- Case studies. Life change events -- Psychological aspects. Adjustment (Psychology) Resilience (Personality trait) Self-actualization (Psychology) Hajer, Maarten A., 1962- author. The politics of environmental discourse [electronic resource] : ecological modernization and the policy process / Maarten A. Hajer. Oxford : Clarendon Press, 2002 (002412062 ) Environmental policy. Ecology. Economic development -- Environmental aspects. Hazut, Noa author. Nitric oxide (NO) effects on appetitive behaviors in satiated rats / [electronic resource] / Noa Hazut. 2015 (002412733 ) Nitric oxide -- Physiological effect. Bar Ilan University -- Dissertations -- Department of Life Sciences Rats as laboratory animals. .הפקולטה למדעי החיים --אוניברסיטת בר-אילן -- עבודות לתאר שני Mashriki, Tal author. Nanoparticle homeostasis in proliferating mammalian cells [electronic resource] / Tal Mashriki. 2015 (002414983 ) Homeostasis. Bar Ilan University -- Dissertations -- Department of Life Sciences .אוניברסיטת בר-אילן -- עבודות לתאר שני -- הפקולטה למדעי החיים Raisken, Sheffi author. Achilles -

New Items – October 2017 Ebooks and Electronic Theses Are
New Items – October 2017 Ebooks and Electronic Theses are displayed as [electronic resource] Including books from previous years in special collections added to the Music Library Fort, Anat composer. Four musical compositions [electronic resource] 2010. (002451762 ) Bar Ilan University -- Dissertations -- Department of Music .אוניברסיטת בר-אילן -- עבודות לתאר שני -- המחלקה למוסיקה Geller, Marina composer. A cello offering [electronic resource] : for cello and symphony orchestra / Marina Geller. ©2010 (002452450 ) .אוניברסיטת בר-אילן -- עבודות לתאר שלישי -- המחלקה למוסיקה Bar Ilan University -- Dissertations -- Department of Music Wolf, Magret Liat composer. Cheleq : [electronic resource] : for viola, 4 singers, 4 actors and orchestra 2009/2010 / Magret Liat Wolf. ©2012 (002452548 ) Bar Ilan University -- Dissertations -- Department of Music .אוניברסיטת בר-אילן -- עבודות לתאר שלישי -- המחלקה למוסיקה Wolf, Magret Liat author. Repopulating ghost towns [electronic resource] : "Jewishness" in the music of Peter Kiesewetter / Magret Liat Wolf. ©2012. (002452551 ) Kiesewetter, Peter Music -- 20th century. Bar Ilan University -- Dissertations -- Department of Music. Dead sea scrolls fragments in the Museum collection [electronic resource] / edited by Emanuel Tov, Kipp Davis, Robert Duke. Leiden : Brill, [2016] (002453144 ) Dead Sea scrolls The religious aspects of war in the ancient Near East, Greece, and Rome [electronic resource] / edited by Krzysztof Ulanowski. Leiden : Brill, [2016] (002453150 ) War -- Religious aspects. Middle East Greece Rome Radai, Itamar author. Palestinians in Jerusalem and Jaffa, 1948 [electronic resource] : a tale of two cities / Itamar Radai ; translated by Haim Watzman. London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016 (002453638 ) Israel-Arab War, 1948-1949 -- Social aspects. Palestinian Arabs -- Social conditions -- 20th century. Palestinian Arabs -- History, Military -- 20th century. Israel-Arab War, 1948-1949 -- Campaigns -- Israel (State) -- Tel Aviv. -

New Arrivals May 2012
New Arrivals Catalog May 2012 Windows Booksellers 199 West 8th Ave., Suite 1 Eugene, OR 97401 USA Phone: (800) 779-1701 or (541) 485-0014 * Fax: (541) 465-9694 Email and Skype: [email protected] Website: http://www.windowsbooks.com Monday - Friday: 10:00 AM to 5:00 PM, Pacific time (phone & in-store); Saturday: Noon to 3:00 PM, Pacific time (in-store only- sorry, no phone). Our specialty is used and out-of-print academic books in the areas of theology, church history, biblical studies, and western philosophy. We operate an open shop and coffee house in downtown Eugene. Please stop by if you're ever in the area! When ordering, please reference our book number (shown in brackets at the end of each listing). Prepayment required of individuals. Credit cards: Visa, Mastercard, American Express, Discover; or check/money order in US dollars. Books will be reserved 10 days while awaiting payment. Purchase orders accepted for institutional orders. Shipping charge is based on estimated final weight of package, and calculated at the shipper's actual cost, plus $1.00 handling per package. We advise insuring orders of $100.00 or more. Insurance is available at 5% of the order's total, before shipping. Uninsured orders of $100.00 or more are sent at the customer's risk. Returns are accepted on the basis of inaccurate description. Please call before returning an item. New Arrivals Catalog May 2012 Table of Contents American History 3 Archaeology & Ancient Near East 3 Art 18 Bibles 20 Biblical Interpretation 21 Biography 24 Books on Books 24 -

National Identity - National Unity the Integrational Aspect of Adult Education in the Development of the Modern State of Israel 1948 - 1973
NATIONAL IDENTITY - NATIONAL UNITY THE INTEGRATIONAL ASPECT OF ADULT EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN STATE OF ISRAEL 1948 - 1973 by James D. Cunningham Department of Educational Theory A Thesis submitted in conformity with the requirements for the Degree of Doctor of Education University of Toronto QD James D. Cunningham 1981 AGSTRACT NATIONAL IDENTITY - NATIONAL UNITY THE INTEGRATIONAL ASPECT OF ADULT EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN STATE OF ISRAEL 1948 - 1973 by James D. Cunningham A qualitative, grounded theory methodology was used in this study to explore how selected adult educators in Israel, perceive and assess adult education as a strategy for the development of National Identity - National Unity (NI-NU) within the modern State of Israel: 1948- 1973. The methodology is an inductive approach that relies heavily on the data from interviews and observation to build a theory 'grounded' in the data rather than to test a theory or merely describe empirical phenomena. The method required the use of theoretical sampling in data collection and analysis. The researcher collected data from thirty-one interviews with selected adult educators, who became the 'primary personnel' (ie policy maker~; with some program implementers and participant evaluators included. The interviews (and related material from observations and publications) were recorded, transcribed, coded and categorized in related sections. Fifteen primary factors were identified that connect modern Israeli Identity to traditional Jewish Identity. ·The study briefly describes the historical and philosophical background of adult education in Israel including a descriptive analysis of the contribution made to NI-NU by seven primary adult education agencies: 1) The Ministry of Education and Culture (Department of Adult Education and Department of Torah Culture); 2) Ulpanim (Hebrew language studies); 3) Israel Defence Force (IDF); 4) Kibbutzim (collective farms); 5) Histadrut (Trades' Unions); 6) Community Centers and 7) Moshavim (Co-operative farms).