Onomastico Di Re Ferdinando
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Autumn 2020 Issue 23
THE ıntage rose Autumn V2020, Issue 23 NOTE: please change your pdf view to landscape mode for optimum screen viewing. NEWSLETTER FOR THE FRIENDS OF VINTAGE ROSES Autumn 2020, Issue 23 IN THIS ISSUE: Featured Rose: ‘Baltimore Curator’s Report Four Uncommon Noisettes Fostering The Friends of It’s a New Day on Our Belle’ Vintage Roses Modern Shrub Website On windowsills the vases Many rose lovers who Collection It’s a lovely rose, as most count the days—blue are fond of climbing and I am so happy to tell you are that survive the whims, cobalt glass, powder blue clustering flowers are fond When I agreed to foster about the new look and ravages, and vicissitudes of pottery, clear cylinders of Noisettes and Tea- The Friends of Vintage changes to our website time. But it’s also a head- in steel. They are always Noisettes. The Noisette, Roses Modern Shrub Col- www.thefriendsofvintage turner of robust health, ready, smiling at me, an original American rose lection, several years ago, roses.org. Thanks to the and, despite being 177 asking me to bring a rose (c. 1810), boasts virtual I thought it would be no hard work . see page 14 years old . see page 3 blossom. see page 5 bouquets . see page 7 big deal . see page 12 On the cover: ‘Earl of Eldon’ (photo by Gregg Lowery) • • • 2 • • • TABLE OF CONTENTS Featured Rose: ‘Baltimore Belle’. 3 Curator’s Report . 5 Four Uncommon Noisettes . 8 Fostering the Friends of Vintage Roses Modern Shrub Collection. 13 It’s a New Day on Our Website . -

INTRODUCTION 1. Charles Esdaile, the Wars of Napoleon (New York, 1995), Ix; Philip Dwyer, “Preface,” Napoleon and Europe, E
Notes INTRODUCTION 1. Charles Esdaile, The Wars of Napoleon (New York, 1995), ix; Philip Dwyer, “Preface,” Napoleon and Europe, ed. Philip Dwyer (London, 2001), ix. 2. Michael Broers, Europe under Napoleon, 1799–1815 (London, 1996), 3. 3. An exception to the Franco-centric bibliography in English prior to the last decade is Owen Connelly, Napoleon’s Satellite Kingdoms (New York, 1965). Connelly discusses the developments in five satellite kingdoms: Italy, Naples, Holland, Westphalia, and Spain. Two other important works that appeared before 1990, which explore the internal developments in two countries during the Napoleonic period, are Gabriel Lovett, Napoleon and the Birth of Modern Spain (New York, 1965) and Simon Schama, Patriots and Liberators: Revolution in the Netherlands, 1780–1813 (London, 1977). 4. Stuart Woolf, Napoleon’s Integration of Europe (London and New York, 1991), 8–13. 5. Geoffrey Ellis, “The Nature of Napoleonic Imperialism,” Napoleon and Europe, ed. Philip Dwyer (London, 2001), 102–5; Broers, Europe under Napoleon, passim. 1 THE FORMATION OF THE NAPOLEONIC EMPIRE 1. Geoffrey Ellis, “The Nature of Napoleonic Imperialism,” Napoleon and Europe, ed. Philip Dwyer (London, 2001), 105. 2. Martyn Lyons, Napoleon Bonaparte and the Legacy of the French Revolution (New York, 1994), 43. 3. Ellis, “The Nature,” 104–5. 4. On the Revolutionary and Napoleonic Wars and international relations, see Tim Blanning, The French Revolutionary Wars, 1787–1802 (London, 1996); David Chandler, The Campaigns of Napoleon: the Mind and Method of History’s Greatest Soldier (London, 1966); Owen Connelly, Blundering to Glory: Napoleon’s Military 212 Notes 213 Campaigns (Wilmington, DE, 1987); J. -

Inventario (1
INVENTARIO (1 - 200) 1 Scatola contenente tre fascicoli. V. segn. 1 ELETTRICE PALATINA ANNA MARIA LUISA DE’ MEDICI 1 Lettere di auguri natalizi all’elettrice palatina Anna Maria Luisa de’ Medici di: Filippo Acciaiuoli, cc.2-4; Faustina Acciaiuoli Bolognetti, cc.5-7; Isabella Acquaviva Strozzi, cc.8-10; cardinale Alessandro Albani, cc.11-13; Fi- lippo Aldrovandi Marescotti, cc.14-16; Maria Vittoria Altoviti Cor- sini, cc.17-19; Achille Angelelli, cc.20-23; Roberto Angelelli, cc.24- 26; Dorothea Angelelli Metternich, cc.27-29; Lucrezia Ansaldi Le- gnani, cc.30-32; Giovanni dell’Aquila, cc.33-35; duchessa Douariere d’Arenberg, con responsiva, cc.36-40; governatore di Grosseto Cosimo Bagnesi, cc.41-43; Andrea Barbazzi, cc.44-46; segretario della Sacra Consulta Girolamo de’ Bardi, cc.47-49; cardinale [Lodovico] Belluga, cc.50-52; Lucrezia Bentivoglio Dardinelli, cc.53-55; Maria Bergonzi Ra- nuzzi, cc.56-58; cardinale Vincenzo Bichi, cc.59-61; «re delle Due Si- Nell’inventario, il numero del pezzo è posto al centro in neretto. Alla riga successiva, in cor- cilie» Carlo VII, con responsiva, cc.62-66; vescovo di Borgo Sansepol- sivo, sono riportate la descrizione estrinseca del volume, registro o busta con il numero com- cro [Raimondo Pecchioli], cc.67-69; Camilla Borgogelli Feretti, cc.70- plessivo dei fascicoli interni e le vecchie segnature. Quando il nesso contenutistico fra i do- 72; Cosimo Bourbon del Monte, cc.73-75; baronessa de Bourscheidt, cumenti lo rendeva possibile si è dato un titolo generale - in maiuscoletto - a tutto il pezzo, con responsiva, cc.76-79; vescovo di Cagli [Gerolamo Maria Allegri], o si è trascritto, tra virgolette in maiuscoletto, il titolo originale. -
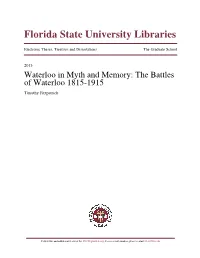
Waterloo in Myth and Memory: the Battles of Waterloo 1815-1915 Timothy Fitzpatrick
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2013 Waterloo in Myth and Memory: The Battles of Waterloo 1815-1915 Timothy Fitzpatrick Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES WATERLOO IN MYTH AND MEMORY: THE BATTLES OF WATERLOO 1815-1915 By TIMOTHY FITZPATRICK A Dissertation submitted to the Department of History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Degree Awarded: Fall Semester, 2013 Timothy Fitzpatrick defended this dissertation on November 6, 2013. The members of the supervisory committee were: Rafe Blaufarb Professor Directing Dissertation Amiée Boutin University Representative James P. Jones Committee Member Michael Creswell Committee Member Jonathan Grant Committee Member The Graduate School has verified and approved the above-named committee members, and certifies that the dissertation has been approved in accordance with university requirements. ii For my Family iii ACKNOWLEDGMENTS I would like to thank Drs. Rafe Blaufarb, Aimée Boutin, Michael Creswell, Jonathan Grant and James P. Jones for being on my committee. They have been wonderful mentors during my time at Florida State University. I would also like to thank Dr. Donald Howard for bringing me to FSU. Without Dr. Blaufarb’s and Dr. Horward’s help this project would not have been possible. Dr. Ben Wieder supported my research through various scholarships and grants. I would like to thank The Institute on Napoleon and French Revolution professors, students and alumni for our discussions, interaction and support of this project. -

The Pasque Veronesi
VERONESE EASTERS celebration Committee (17-25 aprile 1797) Via L. Montano, 1 - 37131 VERONA Tel. 0039/329/0274315 - 0039/347/3603084 0039/45/520859 - 0039/45/8403819 www.traditio.it - E-mail: [email protected] VERONESE EASTERS The Verona rising against Napoleon (April 17-25, 1797) The Veronese Easters , like the Sicilian Vespers , is the name for the general insurrection in Verona and its surrounding country, on April 17, 1797: Easter Monday. Among the innumerable risings from 1796 to 1814 which swept through Italy and Europe occupied by Bonaparte, and which expressed the rejection by the people of the false principles of the French Revolution, imposed by bayonets, the insurrection of Verona was certainly the most important in Italy, after the Saint Faith’s Crusade in 1799, by which Cardinal Fabrizio Ruffo of Calabria and the farmers of the south regained a whole Kingdom for the Bourbons of Naples. 1. Verona and the Serenissima Republic before the Revolution The Revolutionary France, drunk with the massacres of the Terror, ventured into a series of wars against the other European powers after killing the legitimate sovereign, Louis XVI, exterminating his family, causing the death of the Dauphin at the age of ten in the Temple Tower jail, demolishing the monarchy, persecuting worship and the Catholic religion. The revolutionary hordes, led by the darkest anticlerical sects, above all the Masons, were anxious to export hatred against the Church all over the world and upset the traditional sacred Institutions both civil and religious to which the people were deeply attached. The Italian States and the aristocratic Republic of Venice were then unfortunately experiencing a sad moral decline: a large part of the patrician ship, a shadow of that which had faced and beaten the Turks so many times, was infiltrated by the libertarian and libertine principles of the French Revolution. -

IL CENACOLO ITALIAN CULTURAL CLUB Founded in 1928
IL CENACOLO ITALIAN CULTURAL CLUB Founded in 1928 Regular Thursday Meetings, Noon to 2:00 P.M. San Francisco Italian Athletic Club 1630 Stockton Street (3rd floor), San Francisco, CA 94133 www.ilcenacolosf.org “Il Cenacolo is an organization that preserves, enhances and encourages all aspects of Italian arts, language and culture and recognizes the unique contribution of Italian heritage that is intertwined in the history and life of the San Francisco Bay Area.” DECEMBER 2020 Thursday, December 3, 2020 “Venice: The Most Improbable of Cities” (Part I) Carla Gambescia (ZOOM Meeting)* Thursday, December 10, 2020 “Venice: The Most Improbable of Cities” (Part II) Carla Gambescia (ZOOM Meeting)* Thursday, December 17, 2020 The Merrie Olde Christmas Carolers (ZOOM Meeting)* Thursday, December 24, 2020 No meeting in deference to Christmas This month’s programs arranged by Ron Fenolio. (* ZOOM link and instructions by David Cobb will be emailed the week of each meeting.) PROGRAM PROFILES ZOOM Thursdays, December 3 & 10, 2020 Venice, the Most Improbable of Cities (2-part series) Carla Gambescia Venezia is Queen of the Adriatic, La Serenissima, standing for triumph of human will over Nature, once a beehive of espionage, luxury, the pleasure capital of Europe, a mecca of extraordinary artists and personalities and the zenith of all Grand Tours…yet even today, Venice remains an enigma. Come explore Venice’s complexities and seeming contradictions as we discover some of its many secrets and celebrate the city of myth, mystery, majesty and might. Part I: From its inauspicious beginnings at the end of the Roman empire to its apex as a commercial, naval and financial juggernaut, a Xanadu of architecture and a nexus of cultural cross-currents. -

ADDEO GIROLAMO, Nota Storica Sulla Copia
R. Longo Cioffi Società Storia e Cultura del '700 napoletano Abatino, Giuseppe Il forte di Vigliena. Una ricerca topografica e storica. Napoli: Edizioni dell’Anticaglia, 1999 (ristampa anastatica dell’edizione,Trani, Vecchi, 1899). Acton, Harold The Bourbons of Naples:1734-1825. London: Methuen and Co., 1957. Addeo, Girolamo L’albero della libertà nella Repubblica Napoletana del 1799, in “Atti dell’Accademia Pontaniana”, n.s. 26, 1977, p. 67-87. Addeo, Girolamo Contributo alla ricerca sulle origini del Monitore Napoletano di Eleonora Pimentel Fonseca, in “Samnium”, n. 1-2, 1979, p. 103-111. Addeo, Girolamo Un discorso del 1799 di Vincenzio Russo nel crepuscolo della Repubblica napoletana, in “Rassegna Storica del Risorgimento”, 66, n.2, 1979, p. 145-150. Addeo, Girolamo Nota storica sulla copia manoscritta del Monitore Napoletano. Marigliano: Tip.Istituto Anselmi, s.d. Addeo, Girolamo “Le Notizie Officiali”: un ignorato periodico francofilo nel tramonto della Repubblica Napoletana del 1799, in “Archivio storico per le province napoletane”, 6 s., 17, 1978, p. 261-272. Addeo, Girolamo Un periodico del 1799: il Veditore Repubblicano, in “Archivio storico per le province napoletane”, 4 s. 14, 1975, p. 211-229. Addeo, Girolamo La stampa periodica durante la Repubblica Napoletana del 1799, in “Nuovi Quaderni del Meridione”, 61, 1978, p. 1-23. Addeo, Girolamo La stampa periodica napoletana nel sessennio (1799-1806) della prima restaurazione borbonica, in “Archivio storico per le province napoletane”, 3 s., 18, 1979, p. 257-313. Ajello, Raffaele Gli 'afrancesados' a Napoli nella metà del Settecento. Idee e progetti di sviluppo, in I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna: un bilancio storiografico; a cura di Mario Di Pinto. -

Pompei, Nola, Nuceria: Assetti Agrari Tra La Tarda Eta' Repubblicana E La Prima Eta' Imperiale. Documenta
fabrizio ruffo Pompei, Nola, Nuceria: assetti agrari tra la tarda eta’ repubblicana e la prima eta’ imperiale. Documenta- zione archeologica e questioni di metodo. La piana nocerino-sarnese si estende dalle propaggini sud- orientali del complesso vulcanico del Somma-Vesuvio alla catena dei Monti Lattari ed è limitata ad ovest dal mare e a oriente dai rilievi sviluppati a monte dei centri moderni di Palma Campania e di Sarno. ad essa si raccorda in direzione nord-est, senza solu- zione di continuità - mediante una strozzatura dell’ordine di circa 3 chilometri compresa tra i declivii dei rilievi suddetti e occupata nel mezzo dal centro moderno di San Gennaro Vesuviano -, la piana che si apre verso Nola e che, concludendosi a nord in cor- rispondenza della dorsale del Monte fellino, a sua volta in maniera ininterrotta continua a ovest nel più esteso comprensorio costituito dalla vera e propria pianura ‘campana’. L’attuale andamento sub-orizzontale della superficie, con lie- vissima inclinazione verso ovest/sud-ovest a partire grosso modo dall’areale di Poggiomarino, rappresenta l’esito del modellamento operato dalla deposizione dei prodotti delle varie eruzioni che si sono avvicendate nel corso dei millenni e che si sono alternate a fenomeni di tipo alluvionale e ad interventi di natura antropica, antichi e moderni, finalizzati allo sfruttamento agricolo dei suoli. Tale andamento non corrisponde del tutto alla situazione in essere agli albori dell’epoca propriamente storica, che era viceversa ca- ratterizzata dalla presenza di più evidenti, per quanto modesti, ‘rialzi’ morfologici dell’ordine di pochi metri situati in corrispon- denza delle moderne località di Striano, San Marzano, San Valen- fabrizio ruffo tino Torio e Palma Campania, la cui natura ‘asciutta’ non a caso de- terminò, all’epoca, la loro elezione ai fini di una occupazione a ca- rattere funerario da parte delle comunità della piana. -

The Complete Sacred Music of Nicolò Isouard (1773 – 1818) and Maltese Sacred Music for the Order of Malta in the Late Eighteenth Century
The Complete Sacred Music of Nicolò Isouard (1773 – 1818) and Maltese Sacred Music for The Order of Malta in the Late Eighteenth Century. By Richard Sydney Benedict Divall Doctor of Letters (Honoris Causa – Monash 1992) and Doctor of the University (Honoris Causa – Australian Catholic University 2004) A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy MCD University of Divinity 2013 MCD University of Divinity To Whom it May Concern This is to certify that the thesis and music editions presented by me for the degree of Doctor of Philosophy comprises only my original work except where due acknowledgment is made in the text to all other material used. Signature: ____________________________________ Name in Full: ____________________________________ Date: ____________________________________ Abstract. Nicolò Isouard (1773-1818) is considered Malta’s national composer. After studies in France and Naples, he returned to his homeland, where from 1794 to 1798 he was an aspiring composer, and employee of the Order of Malta. In 1994 a collection of thirty-three autographs of hitherto unknown sacred music by Isouard appeared at the Bibliothèque Nationale, Paris, and I recognised the importance of these manuscripts. My intentions are to provide a précis on the Order, as the sovereign entity ruling Malta at the time, and the sacred music composed for them in their great Conventual Church in Valletta – now St John’s Co-Cathedral. The thesis will provide the background to Isouard’s early career and a complete edition and commentary of all of his sacred music, including additional works found during the research process, and a catalogue of his stage works. -

Il Cardinale Fabrizio Ruffo E L'impresa Sanfedista Il Cardinale Fabrizio Ruffo Appartenne Ad Un Ramo Collaterale Dell'antich
Il Cardinale Fabrizio Ruffo e l’impresa sanfedista Il cardinale Fabrizio Ruffo appartenne ad un ramo collaterale dell’antichissima Casa dei Ruffo di Calabria, per l’esattezza a quello dei duchi di Baranello e Sant’Antimo, diventati poi alla fine del Settecento duchi di Bagnara, per estinzione del ramo principale da cui discendevano1. Egli nacque a San Lucido, baronia della sua famiglia, il 16 settembre del 1744 dal duca Letterio e da Giovanna Colonna, principessa di Spinoso, marchesa di Guardia Perticara e signora di Accetturo e Gorgoglione. La sua istruzione iniziò alquanto presto, infatti già a quattro anni venne condotto a Roma presso il prozio cardinale Tommaso Ruffo, decano allora del Sacro Collegio, che lo fece educare dal prelato Giovanni Angelo Braschi, che all’epoca si trovava presso la corte del cardinale in qualità di uditore. Fabrizio studiò con molto impegno nell’esclusivo collegio Clementino dei Padri Somaschi, primeggiando negli studi filosofici e soprattutto nelle scienze fisiche e in quelle di economia pubblica2. Il suo precettore Angelo Braschi nel 1775 salì al soglio pontificio con il nome di Pio VI e seguì da vicino gli studi del suo protetto che non volle mai pronunciare i voti sacerdotali, rimanendo diacono per tutta la vita, avendo pronunciato soltanto i voti minori3. Nel 1785 il Pontefice Pio VI lo nominò Tesoriere Generale della Reverenda Camera Apostolica, per riformare le dissestate finanze dello Stato Pontificio. Le sue leggi miravano a combattere e demolire il nepotismo dispotico e a potenziare e rendere economicamente attiva l’agricoltura in tutta lo stato. Tali riforme, che abolivano di fatto gli abusi feudali, erano molto apprezzate proprio perché venivano da un cardinale appartenente ad una famiglia, tra le più illustri della nobiltà 1 G. -

"A" - You're Adorable (The Alphabet Song) 1948 Buddy Kaye Fred Wise Sidney Lippman 1 Piano Solo | Twelfth 12Th Street Rag 1914 Euday L
Box Title Year Lyricist if known Composer if known Creator3 Notes # "A" - You're Adorable (The Alphabet Song) 1948 Buddy Kaye Fred Wise Sidney Lippman 1 piano solo | Twelfth 12th Street Rag 1914 Euday L. Bowman Street Rag 1 3rd Man Theme, The (The Harry Lime piano solo | The Theme) 1949 Anton Karas Third Man 1 A, E, I, O, U: The Dance Step Language Song 1937 Louis Vecchio 1 Aba Daba Honeymoon, The 1914 Arthur Fields Walter Donovan 1 Abide With Me 1901 John Wiegand 1 Abilene 1963 John D. Loudermilk Lester Brown 1 About a Quarter to Nine 1935 Al Dubin Harry Warren 1 About Face 1948 Sam Lerner Gerald Marks 1 Abraham 1931 Bob MacGimsey 1 Abraham 1942 Irving Berlin 1 Abraham, Martin and John 1968 Dick Holler 1 Absence Makes the Heart Grow Fonder (For Somebody Else) 1929 Lewis Harry Warren Young 1 Absent 1927 John W. Metcalf 1 Acabaste! (Bolero-Son) 1944 Al Stewart Anselmo Sacasas Castro Valencia Jose Pafumy 1 Ac-cent-tchu-ate the Positive 1944 Johnny Mercer Harold Arlen 1 Ac-cent-tchu-ate the Positive 1944 Johnny Mercer Harold Arlen 1 Accidents Will Happen 1950 Johnny Burke James Van Huesen 1 According to the Moonlight 1935 Jack Yellen Joseph Meyer Herb Magidson 1 Ace In the Hole, The 1909 James Dempsey George Mitchell 1 Acquaint Now Thyself With Him 1960 Michael Head 1 Acres of Diamonds 1959 Arthur Smith 1 Across the Alley From the Alamo 1947 Joe Greene 1 Across the Blue Aegean Sea 1935 Anna Moody Gena Branscombe 1 Across the Bridge of Dreams 1927 Gus Kahn Joe Burke 1 Across the Wide Missouri (A-Roll A-Roll A-Ree) 1951 Ervin Drake Jimmy Shirl 1 Adele 1913 Paul Herve Jean Briquet Edward Paulton Adolph Philipp 1 Adeste Fideles (Portuguese Hymn) 1901 Jas. -

Background to Italy in the Time of Rosmini (1797 – 1855) C
A Background to Italy in the time of Rosmini (1797 – 1855) c. 1790 - 1855 Introduction Rosmini lived through an extremely turbulent period of European history. Through all of his early years, until he was eighteen (Napoleon was defeated at Waterloo a few days short of his eighteenth birthday), the continent was riven by wars which had their origins in the bloody, traumatic and epoch making events surrounding the French revolution and its consequences. Governments fell with bewildering regularity, more often than not bloodily, whilst constitutions, both republican and monarchical, were swept away and then often reverted. In this respect hardly a political unit in western and central Europe – city state, prince state, bishop state, empire, kingdom or republic – was unaffected. The sole exception was Great Britain, and even here Ireland was made part of the Union in 1800 and the novelty of income tax was introduced. Warfare was the norm, and although it bore little relationship to the ‘total wars’ of the twentieth century, it affected all classes and all areas to a greater or lesser extent. These events shattered pre-existing ideas – in a more brutal and physical form than the intellectual impact of the Enlightenment of the second half of the eighteenth century. The cost and impact of war speeded up the industrialisation of the continent, though the biggest contributor to this, the arrival of the railways, did not have a significant impact in Italy until after Rosmini had died. Italy It is essential to appreciate that Rosmini’s Italy was very different from todays. The Austrian Foreign Minister and later Chancellor in the post-Napoleonic era, Metternich, is reported to have said in 1847 that, Italy was a geographic expression.