" "P Pi Ia an No C Co Om Mu Un Na Al Le D Di E
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
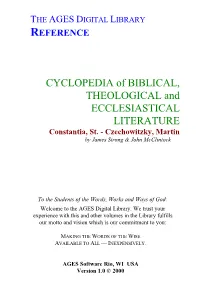
Constantia, St
THE AGES DIGITAL LIBRARY REFERENCE CYCLOPEDIA of BIBLICAL, THEOLOGICAL and ECCLESIASTICAL LITERATURE Constantia, St. - Czechowitzky, Martin by James Strong & John McClintock To the Students of the Words, Works and Ways of God: Welcome to the AGES Digital Library. We trust your experience with this and other volumes in the Library fulfills our motto and vision which is our commitment to you: MAKING THE WORDS OF THE WISE AVAILABLE TO ALL — INEXPENSIVELY. AGES Software Rio, WI USA Version 1.0 © 2000 2 Constantia, Saint a martyr at Nuceria, under Nero, is commemorated September 19 in Usuard's Martyrology. Constantianus, Saint abbot and recluse, was born in Auvergne in the beginning of the 6th century, and died A.D. 570. He is commemorated December 1 (Le Cointe, Ann. Eccl. Fran. 1:398, 863). Constantin, Boniface a French theologian, belonging to the Jesuit order, was born at Magni (near Geneva) in 1590, was professor of rhetoric and philosophy at Lyons, and died at Vienne, Dauphine, November 8, 1651. He wrote, Vie de Cl. de Granger Eveque et Prince dae Geneve (Lyons, 1640): — Historiae Sanctorum Angelorum Epitome (ibid. 1652), a singular work upon the history of angels. He also-wrote some other works on theology. See Hoefer, Nouv. Biog. Generale, s.v.; Jocher, Allgemeines Gelehrten- Lexikon, s.v. Constantine (or Constantius), Saint is represented as a bishop, whose deposition occurred at Gap, in France. He is commemorated April 12 (Gallia Christiana 1:454). SEE CONSTANTINIUS. Constantine Of Constantinople deacon and chartophylax of the metropolitan Church of Constantinople, lived before the 8th century. There is a MS. -

Download Libro Interland
APOLLO Your Hôtel in Riccione ADMIRAL Ai nostri Gentili Ospiti, è da generazioni che la nostra famiglia svolge con grande dedizione questo lavoro, che sin da subito più che un lavoro è divenuto una vera e propria passione. Una passione che ha come obiettivo quello di rendere le vacanze dei nostri ospiti indimenticabili… Per far ciò cerchiamo di curare alla perfezione ogni singolo dettaglio, perché da noi nulla è lasciato al caso! Questa piccola guida è nata proprio dal nostro desiderio di far trascorrere ai nostri ospiti dei momenti di assoluto relax e di tanta felicità…Riteniamo infatti che possa essere veramente utile per tutti coloro che desidereranno conoscere le bellezze della nostra città e del nostro entroterra. Oltre che ad informazioni di carattere storico e geografico, troverete tante curiosità, indicazioni sui principali eventi delle varie località e indirizzi di ottimi ristoranti dove potrete assaporare i sapori della nostra terra. In questo modo scoprirete luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, castelli e rocche ricchi di fascino e mistero, città e paesi che in passato sono stati la culla di civiltà importanti, dove ancora oggi si possono ammirare magnifiche testimonianze. Inoltre da Riccione sarà possibile visitare città famose in tutto il mondo… dalla romantica Venezia alla colta Bologna, dall’artistica Urbino alla storica Firenze, passando per la splendida Ravenna…il tutto a poche ore di distanza da noi! E per gli amanti del divertimento… una lista di tutti i Parchi Tematici della Riviera, mete ideali sia per i grandi -

The Magical Light of Venice
The Magical Light of Venice Eighteenth Century View Paintings The Magical Light of Venice Eighteenth Century View Paintings The Magical Light of Venice Eighteenth Century View Paintings Lampronti Gallery - London 30 November 2017 - 15 January 2018 10.00 - 18.00 pm Catalogue edited by Acknowledgements Marcella di Martino Alexandra Concordia, Barbara Denipoti, the staff of Itaca Transport and staff of Simon Jones Superfright Photography Mauro Coen Matthew Hollow Designed and printed by De Stijl Art Publishing, Florence 2017 www.destijlpublishing.it LAMPRONTI GALLERY 44 Duke Street, St James’s London SW1Y 6DD Via di San Giacomo 22 00187 Roma On the cover: [email protected] Giovanni Battista Cimaroli, The Celebrations for the Marriage of the Dauphin [email protected] of France with the Infanta Maria Teresa of Spain at the French Embassy in www.cesarelampronti.com Venice in 1745, detail. his exhibition brings together a fine selection of Vene- earlier models through their liveliness of vision and master- T tian cityscapes, romantic canals and quality of light ful execution. which have never been represented with greater sensitivity Later nineteenth-century painters such as Bison and Zanin or technical brilliance than during the wondrous years of reveal the profound influence that Canaletto and his rivals the eighteenth century. had upon future generations of artists. The culture of reci- The masters of vedutismo – Canaletto, Marieschi, Bellot- procity between the Italian Peninsula and England during to and Guardi – are all included here, represented by key the Grand Siècle, epitomised by the relationship between works that capture the essence and sheer splendour of Canaletto and Joseph Consul Smith, is a key aspect of the Venice. -

LOC DISAG TOTALE.Xlsx
CAP Prov Località 30010 VE 3 PORTI 03033 FR ABATE 84040 SA ABATEMARCO 61040 PS ABBADIA DI NARO 61041 PU ABBADIA DI NARO 53021 SI ABBADIA S.SALVATORE 53021 SI ABBADIA S.SELVA 53021 SI ABBADIA SAN SALVATORE 65020 PE ABBATEGGIO 87010 CS ABBAZIA 03010 FR ABBAZIA DI TRISULTI 83037 AV ABBONDANZA 12020 CN ABELLY 39058 BZ ABERSTUECKL 40041 BO ABETAIA 85010 PZ ABETINA 23035 SO ABETINA 63040 AP ABETITO 50030 FI ABETO 06040 PG ABETO 51021 PT ABETONE 52037 AR ABOCA 36046 VI ABRIANI 85010 PZ ABRIOLA 36046 VI ABRI-SASSI 10060 TO ABSES 97011 RG ACATE 71021 FG ACCADIA 88040 CZ ACCARIA 88040 CZ ACCARIA ROSARIA 12021 CN ACCEGLIO 75011 MT ACCETTURA 12020 CN ACCHIARDI 67020 AQ ACCIANO 84041 SA ACCIAROLI 02011 RI ACCUMOLI 02011 Rl ACCUMOLI 85011 PZ ACERENZA 39030 BZ ACERETO 39032 BZ ACERETO 84042 SA ACERNO 16041 GE ACERO 95020 CT ACI BONACCORSI 95022 CT ACI CATENA 95020 CT ACI SAN FILIPPO 95025 CT ACI SANT'ANTONIO 85056 PZ ACQUA BIANCA 86084 IS ACQUA DEI RANCI 85050 PZ ACQUA DEI SALICI 87054 CS ACQUA DEL TIGLIO 88045 CZ ACQUA DELLE PERE 16040 GE ACQUA DI OGNIO 84070 SA ACQUA DI PAOLO 16045 GE ACQUA DI SOPRA 16045 GE ACQUA DI SOTTO 85048 PZ ACQUA NOCELLA 85030 PZ ACQUA SECCAGNA 17048 SV ACQUABIANCA 32043 BL ACQUABONA 42037 RE ACQUABONA 16010 GE ACQUABUONA 41026 MO ACQUABUONA 16029 GE ACQUABUONA INFERIORE 16029 GE ACQUABUONA SUPERIORE 98055 ME ACQUACALDA 62035 MC ACQUACANINA 62033 MC ACQUACANINA - FIASTRA 24019 BG ACQUADA 03040 FR ACQUAFONDATA 87010 CS ACQUAFORMOSA 83036 AV ACQUAFREDDA 87055 CS ACQUAFREDDA 17010 SV ACQUAFREDDA 16026 GE ACQUAFREDDA INFERIORE -
Facultad De Arquitectura UDELAR GRUPO DE VIAJE 2012
Facultad de Arquitectura UDELAR GRUPO DE VIAJE 2012 ARQUITECTURA RIFA G05 EQUIPO DOCENTE Taller Danza Marcelo Danza Lucía Bogliaccini Luis Bogliaccini Diego Capandeguy Marcos Castaings Martín Delgado Andrés Gobba Lucas Mateo Nicolás Newton Natalia Olivera Felipe Reyno Thomas Sprechmann Marcelo Staricco MÓDULO 05 ITALIA y SUIZA DOCENTES MÓDULO 05 Luís Bogliaccini Marcelo Staricco GRUPO DE TRABAJO Carolina Arduino Patricia Izaurralde Maia Palomeque Magdalena Sprechmann Magdalena Abreu ITALIA DatoS GENERALES: Nombre oficial: Repubblica Italiana Superficie: 301 338 km² Población: 60.776.531 Densidad de Población: 201,69 hab/km² Territorio: Más de la mitad del territorio corresponde a la península italiana, un largo brazo del continente europeo. Tiene forma de bota y se extiende siguiendo dirección sureste hacia el mar Mediterráneo. PBI per cápita: US$ 33,855 Capital: Roma Idioma oficial: Italiano. Religión: Católica 4 GUÍA DE VIAJE | GEN 2005 GUÍA DE VIAJE | GEN 2005 5 EUROPA | ITALIA I. INTRODUCCION Entre los años 2000 y 1000 a.C. la península italiana recibió el aporte de pueblos indoeu- ropeos provenientes de Europa Central, desarrollando dos áreas culturales homogéneas: la parte septentrional, se caracterizó por la construcción de palafitos y la incineración de los restos mortuorios; y la zona meridional, que se abrió a las influencias de las civi- lizaciones mediterráneas. A fines del segundo milenio a.C. fuertes corrientes migratorias debilitaron la cultura septentrional y fragmentaron a la meridional. Surgió una multipli- cidad de culturas regionales (latina, ligur, véneta, villanoviana e ilírica entre otras). La fundación de colonias griegas, las cuales se extendieron desde el golfo de Nápoles hasta los de Tarento y Palermo a partir del siglo VIII a.C. -

Comune Di Venezia
REGIONE DEL VENETO COMUNE DI VENEZIA ADEGUAMENTO VIA ACQUEA DI ACCESSO ALLA STAZIONE MARITTIMA DI VENEZIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE AL CANALE CONTORTA S.ANGELO Elaborato B Sintesi Non Tecnica Committente e progettista: Estensore dello Studio di Impatto Ambientale: c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA Autorità Portuale di Venezia ed. Auriga - via delle Industrie, 9 Santa Marta, Fabbricato 13 30175 Marghera (VE) 30123 Venezia, VE www.eambiente.it; [email protected] Tel. 041 5093820; Fax 041 5093886 Data: luglio 2014 Revisione 02 Autorità Portuale di Venezia – Studio di Impatto Ambientale SOMMARIO 1. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E FINALITÀ DELLO STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE .........................................................................................................................................8 1.1 Inquadramento territoriale ................................................................................................................................................... 9 1.2 Struttura dell’elaborato ....................................................................................................................................................... 10 2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO ..........................................................................11 2.1 Aree Naturali Protette ........................................................................................................................................................ 11 2.1.1 Parchi Nazionali .................................................................................................................................................................................. -

Mappa Insulae Stevenson
MAPPA INSULAE 978-2-86364-350-1 ISBN GUILLAUME MONSAINGEON / GILLES A. insulae Mappa / JEAN‑MARC BESSE JEAN‑LUC ARNAUD STEVENSON DAVID RENAUD Stevenson TIBERGHIEN PARENTHÈSES : www.editionsparentheses.com www.editionsparentheses.com « Je dessinai la carte d’une île. Elle était soigneusement et (à mon avis) très joliment coloriée. Sa forme emportait mon imagination au‑delà du raisonnable. Elle recélait des ports qui me charmaient comme des sonnets. Je nommai mon chef‑d’œuvre « L’île au trésor », fort de l’ingénuité des prédestinés. On me dit que certains ne s’intéressent pas aux cartes ; j’ai peine à le croire. Les noms, la forme des forêts, le dessin des routes et des rivières, les empreintes des hommes préhistoriques encore visibles à flanc de coteau et dans les plis des vallées, les moulins et les ruines, les étangs et les lacs, peut‑être le Menhir, ou le Cercle Druidique dans les bruyères ; quelle inépuisable source de curiosité pour qui regarde autour de lui ou dispose d’une once d’imagination pour comprendre ! Tous les 978-2-86364-350-1 enfants se rappellent ces moments passés, la tête dans l’herbe, à observer la forêt miniature, grouillante ISBN / d’habitants et d’armées féeriques. insulae « C’est de cette façon que, absorbé par la carte de mon île au Trésor, les futurs personnages du livre Mappa prirent forme, sortant peu à p b l eu du ois imaginaire. Leurs visages basanés et eurs armes étincelantes / surgirent là où je ne les attendais pas, passant et repassant devant mes yeux, à la chasse au trésor, le tout sur les quelques centimètres carrés d’une modeste carte ! J’eus aussitôt après conscience de me trouver Stevenson face à des feuilles sur lesquelles j’écrivais une liste de chapitres. -
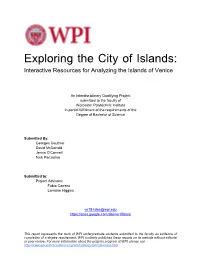
Exploring the City of Islands: Interactive Resources for Analyzing the Islands of Venice
Exploring the City of Islands: Interactive Resources for Analyzing the Islands of Venice An Interdisciplinary Qualifying Project submitted to the faculty of Worcester Polytechnic Institute in partial fulfillment of the requirements of the Degree of Bachelor of Science Submitted By: Georges Gauthier David McDonald Jenna O’Connell Nick Panzarino Submitted to: Project Advisors: Fabio Carrera Lorraine Higgins [email protected] https://sites.google.com/site/ve15isles/ This report represents the work of WPI undergraduate students submitted to the faculty as evidence of completion of a degree requirement. WPI routinely publishes these reports on its website without editorial or peer review. For more information about the projects program at WPI, please see http://www.wpi.edu/academics/ugradstudies/project-learning.html Authorship The creation of this paper was a group effort with all members contributing to its construction as well as its editing and finalization for submission. Each member of the group wrote an equal portion of this paper. For a detailed breakdown of each team member’s individual contribution, see below. Initial research on Venice as a whole: All In depth research on the Lagoon Islands: Jenna O’Connell In depth research on the Inner City Islands: David McDonald In depth research on web applications and different maps: Georges Gauthier and Nick Panzarino Labeled maps of islands in the lagoon: Jenna O’Connell Inner city islands population aggregation: David McDonald GIS Layer Management: Nick Panzarino Island specific bibliographies: -

2015 Deluxe Opera & Music Festival Tours
INTERNATIONAL CURTAIN CALL 2015 DELUXE OPERA & MUSIC FESTIVAL TOURS SPRING ITALY: NAPLES – SICILY – ROME (May 14 - 27, 2015) VIENNA WAGNER RING PLUS TOUR (May 28 - June 8, 2015) ITALY SUMMER FESTIVALS – Milan, Verona & *Opt. Venice Extension (June 18-28; *June 28-July 2, 2015) GLYNDEBOURNE – LONDON ROYAL OPERA & GARSINGTON FESTIVALS (June 30 - July 11, 2015) SALZBURG FESTIVAL & VIENNA OPERA SEASON OPENING WEEK (Aug 24 - Sept 6, 2015) LONDON PANORAMA SPRING ITALY: Naples- Jommelli's The Desert Island; Palermo- Un Ballo In Maschera; Rome- Le Nozze Di Figaro and Orchestra Dell'Accademia Nazionale Di Santa Cecilia Concert- Bruckner's 8th Symphony. VIENNA WAGNER RING PLUS: Wagner's complete New Ring Cycle/ Sir Simon Rattle – Das Rheingold; Die Walküre; Siegfried; and Götterdämmerung. PLUS: Fidelio (Stemme); Salomé; and Così Fan Tutte. ITALY SUMMER FESTIVALS– MILAN & VERONA + *Optional VENICE: Milan La Scala– Cavalleria Rusticana & Pagliacci; and Leo Nucci Recital; Verona– Aida; Nabucco; and Tosca. *Venice– Rossini's La Scala Di Seta & Vivaldi's Juditha Triumphans. GLYNDEBOURNE– LONDON ROYAL OPERA & GARSINGTON FESTIVALS: Glyndebourne– Donizetti's Poliuto & Mozart's Abduction From The Serraglio; Garsington– Così Fan Tutte & Intermezzo; London Royal Opera– La Boheme, William Tell; Falstaff; Shakespeare's "As You Like It" – Old Globe Theater; West End Show–"Matilda, the Musical". SALZBURG FESTIVAL & VIENNA SEASON OPENING WEEK: Salzburg– Der Rosenkavalier; Ernani; Iphigenie En Tauride; Plus Concerts: Israel Philharmonic/Mehta– Tchaikovsky 6th Symphony; and Vienna Philharmonic– Brahms 3rd Symphony. Vienna– Rigoletto; Der Fliegende Holländer; Die Zauberflöte; and Die Fledermaus. SPRING ITALY: NAPLES – SICILY – ROME (May 14 - 27, 2015) Evening— This evening, we meet in the NAPLES (Teatrino Di Corte) Monday, May 18: (B, D) Borsa Lobby and drive to the renowned Free Day; OR OPTIONAL POMPEI & TEATRO MASSIMO to attend Verdi’s– HERCULANEUM RUJNS EXCURSION: BALLO IN MASCHERA After Buffet Breakfast at the Santa Lucia, (Teatro Massimo). -

Co-Supervisor: Alberto Barausse Co-Supervisor: Daniele Brigolin
UNIVERSITY OF PADUA DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING Second Cycle Degree Environmental Engineering Thesis work SEASONAL AND SPATIAL FOOD WEB ANALYSIS IN THE LAGOON OF VENICE USING LINEAR INVERSE MODELLING Supervisor: Luca Palmeri Co-Supervisor: Alberto Barausse Co-Supervisor: Daniele Brigolin Student: VERONICA ZANATTA ACADEMIC YEAR 2013 – 2014 II If you enter this world knowing you are loved and you leave this world knowing the same, then everything that happens in between can be dealt with. Michael Jackson III IV ABSTRACT As a matter of fact anthropogenic pressures on ecosystems are increased in several parts of the world and a preservation and conservation of their natural status are issues of concern. A description of the interactions between the compartments of a trophic network is fundamental in order to obtain a general picture of the state of the ecosystem. The trophic network modelling approach is a useful tool to study the ecosystem state because it collects a large amount of ecological and biological information. This way the food web model describes the relationships among the components of the system. Moreover mass balance models allow to look at the ecosystem through a steady state condition which is a snapshot image of the behaviour of the system in the period under study. For these reasons the first goal of this study is to quantify the flow network of carbon in different food webs models in the Lagoon of Venice using the Linear Inverse Modelling (LIM) approach. LIM ensures that the quantified trophic network satisfies the basic biological constraints and that the experimentally observed composition of the food web is conserved as much as possible. -

Medieval Relevant Das Mittelalter Perspektiven Mediävistischer Forschung
Making the Medieval Relevant Das Mittelalter Perspektiven mediävistischer Forschung Beihefte Herausgegeben von Ingrid Baumgärtner, Stephan Conermann und Thomas Honegger Band 6 Making the Medieval Relevant How Medieval Studies Contribute to Improving our Understanding of the Present Edited by Chris Jones, Conor Kostick, and Klaus Oschema The publication of this book has been generously supported by a British Academy Rising Star Engagement Award, by the Mediävistenverband e.V., and by open access grants from the University of Canterbury (Christchurch, New Zealand) and the Ruhr-University Bochum (Germany). ISBN 978-3-11-054530-2 e-ISBN (PDF) 978-3-11-054631-6 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-054648-4 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Control Number: 2018958050 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2020 Chris Jones, Conor Kostick, Klaus Oschema, published by Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston. The book is published with open access at www.degruyter.com. Typesetting: Integra Software Services Pvt. Ltd. Printing and binding: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com Contents Chris Jones, Conor Kostick, and Klaus Oschema Why Should we Care about the Middle Ages? Putting the Case for -

A Taste of Diplomacy: Food Gifts for the Muscovite Embassy in Venice (1582)*
/ T J R E M D S Laura Mesotten European University Institute A TASTE OF DIPLOMACY: FOOD GIFTS FOR THE MUSCOVITE EMBASSY IN VENICE (1582)* Abstract A vital factor governing early modern diplomatic relations was the practice of hospital- ity. To assure that the embassy began amicably, ambassadors had to be received with generosity. The nature and extent of diplomatic hospitality differed according to the host state, but it often included the offer of housing and victuals. This critical edition of a primary source aims to shed new light on the characteristics of diplomatic hospitality by carefully examining a list of expenses drafted by the Venetian office of the Rason Vecchie. This archival document provides a detailed account of all the food that was supplied to host a Muscovite delegation that visited Venice in 1582. In the first place, the article unravels the qualities and dynamics of Venetian food gifts by contextualising and comparing the source with additional Venetian records. Furthermore, it argues that the type of foodstuffs offered, the amount of money spent on them, and the splendour of festive banquets all communicated strong symbolic and political messages. By focusing the analysis on lists of expenses, the relevance of these documents for the study of diplomatic practices is illustrated. Overviews of financial transactions might seem static and dry accounts at first sight, however, when analysed closely, they reveal a great deal about the day-to-day operation of early modern diplomacy. Keywords: Venice, hospitality, gift-giving, food gifts, diplomatic expenditure * This article draws on a chapter of my PhD dissertation entitled ‘Rituals of Diplomacy in the Venetian Republic’, see: Laura Mesotten, ‘Behind the Curtains of Diplomacy: The Household, Material Culture and Networks of French Ambassadors in Venice (1550–1610)’ (unpublished doctoral thesis, European University Institute, 2017), pp.