28 2007 Bisio Contributo Alla Conoscenza Di
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rote Liste Der Laufkäfer Kärntens (Insecta: Carabidae)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Publikationen Naturschutz Kaernten Jahr/Year: 1999 Band/Volume: 1999_RL Autor(en)/Author(s): Paill Wolfgang, Schnitter Peer Hajo Artikel/Article: Rote Liste der Laufkäfer Kärntens (Insecta: Carabidae). 369-412 © Amt der Kärntner Landesregierung W. E. HOLZINGER, P. M ILDNER, T. ROTTENBURG & C. WIESER (Hrsg.): Rote Listen gefährdeter Tiere Kärntens Naturschutz in Kärnten 15: 369 - 412 ? Klagenfurt 1999 Rote Liste der Laufkäfer Kärntens (Insecta: Carabidae) Wolfgang PAILL & Peer Hajo SCHNITTER unter der Mitarbeit von Thomas LEBENBAUER & Friedrich RASSE 232 Erforschungsstand gut Nachgewiesene Arten 474 (444) Erwartete Gesamtartenzahl ? 480 57 49 36 Anzahl der Fundmeldungen 9500 28 19 1 11 11 0 1 R 2 G 3 V ? - © Amt der Kärntner Landesregierung Laufkäfer 370 EINLEITUNG Als eine der artenreichsten Käferfamilien Rahmen von Eingriffsplanungen, besiedeln Laufkäfer nahezu alle Erfolgskontrollen und im Landlebensräume. In Kärnten reicht das Ökosystemmonitoring. Beachtliche Spektrum vom uferbewohnenden, zeitweise Siedlungsdichten von bis zu 200 Käfern pro unter Wasser Nahrung suchenden Schwarzen Quadratmeter an vegetationslosen Grubenlaufkäfer, dem ausschließlich Schotterbänken der Alpenflüsse (HERING & anthropogene Höhlensysteme besiedelnden PLACHTER 1997) oder sogar 1000 Individuen/m2 Kellerlaufkäfer über den auf Brand- an Ackerrändern (THOMAS et al. 1992) sind gute Sukzessionsflächen spezialisierten -

Ecology and Condition of the Ground Beetle Scaphinotus Angusticollis
Ecology and Condition of the Ground Beetle Scaphinotus angusticollis and Distribution of its Prey in Pacific Northwest Riparian Forests by Susanne L. Lavallee B.Sc (University of British Columbia), 1994 M.Sc (University of British Columbia, Zoology), 1999 A THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY In THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES (Forestry) THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA September 2006 © Susanne L. Lavallee, 2006 Abstract I studied the population ecology of the flightless, forest-dwelling carabid beetle Scaphinotus angusticollis Fischer Von Waldheim (O. Coleoptera F. Carabidae) and several aspects of its body condition for their associations with forest harvesting. Comparison of population estimates revealed that catch-per-unit-effort estimates were not significantly different from more detailed analyses. In two years of trapping, S. angusticollis population densities were found to be significantly lower in clearcuts, as compared to 30 m riparian reserves and uncut forest, suggesting that riparian buffers provide adequate habitat to maintain populations of this terrestrial insect. Movement of S. angusticollis differed in the three habitats studied between years and treatments, with the greatest movement occurring in 30 m buffers in one year and in control sites the next. Clearcuts had the lowest amount of movement in both years. One of the known prey species for S. angusticollis, snails < 2 cm in diameter, were more abundant in clearcut habitat, with Ancotrema hybridum the most abundant species. Canonical correspondence analysis suggests that only A. hybridum were positively correlated with plant cover, and that other species abundances may rely on coarse, downed wood as cover. -

16 June 2021 Aperto
AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino Arthropod colonisation of a debris-covered glacier This is the author's manuscript Original Citation: Availability: This version is available http://hdl.handle.net/2318/85596 since Published version: DOI:10.1177/0959683610374885 Terms of use: Open Access Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law. (Article begins on next page) 26 September 2021 This is an author version of the contribution published on: Questa è la versione dell’autore dell’opera: M. Gobbi, M. Isaia, F. De Bernardi (2011) Arthropod colonisation of a debris-covered glacier. The Holocene 21 (2): 343-349, DOI: 10.1177/0959683610374885 The definitive version is available at: La versione definitiva è disponibile alla URL: http://hol.sagepub.com/content/21/2/343 Arthropod colonisation of a debris-covered glacier Mauro Gobbi1*, Marco Isaia2 and Fiorenza De Bernardi3 *1Sezione di Zoologia degli Invertebrati e di Idrobiologia, Museo Tridentino di Scienze Naturali, Via Calepina 14, I-38122, Trento, Italy. E-mail: [email protected]. 2Laboratorio Ecosistemi Terrestri, Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo, Università di Torino, Via Accademia Albertina 13, I-10123 Torino, Italy. 3Sezione di Zoologia e Citologia, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Milano, Via Celoria 26, I-20133, Milan, Italy. *Correspondence author: Mauro Gobbi Sezione di Zoologia degli Invertebrati e di Idrobiologia, Museo Tridentino di Scienze Naturali, Via Calepina 14, I-38122, Trento, Italy. -

Interacting Effects of Forest Edge, Tree Diversity and Forest Stratum on the Diversity of Plants and Arthropods in Germany’S Largest Deciduous Forest
GÖTTINGER ZENTRUM FÜR BIODIVERSITÄTSFORSCHUNG UND ÖKOLOGIE - GÖTTINGEN CENTRE FOR BIODIVERSITY AND ECOLOGY - Interacting effects of forest edge, tree diversity and forest stratum on the diversity of plants and arthropods in Germany’s largest deciduous forest Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultäten der Georg-August-Universität Göttingen vorgelegt von M.Sc. Claudia Normann aus Düsseldorf Göttingen, März 2015 1. Referent: Prof. Dr. Teja Tscharntke 2. Korreferent: Prof. Dr. Stefan Vidal Tag der mündlichen Prüfung: 27.04.2015 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS CHAPTER 1 GENERAL INTRODUCTION ................................................................................. - 7 - Introduction ....................................................................................................................... - 8 - Study region ..................................................................................................................... - 10 - Chapter outline ................................................................................................................ - 15 - References ....................................................................................................................... - 18 - CHAPTER 2 HOW FOREST EDGE–CENTER TRANSITIONS IN THE HERB LAYER INTERACT WITH BEECH DOMINANCE VERSUS TREE DIVERSITY ....................................................... - 23 - Abstract ........................................................................................................................... -

Bertok Et Al 2012 Sedgeol Postprint
This Accepted Author Manuscript (AAM) is copyrighted and published by Elsevier. It is posted here by agreement between Elsevier and the University of Turin. Changes resulting from the publishing process - such as editing, corrections, structural formatting, and other quality control mechanisms - may not be reflected in this version of the text. The definitive version of the text was subsequently published in Sedimentary Geology, Vol. 251-252, 2012, doi:10.1016/j.sedgeo.2012.01.012 You may download, copy and otherwise use the AAM for non-commercial purposes provided that your license is limited by the following restrictions: (1) You may use this AAM for non-commercial purposes only under the terms of the CC-BY-NC- ND license. (2) The integrity of the work and identification of the author, copyright owner, and publisher must be preserved in any copy. (3) You must attribute this AAM in the following format: Creative Commons BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en), [ + Digital Object Identifier link to the published journal article on Elsevier’s ScienceDirect® platform ] 1 Kilometre-scale palaeoescarpments as evidence for Cretaceous synsedimentary tectonics in the External Briançonnais Domain (Ligurian Alps, Italy) Carlo Bertok a*, Luca Martire a, Elena Perotti a, Anna d’Atri a, Fabrizio Piana b a Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Torino, via Valperga Caluso 35, 10125 Torino, Italy b CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Geoscienze e Georisorse, unità di Torino, via Valperga Caluso 35, 10125 Torino, Italy *Corresponding author. e-mail address: [email protected] phone : +39 011 6705335 fax : +39 011 6705339 ABSTRACT In the central part of the External Ligurian Briançonnais in the Ligurian Alps (NW Italy), a large and diverse set of stratigraphic, sedimentologic and petrographic data provides evidence for the occurrence of Cretaceous kilometre-scale palaeoescarpments. -

Archivio Istituzionale Open Access Dell'università Di Torino
AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino New data on post-Eocene tectonic evolution of the External Ligurian Briançonnais (Western Ligurian Alps) This is the author's manuscript Original Citation: Availability: This version is available http://hdl.handle.net/2318/99382 since Terms of use: Open Access Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law. (Article begins on next page) 11 October 2021 This is an author version of the contribution published on: Questa è la versione dell’autore dell’opera: Italian Journal of Geosciences, Vol. 128, No. 2, pp. 353‐366 (DOI: 10.3301/IJG.2009.128.2.353) The definitive version is available at: La versione definitiva è disponibile alla URL: http://www.socgeol.it/374/italian_journal_of_geosciences.html New data on post-Eocene tectonic evolution of the External Ligurian Briançonnais (Western Ligurian Alps) FABRIZIO PIANA (∗∗), ALESSIA MUSSO (*), CARLO BERTOK (∗), ANNA D’ATRI (*), LUCA MARTIRE (*), ELENA PEROTTI (*), DARIO VARRONE (**), GIORGIO MARTINOTTI (*) Nuovi dati sull’evoluzione tettonica post-eocenica del Brianzonese Ligure Esterno (Alpi liguri occidentali) (∗∗) CNR, Istituto di Geoscienze e Georisorse, via Valperga Caluso 35 10125 Torino, Italy; [email protected]; [email protected]. (∗) Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Torino, via Valperga Caluso 35 10125 Torino, Italy; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]. -

Insects of Lazovsky Nature Reserve
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES FAR EASTERN BRANCH INSTITUTE OF BIOLOGY AND SOIL SCIENCE LAZOVSKY STATE NATURE RESERVE NAMED AFTER L.G. KAPLANOV INSECTS OF LAZOVSKY NATURE RESERVE VLADIVOSTOK DALNAUKA 2009 РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛО厂О—ПОЧВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК им. Л.厂.КАПЛАНОВА НАСЕКОМЫЕ ЛАЗОВСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ВЛАДИВОСТОК ДАЛЬНАУКА 2009 УДК 595,7+595.4+595.6(571.63} Насекомые Лазовского заповедника. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 464 с. + цв. вкл.16 с. ISBN 978-5-8044-0992-1 В книге обобщены результаты многолетних исследований насекомых, а также пауков и многоножек Лазовского государственного заповедника им. J1.F. Капланова. Дан обзор истории изучения членистоногих заповедника, охарактеризованы его ландшафт, климат и растительность, освещены методы и места сборов коллекционного материала. Приведены аннотированные списки 6108 видов насекомых из 290 семейств, 231 вида пауков из 31 се- мейства и 18 видов многоножек из 9 семейств, основанные на изучении более чем 100 тыс. экземпляров, собранных в заповеднике. Для каждого вида даны синонимия, ранее опубли- кованные литературные данные, число исследованных особей, места сбора в заповеднике и его окрестностях, местообитания, встречаемость и общее распространение. Впервые для фауны России указано 53 вида, для Дальнего Востока 一 56, а для Приморского края 一 85 видов. Книга предназначена для зоологов, биогеофафов, специалистов в области охраны окружающей среды, преподавателей и студентов высших учебных заведений. Библ. 785,ил л.1,табл.1. Insects of Lazovsky Nature Reserve. - Vladivostok: Dalnauka, 2009. 一 464 p. + col. pis 16 p. ISBN 978-5-8044-0992-1 The book treats the results of the long-term investigations on insects of Lazovsky Nature Reserve named after L.G. -
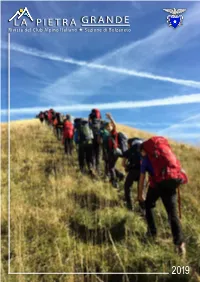
Pietragrande La
LA PIETRA GRANDE Rivista del Club Alpino Italiano « Sezione di Bolzaneto 2019 LA PIETRA GRANDE RIVISTA DEL CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di BOLZANETO Via C. Reta 16r - Tel. e Fax 010.740.61.04 - 16162 Genova Da Bologna a Santiago de Compostela....50 www.caibolzaneto.it - [email protected] di Giorgio Trotter Apertura Sede e tesseramento: giovedì ore 21 Api e Vale sull’Alta Via dei Monti Liguri.....52 di Franco Api e Valentina Vinci Un’esperienza di vita...............................54 LA PIETRA GRANDE Rivista del Club Alpino Italiano « Sezione di Bolzaneto di Stefano Camarda Cos’è Alvi Trail?.........................................56 Sommario di Marzia Gelai Capodanno in solitaria notturna..............57 di Marco Ferrando Trek in Portogallo dalla A alla Z...............60 CAI SEZIONE di BOLZANETO.......................2 di Sabrina Poggi e Michela Repetto Il socio agente del corretto rapporto con la Sulla Cima di Nasta..................................64 montagna.................................................3 di Bruna Carrossino di Nadia Benzi CULTURA.............................................68 Anno XII • Numero 12 2019 ALPINISMO.........................................5 Monte Carmo, storia di una croce di La Montagna si sconta... salendo..............5 vetta......................................................68 di Salvatore Gabbe Gargioni di Pietro Pitter Guglieri In copertina: “Verso il blu” 1...8 e 1…9 ma l’Alpinismo non dà i 25 aprile sull’Antola per ricordare Guido Foto di Valentina Vinci numeri!.......................................................7 -

Carte NTP GB-D
Alpes de Haute-Provence / Provincia di Cuneo New Shared Territory - Neues geteiltes Gebiet Outdoor activities / Outdoor-Tätigkeiten Motorbike Tours in France / Motorradrouten Storming the Alpes Grandes Randonnées (GR®) itineraries 1 Routen der Grandes Randonnées (GR®) Der Angriff der Alpen Sensitive natural area Motorways Torino ® - GR 4 Haute-Provence through the Verdon Gorges Empfindlicher Naturraum Autobahn ® Jean Giono road Torino - GR 4 die Haute-Provence durch die Verdon-Schluchten 2 Carignano ® Straße Jean Giono - GR 653D Path to Santiago de Compostela: Montgenevre-Arles Protected areas Main road Asti ® - GR 653D Weg nach Santiago di Compostela: Monginevro-Arles Naturschutzgebiete Hauptverkehrsstraße - GR®406 The Route Napoléon on foot or on horseback 3 Provence Highlands road ® Straße de Hautes Terres de Provence Asti - GR 406 Die Route Napoléon zu Fuß oder zu Pferd 3,000 m (9,842 ft) mountains Secondary road Pinerolo ® - GR 56 Tour of Ubaye Berge > 3.000 m Nebenverkehrsstraße - GR®56 Tour de l’Ubaye 4 Peaks road Rocche del Roero Gebirgskammstraße - GTPA Grande Traversata delle Prealpi Railways Casalgrasso Montà - GTPA Weitwanderweg der Voralpen Great Alps Road Govone Eisenbahn Canale - GTA Grande Traversata delle Alpi Straße der Grandes Alpes Polonghera Ceresole Motorbike Tours in Italy / Motorradrouten d’Alba S. Stefano Roero Priocca - GTA Weitwanderweg der Alpen Alternative route / Variante Faule Caramagna Train des Pignes Piemonte Monteu Roero Castellinaldo Les Chemins de fer Following transhumance Lavender road Montaldo Vezza -
Effects of Climate on Diversity Patterns in Ground Beetles: Case Studies in Macroecology, Phylogeography and Global Change Biology
EFFECTS OF CLIMATE ON DIVERSITY PATTERNS IN GROUND BEETLES: CASE STUDIES IN MACROECOLOGY, PHYLOGEOGRAPHY AND GLOBAL CHANGE BIOLOGY Der Fakultät Nachhaltigkeit der Leuphana Universität Lüneburg zur Erlangung des Grades Doktorin der Naturwissenschaften – Dr. rer. nat. – vorgelegte Dissertation von Katharina Homburg geb. Schäfer am 16.03.1984 in Stadthagen 2013 Eingereicht am: 15.01.2013 Betreuer und Erstgutachter: Prof. Dr. Thorsten Assmann Zweitgutachter: Prof. Dr. Tamar Dayan Drittgutachter: Prof. Dr. Achille Casale Tag der Disputation: 20.12.2013 COPYRIGHT NOTICE: Cover picture: Modified photograph of Carabus irregularis. Copyright of the underlying photograph is with O. Bleich, www.eurocarabidae.de. Chapters 2, 3, 4 and 5 have been either published, submitted for publication or are in preparation for publication in international ecological journals. Copyright of the text and the figures is with the authors. However, the publishers own the exclusive right to publish or use the material for their purposes. Reprint of any of the materials presented in this thesis requires permission of the publishers and the author of this thesis. CONTENTS CONTENTS Zusammenfassung ...................................................................................................................... 1 Summary .................................................................................................................................... 4 1 General introduction and conclusions ............................................................................... -

21 2000 Bisio Secondo Contributo Alla Conoscenza Di Carabus Del Subg Orinocarabus Del Piemonte Carabus Putzeysianus E Il Gruppo
RIV. PIEM. ST. NAT., 21, 2000: 115-152 LUIGI BISIO * SECONDO CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DI CARABUS DEL SUBG. ORINOCARABUS DEL PIEMONTE: CARABUS PUTZEYSIANUS, E IL GRUPPO FAIRMAIREI-CENISIUS-HETEROMORPHUS (Coleoptera Carabidae) SUMMARY - The second contribution to the knowledge of the Carabus species of the subg. Orinocarabus in Piedmont, Italy: Carabus putzeysianus, and the fairmai- rei-cenisius-heteromorphus species group. This work is the results of twenty years of researches about four Carabus spe- cies of subg. Orinocarabus (putzeysianus, fairmairei, cenisius, heteromorphus) in Western Alps of Piedmont. Observations about taxonomy, distribution and eco- logy of these species are presented. RIASSUNTO - Questo lavoro è il risultato di vent’anni di ricerche su quattro spe- cie di Carabus del subg. Orinocarabus (putzeysianus, fairmairei, cenisius, hetero- morphus) nelle Alpi Occidentali piemontesi. Vengono riportate alcune osservazio- ni sulla tassonomia, sulla corologia e sull’ecologia delle suddette specie. Dopo un primo contributo dedicato interamente a Carabus latreilleanus (Bisio, 1999), mi occupo in questa nota di Carabus putzeysianus e delle spe- cie del gruppo fairmairei-cenisius-heteromorphus. Il presente lavoro, frutto di quasi trent’anni di escursioni effettuate nelle valli piemontesi delle Alpi Marittime, Cozie e Graie, si propone soprattutto di approfondire nei dettagli la corologia dei diversi taxa, individuandone con maggior precisione sia i limiti dei rispettivi areali, sia le zone di vica- rianza, riportando inoltre, per qualche specie, alcune considerazioni sulla tassonomia, sull’ecologia e sulla fenologia. Carabus (Orinocarabus) putzeysianus Géhin, 1876 La specie è stata indagata di recente da diversi autori (Casale & Cavaz- zuti, 1976; Deuve & Simard, 1977; Casale et al., 1982; Casale & Vigna Ta- glianti, 1993; Cavazzuti & Meli, 1999) che ne hanno chiarito lo status tasso- * via Galilei 4 - 10082 Cuorgnè (TO) 115 Carabus (Orinocarabus) del Piemonte: C. -
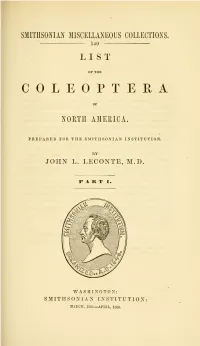
Smithsonian Miscellaneous Collections
SMITHSONIAN MISCELLANEOUS COLLECTIONS. 140 LIST COLEOPTERA NORTH AMERICA. PREPARED FOR THE SMITHSONIAN INSTITUTION. BY JOHN L. LECONTE, M.D. PART I. WASHINGTON: SMITHSONIAN INSTITUTION: MARCH, 18G3.—APRIL, 1866. : — ADVERTISEMENT. A catalogue of the described Coleoptera of the United States, prepared by Dr. F. E. Melsheimer, and revised by Prof. Halde- man and Dr. LeConte, was published by the Smithsonian Insti- tution in 1853. This work furnished a reference to all the species described at the time, and known to the author or editors, but did not profess to indicate what were synonymes and what actual species. Dr. LeConte has since had in view a new and improved cata- logue, and by his own researches, and by reference to those of others, has endeavored to ascertain the proper synonymy of the North American Coleoptera, adding the new species described since the date of the Melsheimer Catalogue. The portion of the New List, now published, includes all the families treated of in Part I of the Classification of the Coleop- tera of North America, by Dr. LeConte, who will complete that work, with its companions, the "List," and the "Descriptions of New Species of North American Coleoptera," at the earliest practicable moment. Pages 1 published in March, 1863 50 10 in —49 were ; pp. April, 1866. JOSEPH HENRY, Secretary S. I. Smithsonian Institution, Washington, April, 1866. PHILADELPHIA COLLINS, PRINTEE. NOTICE. The present catalogue was commenced in 1861, and the portion now issued was, in great part, printed as early as June, 1862. The official duties of the author have since left him but little time for scientific research ; but believing that the catalogue, even in its present incomplete condition, will be of service to students, he has considered it proper not to retard its appearance any longer.