Sacco, Ver Sacrum, Ch&K 2016-2017 Upd 27.07.2018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

THE PONTIFICAL LAW of the ROMAN REPUBLIC by MICHAEL
THE PONTIFICAL LAW OF THE ROMAN REPUBLIC by MICHAEL JOSEPH JOHNSON A Dissertation submitted to the Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in Classics written under the direct of T. Corey Brennan and approved by ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ New Brunswick, New Jersey October, 2007 ABSTRACT OF THE DISSERTATION The Pontifical Law of the Roman Republic by MICHAEL JOSEPH JOHNSON Dissertation Director: T. Corey Brennan This dissertation investigates the guiding principle of arguably the most important religious authority in ancient Rome, the pontifical college. Chapter One introduces the subject and discusses the hypothesis the dissertation will advance. Chapter Two examines the place of the college within Roman law and religion, giving particular attention to disproving several widely held notions about the relationship of the pontifical law to the civil and sacral law. Chapter Three offers the first detailed examination of the duties of the pontifical college as a collective body. I spend the bulk of the chapter analyzing two of the three collegiate duties I identify: the issuing of documents known as decrees and responses and the supervision of the Vestal Virgins. I analyze all decrees and responses from the point of view their content, treating first those that concern dedications, then those on the calendar, and finally those on vows. In doing so my goal is to understand the reasoning behind the decree and the major theological doctrines underpinning it. In documenting the pontifical supervision of Vestal Virgins I focus on the college's actions towards a Vestal accused of losing her chastity. -

The Roman Army's Emergence from Its Italian Origins
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Carolina Digital Repository THE ROMAN ARMY’S EMERGENCE FROM ITS ITALIAN ORIGINS Patrick Alan Kent A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Chapel Hill 2012 Approved by: Richard Talbert Nathan Rosenstein Daniel Gargola Fred Naiden Wayne Lee ABSTRACT PATRICK ALAN KENT: The Roman Army’s Emergence from its Italian Origins (Under the direction of Prof. Richard Talbert) Roman armies in the 4 th century and earlier resembled other Italian armies of the day. By using what limited sources are available concerning early Italian warfare, it is possible to reinterpret the history of the Republic through the changing relationship of the Romans and their Italian allies. An important aspect of early Italian warfare was military cooperation, facilitated by overlapping bonds of formal and informal relationships between communities and individuals. However, there was little in the way of organized allied contingents. Over the 3 rd century and culminating in the Second Punic War, the Romans organized their Italian allies into large conglomerate units that were placed under Roman officers. At the same time, the Romans generally took more direct control of the military resources of their allies as idea of military obligation developed. The integration and subordination of the Italians under increasing Roman domination fundamentally altered their relationships. In the 2 nd century the result was a growing feeling of discontent among the Italians with their position. -

Roman Religion
4 Roman Religion 1. “By pietas and fides the Romans Reached TheiR PResent eminence” the strength of Rome rested on a number of foundations. Among these were its extraordinarily vital political culture and its capacity to sustain warfare for extended periods of time. Previous chapters have emphasized these features, but in this chapter and the next, focus shifts to less obvious sources of Rome’s strength, namely the special character of its society whose dual foundations were the household and the civic religion of the city. Roman Religiosity during the period of the Republic, outsiders were struck by the religiosity of the Romans. In the second century b.c., Polybius, a Greek statesman and historian who lived much of his adult life in Rome, claimed that it was “scrupulous fear of the gods that kept the Roman commonwealth together” (6.56). A century or so later another expatriate Greek, Dionysius of Halicarnassus, was also impressed by the concern of Romans for religion. Writing about the second king of Rome, dionysius noted that as a result of Numa’s activities, Rome possessed more religious observances than any other city “Greek or non-Greek, even among those who thought of themselves as most god- fearing” (2.63). Needless to say, Romans themselves promoted the belief that fidelity to their oaths and treaties and their general reverence for the gods explained their imperial success. “the gods look kindly on these qualities, for it was by pietas and fides that Romans reached their present eminence” declared the consul Q. Marcius Philippus in 169 b.c. -

Adriano La Regina, La Lancia E Il Toro
LA CULTURA A CURA DI ENRICO NARCISO DELLA TRANSUMANZA GUIDA EDITORI Atti del Convegno promosso dal Comune di Santa Croce del Sannio dall'Istituto Storico « Giuseppe Maria Galanti» e dalla Comunità Montana « Alto Tammaro» 12-13 novembre 1988 LA CULTURA DELLA TRANSUMANZA a cura di Enrico Narciso Guida editori Il Convegno si è svolto con il contributo del Ministero ai Beni Culturali e Ambientali, della Regione Campania, della Comunità Montana « Alto Tammaro », del Comune di Santa Croce del Sannio. Copyright 1991 Guida editori Napoli Grafica di Sergio Prozzillo ISTITUTO STORICO « GIUSEPPE MARIA GALANTI» Comitato scientifico Raffaele Ajello, Raffaele Colapietra, Romeo De Maio, Giuseppe Galasso Giuseppe Giarrizzo, Marcello Gigante, Adriano La Regina Augusto Placanica, Fulvio Tessitore, Pasquale Villani ADRIANO LA REGINA La lancia e il toro I Sanniti hanno preso il nome dalle lane e che usavano portare e che i Greci chiamano saunia, oppure dal colle Sannio, ove si insediarono provenendo dalla Sabina. CosÌ viene riassunta da Paolo Diacono, contemporaneo di Carlo Magno, la voce Samnites nella sua epitome 1 del diziona rio De verborum significatu che Sesto Pompeo Festo aveva compilato nel II o nel III secolo d.C., riassumendo a sua volta l'enciclopedia omonima di Verrio FIacco, autore vissuto all' e poca e nella cerchia di Augusto. Coesistevano infatti, sulle origini dei Sanniti e del loro nome, due tradizioni distinte. La prima, formatasi in ambienti greci, è manifestamente infondata ma è tuttavia interessante, per comprendere i rapporti tra la Magna Grecia e il Sannio. L'altra, autoctona, è invece più aderente alla realtà, perché basata sulla evidente affinità etnica 1 Excerpta ex libris Pompei Festi de significatione verborum, Lindsay 1913, p. -

Dionysius of Halicarnassus and the 'Founders' of Rome
Dionysius of Halicarnassus and the ‘Founders’ of Rome: Depicting Characters in the Roman Antiquities by Beatrice Poletti A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Classical Languages Department of History and Classics University of Alberta © Beatrice Poletti, 2018 ABSTRACT In my thesis, I analyze Dionysius’s presentation of some of the most celebrated characters of Rome’s early past: Aeneas, Romulus, Numa Pompilius, L. Junius Brutus, and M. Furius Camillus. The thesis is composed of Five Chapters, an introduction, and a conclusion. In Chapter 1, I describe the background to Dionysius’s arrival in Rome, focusing on the literary milieu of the capital. In Chapter 2, I discuss Dionysius’s work and the ideas underlying the conception of the Roman Antiquities. In Chapter 3, I examine Dionysius’s account of the Aeneas legend. I deal with the legends of Romulus and Numa, respectively, at Chapters 4.1.1 and 4.2, and 4.1.2 and 4.3. My analysis of the stories of L. Junius Brutus and M. Furius Camillus occupies Chapters 5.1 and 5.2. I have chosen these characters for my study because of their significance in the Romans’ conception of their early past and their association with key events and institutions of Roman history, as well as the political meaning which their figures eventually acquired. By Dionysius’s time, all these characters (with the exception of L. Brutus) had come to embody the qualities and political virtues of the princeps. Aeneas was the progenitor of the Roman race as well as Augustus’s personal ancestor through his adoption into the gens Julia. -

Reconstructing Religion Augustus and the Fratres Arvales Sarah Limoges
Reconstructing Religion Augustus and the Fratres Arvales Sarah Limoges Department of History McGill University Montreal, Canada August 2010 A thesis submitted to McGill University in partial fulfilment of the requirements of the degree of Master of Arts Sarah Limoges 2010 Library and Archives Bibliothèque et Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de l’édition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A 0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre référence ISBN: 978-0-494-72788-1 Our file Notre référence ISBN: 978-0-494-72788-1 NOTICE: AVIS: The author has granted a non- L’auteur a accordé une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant à la Bibliothèque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par télécommunication ou par l’Internet, prêter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des thèses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, à des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non- support microforme, papier, électronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L’auteur conserve la propriété du droit d’auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protège cette thèse. Ni thesis. Neither the thesis nor la thèse ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent être imprimés ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation. -
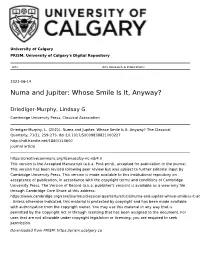
Numa and Jupiter: Whose Smile Is It, Anyway?
University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository Arts Arts Research & Publications 2021-06-14 Numa and Jupiter: Whose Smile Is It, Anyway? Driediger-Murphy, Lindsay G. Cambridge University Press, Classical Association Driediger-Murphy, L. (2021). Numa and Jupiter: Whose Smile Is It, Anyway? The Classical Quarterly, 71(1), 259-275. doi:10.1017/S0009838821000227 http://hdl.handle.net/1880/113600 journal article https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 This version is the Accepted Manuscript (a.k.a. Post-print), accepted for publication in the journal. This version has been revised following peer review but was subject to further editorial input by Cambridge University Press. This version is made available to this institutional repository on acceptance of publication, in accordance with the copyright terms and conditions of Cambridge University Press. The Version of Record (a.k.a. publisher's version) is available as a view-only file through Cambridge Core Share at this address: https://www.cambridge.org/core/journals/classical-quarterly/article/numa-and-jupiter-whose-smile-is-it-anyway/920201DB4C14523C3264EC3487533D85/share/f9f5662ce7ad1712f44dd4d00adfc73c54ee3fc5 . Unless otherwise indicated, this material is protected by copyright and has been made available with authorization from the copyright owner. You may use this material in any way that is permitted by the Copyright Act or through licensing that has been assigned to the document. For uses that are not allowable under copyright legislation or licensing, you are required to seek permission. Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca 1 NUMA AND JUPITER: WHOSE SMILE IS IT, ANYWAY? Roman tradition held that Numa and his people had once been terrified by frequent lightning bolts, signs of the wrath of Jupiter. -

Some Remarks on War Rituals in Archaic Italy and Rome and the Beginnings of Roman Imperialism
ELECTRUM * Vol. 21 (2014): 87–97 doi: 10.4467/20800909EL.14.001.2781 www.ejournals.eu/electrum SOME REMARKS ON WAR RITUALS IN ARCHAIC ITALY AND ROME AND THE BEGINNINGS OF ROMAN IMPERIALISM Maciej Piegdoń Jagiellonian University, Kraków Abstract: The success of Roman expansion in the Republican period and the durability of the empire, which survived the fall of the Republic and continued to function for the next few hun- dred years under the rule of emperors, drew the attention of both scholars and rulers in subsequent eras. The Imperium Romanum became a model for other states that attempted to build their own empires in later times. What captures our attention in discussions on Roman imperialism is mainly one, so far unresolved, dilemma: was Roman expansion a result of the material and psychologi- cal benefi ts that individual social groups enjoyed as a result of the aggressive policy, or a product of the Roman society’s atavistic tendencies for using violence? This seems to be a very diffi cult question to answer. If we also consider other elements that cause aggression, such as fright, fear (metus Gallicus, Punicus, Etruscus, etc.) of something or someone and a desire to win fame or glory over an enemy, then solving the problem seems impossible indeed. Finding the right answer is not made any easier by the historical sources. On the one hand, they are very biased, as they hide the actual reasons under a thick layer of propaganda and apologetic slogans; so thick, in fact, that in many cases the Romans’ true motives seem incomprehensible. -

De Religionibus Sacris Et Caerimoniis Est Contionatus: Piety and Public Life in Republican Rome
DE RELIGIONIBUS SACRIS ET CAERIMONIIS EST CONTIONATUS: PIETY AND PUBLIC LIFE IN REPUBLICAN ROME Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Jack C. Wells, M.A. * * * * * The Ohio State University 2004 Dissertation Committee: Approved by Professor Nathan S. Rosenstein, Adviser Professor Timothy E. Gregory ________________________ Professor Sarah Iles Johnston Adviser History Graduate Program ABSTRACT This study explores how piety became a topic for public discussion during ancient Rome’s middle and late Republican eras (264-31 B.C.). It examines public religious discussions in Rome, in particular the conflict between P. Clodius Pulcher (c. 92-52 B.C.) and M. Tullius Cicero (106-43 B.C.), who brought each other’s piety to the attention of their fellow citizens as part of their public rivalry. It aims to understand what caused disputes over piety and how these disputes were resolved. Public conflicts involving a person’s piety tended to occur when some novelty or unforeseen element was introduced into Roman religious life, since in these situations tradition did not provide guidelines on what the community had to do to fulfill its obligation to the gods. Such disputes often had a political element to them, but this ‘politicization’ did not indicate corruption and decline. Instead, it was inevitable, given the link between religion and politics in Roman civic life, that politics would play a role in religious conflicts. Disputes over piety took place in a wide variety of fora: in the senate, before popular assemblies, in front of priestly colleges, and in the courts. -

Reflections on a Mirror: Possible Evidence For
http://akroterion.journals.ac.za/ AKROTERION XL (1995) 64-79 ISSN 0303-1896 REFLECTIONS ON A MIRROR: POSSIBLE EVIDENCE FOR THE EARLY ORIGIN OF THE CANONICAL VERSION OF THE ROMAN FOUNDATION LEGEND P.M.W. Tennant, University of Natal, Pietermaritzburg T.P. Wiseman (1991: 115-124) suggests that the whole story of the twins - and in particular the life and death of Remus - was progressively invented between the Lex Licinia Sextia in 367 and the battle of Sentinum in 295, a period which "saw the establishment of a new mythology, a new way of making sense of Rome and her destiny in an era of cataclysmic change".1 Wiseman has not beel) the only scholar to postulate a relatively late development of the Romulus and Remus legend: H. Strasburger (1968) argued that it was created during the last decades of the 4th century or, more probably, during the first decades of the 3rd. Furthermore, he maintained that, because the tale contained elements - notably that of fratricide - which did not reflect favourably on the image of Rome, it was essentially the product of anti-Roman propaganda. Wiseman, on the other hand, suggests that Remus represents the Roman plebs and that the twins actually symbolise the "power-sharing" between patricians and plebeians brought about by the Licinio-Sextian laws. The starting point of Wiseman's thesis is that the plebs' "lateness" in coming to power is reflected in the name "Remus", which signifies "slowness"; and he cites the etymology given in the Origo Gentis Romanae (21.5), where "Romulus" is derived from "rhome" ("strength") and "Remus" from "remores", because that is what the ancients called people who were "slow" by nature . -

Pre-Republican Rome
CHAPTER ONE The Rise of Rome to 264 BC John Serrati Now I will set forth the glory that awaits the Trojan race, the illustrious souls of the Italian heirs to our name. I will teach you your destiny … Under [Romulus’] auspices, my son, Rome’s empire will encompass the Earth, its glory will rival Olympus … This will be your destiny, Roman, to rule the world with your power. These will be your arts: to establish peace, to spare the humbled, and to conquer the proud. By the time Vergil put these words into the mouth of Anchises as he showed his son Aeneas the glories that awaited his lineage, Rome controlled the entire Mediterranean and had already established itself as one of history’s leading imperial states. In the last decades of the first century, though in all likelihood going back to Cicero, there was a belief among some Romans that it was their destiny to rule an empire, that they had not become so powerful simply by happenstance but because conquest was somehow part of their psyche, and that early on in their history they were marked out as different, even gifted, when it came to the art of war. It has recently been argued that at no point in its history was the Roman Republic ever markedly more aggressive or imperi- alistic than contemporary states, yet it is unlikely that Rome owed the empire of Cicero or Vergil’s times merely to the might of its legions.1 By the fourth century Rome was almost certainly militarized to a far greater extent than any of its neighbors, and within a short time a hypercompetitive, aggressive, and warlikeCOPYRIGHTED nobility would emerge as MATERIAL leaders of the state, while the classes that made up the common soldiery themselves favored war due to the plunder which it provided. -

Young Roman Males, Environmental Scarcity, and The
Endowment or Curse? Young Roman Males, Environmental Scarcity, and the Origins of Roman Expansionism R. Bruce Hitchner I begin with two quotations. First from Livy providing a rationale for the siege of Veii: There was no year in which there was not a pitched battle and, as if they [the patricians] did not have enough trouble, a new war was being prepared against very powerful neighbors who were bound to stir up all of Etruria. This spontaneous agitation was further inflamed by the tribunes of the plebs who repeatedly said that the senators’ biggest war was with the plebeians. These were the men the patricians deliberately exposed to the hardships of military service and to slaughter by the enemy. These were the men they kept in exile far from the city, lest, if they were quietly at home, they should start thinking about liberty and colonies and agitate for public land or the free exercise of their votes.1 Later, describing the conflicts with the Latins in 380 B.C. he observes: Wars were now sought indiscriminately, far and wide; from Antium the legions had been marched to Satricum, from Satricum to Velitrae, from there to Tusculum; now it was the Latins, the Hernici, and the Praenestini who were threatened with attack, more out of hatred of Rome’s citizens [i.e. its young men] than of her enemies. The object was to wear out the plebeians with service and give them no time to take a breath in the city, or leisure to think of liberty or to stand in the assembly.2 1 Livy 4.58 (Warrior translation).