Ricerche Sulle Architetture Dell'acqua in Sardegna
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Abbreviations
Abbreviations Archival sources ACSR Archivo Centrale dello Stato, Rome. AG Archives de Guerre, Vincennes. AMAE Archives, Ministere des Affaires Etrangeres, Paris ANP Archives Nationales, Paris. ASN Archivio dello Stato, Napoli. BNP Bibliotheque Nationale, Paris. Archival series AP Archives Privees (ANP). CC Carte Crispi (ACSR). FI Fonds Italiens (BNP). Min. GG Ministero di Grazia e Giustizia (ACSR). Min. Int. Ministero degli Interni (ACSRlASN). Journals AEUI Archivio Economico dell'Unificazione Italiana. AHR American Historical Review. AIISS Annali dell'Istituto Italiano per Gli Studi Storici. AISMC Annuario dell'Istituto Italiano per la Storia Moderna e Contemporanea. ASCL Archivio Storico per la Calabria e la Lucania. ASM Archivio Storico Messinese. ASPN Archivio Storico per le Provincie Napoletane. ASSO Archivio Storico per la Sicilia Orientale. ABBREVIATIONS 361 CIHSE Cahiers Internationaux de I'Histoire Sociale et Eeonomique (Geneva). CJH Criminal J ustiee History . CSSH Comparative Studies in History and Society. EeHR Eeonomie History Review. ER Etudes Rurales. EUI European University Institute, Working Papers. GE Giornale degli Eeonomisti. HJ Historical Journal. IAHCCJ International Association for the History of Crime and Criminal Justice, Newsletter. JEEH Journal of European Eeonomie History. JEeH Journal of Eeonomie History. JIH Journal of Italian History. JPS Journal of Peasant Studies. JSH Journal of Social History. MEFR Melanges de I'Eeole Franc;aise de Rome. MO Movimento Operaio. MOS Movimento Operaio e Soeialista. NA Nuova Antologia. NRS Nuova Rivista Storiea. PP Past and Present. QFSPGM Quaderni Fiorentini per la Storia deI Pensiero Giuridieo Moderno. QB Quaderni Storiei. RISN Rivista Italiana di Studi Napoleoniei. RSC Rivista di Storia Contemporanea. RSI Rivista Storiea Italiana. RSR Rassegna Storiea deI Risorgimento. -

Rivista No. 395 Winter 2012/13
RIVISTA ISSN 1759-6939 RIVISTA No. 395 2012/13 The Magazine of the British-Italian Society 1 RIVISTA The Magazine of the British-Italian Society Co-Editors: Alexandra Richardson and Georgina Gordon-Ham No. 395 2012/2013 E-mail addresses: [email protected] [email protected] www.british-italian.org © The British-Italian Society 2012 Printed by EVONPRINT Ltd TABLE OF CONTENTS – PRESIDENT NAPOLITANO’S MESSAGE 3 – SANTA MARIA DELLE GRAZIE AND SIDEBAR 20 – NATIONALISM IN 19TH CENTURY ITALIAN PAINTING 4 – ITALIAN GOLD AT THE ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY 22 – THE 2011 LECONFIELD LECTURE – ITALO CALVINO 4 – REFLECTIONS ON TWO FILMS 25 – THE SOCIETY’S CHRISTMAS DINNER 2011 6 – NELSON’S ITALIAN VALET 29 – MAFIA BROTHERHOODS 7 – PAVANE FOR A DEFUNCT HOTEL 29 – THE BEST GARDENS IN ITALY 8 – ALL THAT JAZZ 31 – PRESENTING THE ROOKE PRIZE AWARDS – DUILIO CAMBELLOTTI AND THE WATERWORKS OF BARI 32 FOLLOWED BY LECTURE ON REPRESENTATIONS – THE BRITISH SCHOOL AT ROME 34 OF THE ISLAMIC WORLD IN ITALIAN CULTURE 10 – LONDON MEMORIAL TO ARANDORA STAR VICTIMS 35 – THE LANDMARK TRUST 12 – FOSCOLO A LONDRA 36 – VENICE NOIR – AGM 13 – PIEDMONT ON A PLATE 38 – ESPERIENZA ITALIA 14 – A FAMILY IN TURMOIL: THE ITALIAN EXILE 40 – A SPASSO TRA I LIBRI 15 – BOOK REVIEWS 43 – “THERE WILL BE SHOOTING” 18 – SNIPPETS 48 EDITORIAL Dear Members Once again, The British-Italian Society has had a busy and varied films from England and Italy sent calendar of activities over the past twelve months. Attendance at to us by perhaps our youngest events has been good, we are pleased to report. -

La Carta Geologica D'italia
One of the earliest geological maps / Una delle prime carte geologiche (Biblioteca Istituto di Geologia e Paleontologia “R. Selli”, foto Vai) The Italian Geological Survey: La Carta Geologica d’Italia: the early history of a divided community agli inizi di un lungo contenzioso Pietro13 Corsi The historiography of science, and particularly of geology, as well as the La storia della scienza, e della geologia in particolare, al pari degli historiography concerned with the early formation of the Italian State, studi sulla formazione dello Stato Italiano, hanno prestato scarsa o have paid scant if any attention to the complex history of the Italian pressoché nessuna attenzione alle complesse vicende della Carta Geological Survey. Indeed, great uncertainty still prevails as to the ori- geologica d’Italia. Al punto che prevale ancora grande incertezza –a gin and source of the project to provide the new Italian State, formally leggere le fonti ottocentesche, le uniche– sulle origini e la paternità constituted as “Regno d’Italia” on January 1st, 1861, with a geological del progetto. L’eccellente biografia di Quintino Sella (1827-1884) a map. There is an excellent, ground-breaking biography of Quintino firma di Quazza si limita a brevi cenni sul coinvolgimento dello Sella (1827-1884), the wealthy Piedmontese scientist turned politician scienziato –assurto ai vertici della politica– nel rapido susseguirsi di who was one of the major actors in the early history of the survey. eventi che, a partire dal luglio del 1861, portò all’emanazione di un However, it mentions only in passing Sella’s involvement in the rapid Decreto Reale, il 12 dicembre dello stesso anno, che sanciva l’inizio succession of events, starting in July 1861, that led to the Royal decree del rilevamento geologico del paese (Quazza 1992, p. -
A History of the Birds of Europe, Not Observed in the British Isles
1 i NouniiiSNi - nvinoshhws S3iavaan libraries Smithsonian inst r Z r- rr (— to rn co E co LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOUfUllSNI NVINOSH1IWS S3 I! '* CO ? !£ ^ . Z r 2; CO - - Z^S^\ < 'a -Jfe. < /^7T^ 2 z \.\a -< A^P^tA z 9 CO CO 1 1 00 to z co NOIinillSNI_NVIN0SHllWS S3IMVyail LIBRARIES SMITHSONIAN INST 00 w - ^—. ^ ^ co y o J Z '""LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNl" NVINOSHllWS <~ S3 z r- » m - to NoiiniiisNi^NViNosHiiws^sa 1 y a vy n li b rar i es, ..Smithsonian "inst *' . H ,,*/ Z *XA X .'jfflj&ff/yi o ^.*$f -J; W • CO z % t CO CO *. z ^ LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIlfllllSNI NVIN0SH1IWS S3I 2 j NouniiiSNi^NviNOSHiiws S3 i y v y a n ""l i b r a r i es smithsonian" inst r- z — co _ co £ co LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIlfllllSNI NVIN0SH1IWS S3U 5 ^ ^ Z r CO Z CO 5 > W C/ NOIlfllllSNI NVIN0SH1IWS 'S3 I Vy I y a n^LI- B RAR ES^SMITHSONIAN^INSTI z \ w CO co -J z — _J Z LIBRAR I ES^SMITHSONIANJNSTITUTION NOIlfllllSNI NVIN0SH1IWS S3 1 z o *> lnillSNI NVIN0SH1IWS bJiaVdbll LIUKHttlta oiyiiinauniniyiiuuM - n m CO jRARIES^SMITHSONIAN'lNSTITUTION^NOIinillSNrNVINOSHHWS S3iaVM ^TITctX COO c/, z i "instituti niusNi~NviN0SH±iws S3 i a v h a n i_ i b r a r es Smithsonian < TION NOIinillSNI^NVINOSHilWS ssiava? m CO JlinillSNI NVINOSHJLMS SHiavaail LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUT Z O Z </> BRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNI NVINOSH1IWS S3IHVUI co co 5: _ — . 00 Tk /<^2?X ^ X^?~X m ^vki ^ /_, SMITHSONIAN INSTITUT JlinillSNI - NVINOSHlllMS S3.IHVaa II LIBRARIES r -, z r~ Z co - co ± co BRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNI NVINOSHJLIWS S3iavai z co z co z )linillSNI NVINOSH1IWS S3iavaan_LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUT car Z _l Z _j z BRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNI NVIN0SH1IWS S3IHVH co CO y OC! LE V DLTU R A HISTORY BIRDS OF EUROPE, NOT OBSERVED IN THE BRITISH ISLES. -

78Th Congress of the 118Th Congress of the Unione Zoologica Italiana Société Zoologique De France
78th Congress of the 118th Congress of the Unione Zoologica Italiana Société Zoologique de France Second Joint Meeting of Société Zoologique de France and Unione Zoologica Italiana Torino, 18-23 September 2017 The evolution of animal diversity: a comparative approach Abstract Book Department of Life Sciences and Systems Biology - University of Torino 1 This work is distributed under the Creative Commons 3.0 licence BY/NC/ND. You are free to use the material in any medium or format, under the following terms: Attribution (BY). You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. NoCommercial (NC). You may not use the material for commercial purposes. NoDerivs (ND). If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material. Citare come segue / Quote as follows: Donna D., Moietta M., Palestrini C., Peretto P., Roggero A., Editors, 2017 - The evolution of animal diversity: a comparative approach. Abstract Book of the Second Joint Meeting of Société Zoologique de France and Unione Zoologica Italiana. Torino, 18-23 September 2017. Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di Torino and Museo Regionale di Scienze Naturali. Torino, Italy ISBN 978-88-905691-7-3 2 Abstract Book Edited by Daniela Donna Marco Moietta Claudia Palestrini Paolo Peretto Angela Roggero 3 DIRETTIVO Unione Zoologica Italiana Elvira -

Type Specimens of Birds in the Museo Regionale Di Scienze Naturali (Torino, Italy)
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series Vol. 189 (2020), ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic) DOI: 10.37520/jnmpnhs.2020.007 Původní práce / Original paper Type specimens of Birds in the Museo Regionale di Scienze Naturali (Torino, Italy) Giorgio Aimassi1,*, Claudio Pulcher2 & Luca Ghiraldi3 1 Museo Civico «F. Eusebio», Via Paruzza 1, I-12051 Alba, Italy; email: [email protected] 2 Gruppo Piemontese Studi Ornitologici – Museo Civico di Storia Naturale, Via S. Francesco di Sales 188, I-10022 Carmagnola, Italy 3 Museo Regionale di Scienze Naturali, Via Giolitti 36, I-10123 Torino, Italy * corresponding author Aimassi G., Pulcher C. & Ghiraldi L., 2020: Type specimens of Birds in the Museo Regionale di Scienze Naturali (Torino, Italy). – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 189: 65–154. Abstract: Since the 1990s, the Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino houses the ornithological collection formerly belonging to the Zoological Museum of the University of Turin (MZUT). This collection includes about 20,500 specimens, mostly dating from the second half of the nineteenth century or early twentieth. The high number of type-specimens gives it great historical and scientific significance. The types have been described mainly by Tommaso Salvadori (171 taxa, 282 specimens) and, to a lesser extent, by other Italian authors such as Enrico Festa, Filippo de Filippi, Orazio Antinori, Enrico H. Giglioli or by foreign authors as John Gould, Eduard Rüppell, Coenraad Jacob Temminck, Philip -

The Iconography of Some Phoenician Seals and Seal Impressions
AUSTRALIAN JOURNAL OF BIBLICAL ARCHAEOLOGY THE ICONOGRAPHY OF SOME PHOENICIAN SEALS AND SEAL IMPRESSIONS W. Culican, University of Melbourne The purpose of this paper is twofold: firstly, to publish a number of seals and seal impressions and secondly, to discuss the iconography of these and their relatives within the wider context of Phoenician glyptic art and religion. Many of the seals published here have details closely comparable to examples already known. Phoenician seals, mostly of green jasper and carnelian, but with occasional examples in chalcedony, and sharing many common techniques of gravure, are particularly well represented from the Phoenician colonies in the West Mediterranean. Most of the pub lished examples come from Tharros in Sardinia1 but they are well known at Carthage,2 Utica3 and from Spain, where Ibiza,4 Villaricos5 and Gibraltm·l\ have provided examples. There is an early find of imprints of these seals from Selinunte in Sicily,' but otherwise they are rare in the Phoenician colonies of Sicily, Motya having provided a few examples,8 and none is recorded from Malta. 1. H. B. WaIters, Catal. Engraved Gems and Cameos etc. in the British !VIlIseum, 1926; many are included in A. Furtwangler, Die AI/tiken Gemmel/ , 1900 (afterwards "Furtwangler"). Many of the seals illustrated by Alberto della Marmora's Sopra a/cllne al/tichita sW'de (Memorie della Reale Accad. di Scienze, Torino, 1854) were originally published by Canon B. Spano in various volumes of BIIII arch. sW'do; C. Mansell, Gaz. arch., 1877, pp. 74-76; 1878, pp. 35-40, 50-53, discusses individual motifs from Tharros scarabs. -

An Annotated Checklist of the Italian Butterflies and Skippers (Papilionoidea, Hesperiioidea)
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Institutional Research Information System University of Turin Zootaxa 3853 (1): 001–114 ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ Monograph ZOOTAXA Copyright © 2014 Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3853.1.1 http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:D83EF7E0-51C6-4D3D-9269-CD5EDD40250E ZOOTAXA 3853 An annotated Checklist of the Italian Butterflies and Skippers (Papilionoidea, Hesperiioidea) EMILIO BALLETTO, LUIGI A. CASSULO & SIMONA BONELLI1 Department of Life Sciences and Systems Biology, Via Accademia Albertina 13, I-10123 Torino, Italy. 1Corresponding author. E-mail: [email protected] Magnolia Press Auckland, New Zealand Accepted by C. Prieto: 19 Apr. 2014; published: 20 Aug. 2014 EMILIO BALLETTO, LUIGI A. CASSULO & SIMONA BONELLI An annotated checklist of the Italian Butterflies and Skippers (Papilionoidea, Hesperiioidea) (Zootaxa 3853) 114 pp.; 30 cm. 20 Aug. 2014 ISBN 978-1-77557-473-6 (paperback) ISBN 978-1-77557-474-3 (Online edition) FIRST PUBLISHED IN 2014 BY Magnolia Press P.O. Box 41-383 Auckland 1346 New Zealand e-mail: [email protected] http://www.mapress.com/zootaxa/ © 2014 Magnolia Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted or disseminated, in any form, or by any means, without prior written permission from the publisher, to whom all requests to reproduce copyright material should be directed in writing. This authorization does not extend to any other kind of copying, by any means, in any form, and for any purpose other than private research use. -

6.2 Catalogo Della Biblioteca Dell'istituto Nazionale Di Cultura
6.2 Catalogo della Biblioteca dell’Istituto nazionale di cultura fascista Tutti dati bibliografici sono stati trasferiti da Access a Word. Per comodità di ordinamento si è ritenuto opportuno distinguere in due sezioni le opere a carattere miscellaneo da quelle attribuibili a un autore. 1 "... la nostra vecchia bandiera", Roma, Istituto nazionale di cultura fascista, 1937 (Bibliotechina corporativa) A Domenico Lettieri, Roma, Tipografica editrice, 1935 A wreath of remembrance, London, Drane, 1906 Affaire Dreyfus, Paris, Cahiers de la quinzaine, 1903 (Cahiers de la quinzaine, Ive série) Affaire Dreyfus. Débats parlementaires, Paris, 1903 (Cahiers de la quinzaine. Ive série) Albania, a cura dell'Istituto di studi adriatici, Venezia, 1939 Alberico Gentili. Scritti e discorsi, Roma, Anonima romana editoriale, 1936 Ali nel cielo. Antologia dell'aviazione, a cura di A. Bertùccioli e B. Pinchetti, Roma, Libreria del littorio, 1929? Almanach Hachette, éd. Complète, Paris, Hachette, 1931 Ancora per Amilcare Cipriani e pel diritto, Rimini, Renzetti, 1888 Anthologie des écrivains turcs d'aujourd'hui, Instanbul, Basimevi, 1935 Anthologie du travail, par J. Caillat … [et al.], Paris, Les arts et le livre, 1928 Antica oreficeria italiana, a cura di Antonio Morassi, Milano, Hoepli, 1936 (Quaderni della Triennale) Antilei, a cura di Asvero Gravelli, Roma, Nuova Europa, 1939 Antologia critica degli scrittori fascisti, a cura di Mario Carli, Firenze, Bemporad, 1931 Antologia di cattolici francesi del secolo XIX: De Maistre, Bonald, Lamennais, Balzac, D'Aurevilly, Hello, Venillot, Bloy, traduzioni e notizie di Domenico Giuliotti, Lanciano, Carabba, 1920 (Cultura dell'anima, 74) Apologia dei secoli barbari, 2. ed. corredata di nuove aggiunte, Bologna, Nobili, 1823 2 Approvvigionamenti e consumi in tempo di guerra. -

The Italian Geological Survey: the Early History of a Divided Community Pietro Corsi
The Italian Geological Survey: the Early History of a Divided Community Pietro Corsi To cite this version: Pietro Corsi. The Italian Geological Survey: the Early History of a Divided Community: dans G.B. Vai et W.Cavazza, ed, Four centuries of the word ‘Geology’, Ulisse Aldrovandi 1603 in Bologna,Minerva Edizioni, Bologna, septembre 2003, p.255-279.. 2003. halshs-00002891v2 HAL Id: halshs-00002891 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00002891v2 Preprint submitted on 29 May 2006 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. The Italian Geological Survey: the Early History of a Divided Community Pietro Corsi Université Paris I, Panthéon - Sorbonne E.H.E.S.S. [“The Italian Geological Survey: the Early History of a Divided Community”, in G.B. Vai et W.Cavazza, ed, Four centuries of the word ‘Geology’, Ulisse Aldrovandi 1603 in Bologna, Minerva Edizioni, Bologna, septembre 2003, p.255-279.] The historiography of science, and particularly of geology as well as the historiography concerned with the early formation of the Italian State, have paid scant if any attention to the complex history of the Italian geological survey. Indeed, great uncertainty still prevails as to the origin and source of the project to provide the new Italian State, formally constituted as “Regno d’Italia” on January 1st, 1861, with a geological map. -
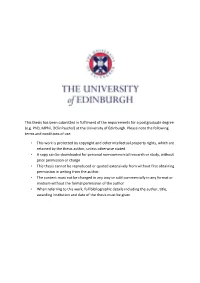
This Thesis Has Been Submitted in Fulfilment of the Requirements for a Postgraduate Degree (E.G
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: • This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. • A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. • This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. • The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. • When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. DE INVENTIO SARDINIÆ THE IDEA OF SARDINIA IN HISTORICAL AND TRAVEL WRITING 1780-1955 Sandro Corso PhD – College of Humanities and Social Sciences THE UNIVERSITY OF EDINBURGH 2010 Edinburgh, 27th December, 2010 This is to declare that the thesis herewith bound, being my own work, has been composed by myself and has not been submitted for any other degree or professional qualification. Sandro Corso 2 ABSTRACT This thesis investigates the way the national identity of Sardinia was perceived in travel literature – and more particularly the way writing about travel experiences contributed to shape identity, both of the visited place and of its inhabitants. The thesis draws from different sources (travelogues, belles lettres, history books); the work reflects therefore a rather eclectic panorama. For obvious reasons the research field has been circumscribed in time and space, but , but aims at drawing general conclusions, i.e. -

I 150 Anni Della Geologia Unitaria
UOMINI E RAGIONI: I 150 ANNI DELLA GEOLOGIA UNITARIA Sessione F4 - Geoitalia 2011 VIII Forum Italiano di Scienze della Terra Torino, 23 settembre 2011 Convener: Myriam D’Andrea, Dirigente Servizio Attività Museali, Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, Roma Lorenzo Mariano Gallo, Conservatore Sezione di Mineralogia, Petrografia e Geologia Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino Gian Battista Vai, Direttore Museo Geologico “Giovanni Capellini”, Dipartimen- to di Scienze della Terra e Geologiche Ambientali, Università di Bologna Informazioni legali L’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le persone che agiscono per conto dell’Istituto non sono responsabili per l’uso che può essere fatto delle informazioni con- tenute in questo volume. ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma www.isprambiente.gov.it ISPRA, Atti 2012 ISBN 978-88-448-0514-2 Riproduzione autorizzata citando la fonte Coordinamento tecnico-scientifico: Myriam D’Andrea ISPRA - Servizio Attività Museali [email protected] http://www.isprambiente.gov.it/it/museo Revisione linguistica degli abstract in lingua Inglese: Daniela Genta ISPRA - Settore Redazione Web Elaborazione grafica: ISPRA Grafica di copertina: ISPRA – Franco Iozzoli Foto di copertina: Schizzo geologico dell’Italia redatto da Giuseppe Gabriel Balsamo Crivelli, allegato al volume “Sullo stato geologico dell’Italia” di G. Omboni, (Ed. F. Vallardi,1856) Coordinamento tipografico: Daria Mazzella ISPRA - Settore Editoria Amministrazione: Olimpia Girolamo ISPRA - Settore Editoria Distribuzione: Michelina Porcarelli ISPRA - Settore Editoria Impaginazione: Tiburtini s.r.l. – Roma Si ringrazia la Regione Piemonte - Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino per la stampa del volume.