Villa Forni Cerato
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1. World Heritage Property Data
Periodic Report - Second Cycle Section II-City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto 1. World Heritage Property Data Villa Forni Cerato, 45.653 / 11.561 2.23 0 2.23 1996 Montecchio Precalcino , 1.1 - Name of World Heritage Property Province of Vicenza , Veneto City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto Region , Italy Comment Villa Godi 45.746 / 11.529 4.66 0 4.66 1996 Committee Decision 20COM VIIC: The name of the property Malinverni, Lonedo di Lugo was changed to “The City of Vicenza and the Palladian Villas Vicentino , of the Veneto” . (Note: "The") Province of Vicenza , Veneto Region , Italy 1.2 - World Heritage Property Details Villa Pisani Ferri, 45.359 / 11.369 1.6 0 1.6 1996 State(s) Party(ies) Bagnolo di Lonigo , Province Italy of Vicenza , Veneto Region , Type of Property Italy cultural Villa Pojana, 45.282 / 11.501 6.14 0 6.14 1996 Identification Number Poiana Maggiore , 712bis Province of Vicenza , Veneto Year of inscription on the World Heritage List Region , Italy 1994, 1996 Villa Saraceno, 45.311 / 11.587 0.59 0 0.59 1996 Agugliaro , Province of 1.3 - Geographic Information Table Vicenza , Veneto Name Coordinates Property Buffer Total Inscription Region , Italy (latitude/longitude) (ha) zone (ha) year Villa Thiene, 45.573 / 11.63 0.38 0 0.38 1996 (ha) Quinto Vicentino , 0 / 0 ? ? ? Province of Vicenza , Veneto 0 / 0 ? ? ? Region , Italy City of Vicenza 45.549 / 11.549 218 0 218 1994 Villa Trissino, 45.428 / 11.414 3.78 0 3.78 1996 (including 23 Sarego , Province buildings of Vicenza , constructed -

Frontespizio
Università degli Studi di Padova Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica Corso di Laurea Triennale in Progettazione e gestione del turismo culturale Andrea Palladio a Montecchio Precalcino: villa Forni Cerato Relatrice: Prof.ssa Elena Svalduz Correlatrice: Prof.ssa Barbara Maria Savy Laureanda: Costanza Scarpa Matr. 1125621 Anno Accademico 2018/2019 Ringraziamenti Desidero esprimere la mia gratitudine nei confronti della Professoressa Elena Svalduz per il tempo dedicatomi, l’impegno nel seguirmi e soprattutto per aver sempre supervisionato in modo accurato la tesi durante la stesura. Un contributo importante è stato offerto dalla Professoressa Barbara Maria Savy che ringrazio per la disponibilità e per avermi indirizzato nella parte della tesi inerente agli affreschi. Senza visitare villa Forni Cerato questa tesi non avrebbe mai avuto inizio, per questo ringrazio innanzitutto il proprietario della villa, il Dottor Ivo Boscardin, per aver accolto subito con entusiasmo e interesse il progetto di questa tesi e la Dottoressa Francesca Grandi per essere stata sempre presente in caso di chiarimenti e avermi dato la possibilità di consultare e utilizzare foto e planimetrie di ottima qualità, un importante supporto nonché ricchezza per questo elaborato. !3 !4 INDICE INTRODUZIONE pag. 7 CAPITOLO 1. IL COMMITTENTE pag. 11 1.1. Il ritratto di Girolamo Forni pag. 11 1.2. Il testamento di Girolamo Forni pag. 21 CAPITOLO 2. VILLA FORNI CERATO E ANDREA PALLADIO pag. 23 CAPITOLO 3. LA VILLA E IL TERRITORIO pag. 35 3.1. Il territorio attuale pag. 40 3.2. Analisi cartografica territoriale del contesto paesaggistico di villa pag. 41 3.2.1. -

La Città Di Vicenza E Le Ville Del Palladio Nel Veneto
La presente pubblicazione è stata realizzata con la collaborazione Vicenza con le sue 26 opere palladiane, 23 monumenti del centro storico e 3 ville Un progetto editoriale dei seguenti Enti: suburbane, è entrata a pieno titolo nel 1994 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Ufficio Unesco dell’Umanità. I monumenti palladiani hanno conferito alla realtà urbana nel suo complesso Comune di Vicenza Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto una singolare unicità, in forza della loro emergenza architettonica e in virtù delle Soprintendenze per i beni storici, artistici ed etnoantropologici relazioni che intercorrono tra tali opere e il loro intorno costruito. del Veneto Nel 1996 il riconoscimento dell’UNESCO è stato esteso ad altre 21 ville di Andrea Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici del Veneto Palladio sparse nel territorio veneto. NEL VENETO DI VICENZA E LE VILLE DEL PALLADIO LA CITTA’ Regione del Le relazioni di dialogo tra i monumenti palladiani e il paesaggio veneto costituiscono Veneto un dato forte ed emergente, la cui esemplarità assume titolo di valore universale. L’influenza dell’opera palladiana ha, infatti, determinato per i secoli successivi un riferimento irrinunciabile per l’architettura di tutto il mondo. Le ville venete costituiscono un patrimonio che nel suo insieme è testimonianza altissima di una civiltà e di una cultura – non solo ovviamente artistica e architettonica – da proteggere, da conservare, da valorizzare. Testi, fotografie, ricerca iconografica, Provincia di Provincia -
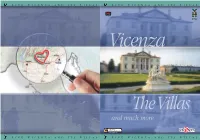
And Much More
L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS ENGLISH PROVINCIA DI VICENZA Vicenza TheVillas and much more L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS Vicenza... The Villas and much more This small structured guide to routes aims to be an instrument of easy consultation for those wishing to discover the Vicentine villas, combining their visit with the other offers of the rich territory: from museums to wine roads, from castles to typical productions. Here below you will not merely fi nd a list of villas since those which most represent the defi nition of tourist interest have been carefully selected. Every route is subdivided into two sections: “the villas” and “much more”, in order to indicate that besides the villas there are other attractions for the visitor. The villas in the fi rst section are generally usable, from the point of view of opening and accessibility to the visitor. 1 itinerary_1 Pedemontana Vicentina and High Vicentino itinerary_1 Pedemontana Vicentina and High Vicentino Romano d'Ezzelino Pove del Grappa Mussolente 12 BASSANO The Villas DEL GRAPPA Santorso Lonedo MAROSTICA Zugliano 11 7 2 - VillaRosà Ghellini, Villaverla Description 6 10 Nove SCHIO BREGANZE CartiglianoBegun in 1664 designed by Pizzocaro, the works were in- 1 CALDOGNO - VILLA CALDOGNO Sarcedo 14 terrupted in 1679, date engraved in two places of the main 2 VILLAVERLA - VILLA GHELLINI THIENE 13 3 VILLAVERLA - VILLA VERLATO PUTIN 8 9 façade, and never restarted because of the death of the archi- 4 MOLINA DI MALO - VILLA PORTO THIENE 4 15 Longa tect. -

Illustrated Content List Here
TM ARCHIVISION www.archivision.com an image source for visual resource professionals Renseignements généraux en français disponibles sur demande. No part of this publication may be reproduced or printed, in whole or in part, without the written consent of Archivision. All terms and fees subject to change without notice. Archivision Inc. © 2009 Archivision Inc. All rights reserved. version April 2009 THE ARCHIVISION DIGITAL RESEARCH LIBRARY This catalogue is a partially illustrated content list of architectural sites, gardens, parks and works of art which comprise the Archivision Digital Research Library. The Archivision Library is currently 46,000 18 MB files and is composed of: 1) Base Collection (16,000 images) 2) Addition Module One (6,000 images) 3) Addition Module Two (6,000 images) 4) Addition Module Three (6,000 images) 4) Addition Module Four (6,000 images) 4) Addition Module Five (6,000 images) The content coverage within each Library module is: .: 60% architecture (most periods) .: 20% gardens & landscapes .: 15% public art .: 5% other design related topics The Archivision Library makes an ideal complement to any core art digital collection, such as the Saskia Archive or ARTstor. Only the Archivision Digital Research Library meets the needs of students and faculty – for both research and teaching – in the disciplines of architecture, landscape architecture, and urban planning. We do not offer a subscription service – you must sign a site license agreement and pay a one-time license fee for the Library – then you may keep the images and related metadata in perpetuity with no additional annual fees. The exception is where you choose one of our hosted server options – the annual fee you pay is only for the access service. -

Barboursville Iterations of the “Rotunda House”
Pall adiana JOURNAL OF CENTER FOR PALLADIAN STUDIES IN AMERICA FALL 2019 Barboursville Iterations of the “Rotunda House” Henry Hull When James Barbour (1775 –1842) set out to build his home in his personality made a tremendous impact not only on his political native Orange County, Virginia, he consulted the same person career, but also on his agrarian pursuits and architectural aspirations. 1 upon whom he had built his political career, Thomas Jefferson. Barboursville would come to embody these passions in the specific One of only a few houses for which Jefferson was largely responsible language of Jeffersonian Palladianism. for the design, Barboursville is at the epicenter In 1808, Barbour started his architectural en - of neoclassical architectural discourse in the deavor with a pair of two-story structures early republic. At least 14 years in the making, arranged in an arc flanking the western hillside Barbour’s residence underwent a series of of his future residence. Barbour, then in his design changes involving the leading architectural mid-30s, served as Speaker of the Virginia House figures in the United States, including Thomas of Delegates. He and his family likely occupied Jefferson as well as Robert Mills and Benjamin these buildings in 1810, when the next critical Henry Latrobe. A remarkable assemblage development of Barbour’s project occurred. of 19th-century depictions of Barboursville chronicles Jefferson’s commitment and As part of Barboursville’s architectural influence in reforming domestic architecture in development, he commissioned Cephas the United States. Thompson to paint his portrait. Thompson, a contemporary of Barbour, was an itinerant From a young age, James Barbour devoted his portrait artist from Massachusetts, who trav - life to a career in public service. -

He.Su.Tech. Laboratory: Academic Research Combined With
https://doi.org/10.11606/gtp.v16i3. 172008 HE.SU.TECH. LABORATORY: ACADEMIC RESEARCH COMBINED WITH THE PRACTICE APPLIED IN THE DOCUMENTATION, REPRESENTATION, AND PRESERVATION OF THE ARCHITECTURAL HERITAGE - THE CASE OF THE PALLADIO VILLA FORNI CERATO LABORATÓRIO HE.SU.TECH: PESQUISA ACADÊMICA COMBINADA COM A PRÁTICA APLICADA NA DOCUMENTAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO - O CASO DA VILLA FORNI CERATO DE PALADDIO Andrea Adami1, Luigi Fregonese 1, Simone Helena Tanoue Vizioli 2, Laura Taffurelli1, Daniele Treccani 1, Olga Rosignoli1, Jacopo Helder1 ABSTRACT: This article runs an in-depth examination of documentation, representation and conservation praxis of Architectural Heritage in the field of applied academic research. The focus is put on technological advances in 1 digital documentation applied to Cultural Heritage. The architectural survey is one of the first actions taken in Politecnico di Milano – the knowledge process of an asset and, as such, it becomes essential for subsequent conservation, restoration Polo di Mantova and management operations. This paper describes an experience of integrated digital surveying techniques for the digitalization of an architecture by Andrea Palladio: Villa Forni Cerato. This experience has been carried 2 Universidade de São out by the Heritage Survey Technology (HE.SU.TECH.) Group, from Politecnico di Milano - Polo di Mantova that Paulo. Instituto de has been carrying out research and consulting activities with institutions related to Italian Heritage since 2000. Arquitetura e Urbanismo The case of Villa Forni Cerato is particularly interesting because, in this instance, digitization was integrated with other documental sources. The survey of the villa required the integration of all the different technologies used in the geomatic field for cultural HeritageThis case study, in particular, became an opportunity to test photogrammetric techniques with different photographic sets, acquired both from the ground and by means of Unmanned Aerial Systems (UAS). -
Report on the ICOMOS/UNESCO Advisory Mission to City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto (C 712Bis)
Report on the ICOMOS/UNESCO Advisory Mission to City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto (C 712bis) 28th to 31st March 2017 ICOMOS/UNESCO Advisory Mission “City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto” (Italy) 2 Report TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS 3 EXECUTIVE SUMMARY 4 1. BACKGROUND TO THE MISSION 6 1.1 Justification of the Mission 6 1.2 Terms of Reference 7 2. THE WORLD HERITAGE PROPERTY “CITY OF VICENZA AND THE 7 PALLADIAN VILLAS OF THE VENETO” 2.1 History of inscription 7 2.3 Examination of the State of Conservation by the World Heritage 11 Committee 2.4 Second Cycle Periodic Report 11 3 NATIONAL POLICY FOR THE PRESERVATION AND MANAGEMENT 13 OF THE WORLD HERITAGE PROPERTY 3.1 Legal Framework 13 3.2 Institutional Framework 16 3.3 Management system 16 3.4 Management Plan 17 3.5 Heritage Impact Assessment 18 4 STATE OF CONSERVATION 21 4.1 The Historic City of Vicenza and the Villas of Palladio 21 4.2 Conservation Activities 21 5 TRANSFORMATION PROJECTS 22 5.1 Preliminary Remarks 23 5.2 US Army Military Base Setaf “Del Din” 25 5.3 Parco della Pace (Peace park) 28 5.4 Building Complex in the Former Cotonificio Cotorossi Area: Borgo 29 Berga 5.5 Railway Line Connection AC Milan-Venice 33 5.6 Vicenza Bypass “Tangenziali” 35 5.7 Redevelopment Project of the Former “San Biagio” Complex 36 5.8 Urbanistic Plans near Villa Trissino Cricoli 37 5.9 Further realisations and projects 38 5.10 Overall Comment on Recent Realisations and Development Projects 40 – Inscription on the List of World Heritage in Danger? 5.11 Questions -

Cronología Gráfica De La Obra Del Arquitecto Andrea Palladio Primera Parte Obras Realizadas Desde 1537 a 1559
Cronología gráfica de la obra del arquitecto Andrea Palladio Primera Parte obras realizadas desde 1537 a 1559 Arq. Manuel Net Arq. Verónica Galloni Villa Trissino (Cricoli), Vicenza Palladio realizó las obras de remodelación de la villa. Fue Trissino, poeta, literato y arquitecto, amigo de Pallladio quien lo bautizó, pues hasta los treinta y dos años se lo conocía por Andrea, el hijo de Pedro Maganza, un “tagliapietra”. El padre de Trissino, había comprado una casa de campo llamada villa Cricoli, y su hijo se había empeñado en restaurarla según el estilo nuevo. Entre los albañiles que trabajaban en la restauración, estaba Andrea, a quien, intuyendo sus posibilidades, le aconsejó que a fin de estudiar hiciera un viaje a Roma, el primero, en 1541. Este viaje lo hace Palladio con Trissino y dos nobles venecianos: Marco Thiene y Gian Battista Braganza. Villa Godi,1537, Lonedo di Lugo Primer villa construida por Palladio. Sufrirá sucesivas intervenciones del mismo Palladio, modificaciones parciales con el fin de ampliar las zonas decorativas pictóricas de los interiores. Obra concebida antes del primer viaje a Roma, en 1541, el edificio manifiesta el modo de una cultura formada sobre el ejemplo más significativo disponible en aquel momento en el Véneto. Villa Piovene,1539, Lonedo di Lugo Vicentino, Vicenza La Villa Piovene, se llamó Villa Godi, , y después Porto; Piovene, Valmarana y hoy Malinverni.Se sabe, por testamento del mismo Palladio, que “ha estado esta obra, ornada de pinturas de bellísima invención de Messer Gualterio Padovano, de Battista del Moro, y de Messer Battista Veronese”. Por las constancias de los pagos de honorarios, siempre modestos, que se le hicieron por esta obra a Palladio, se supone que su intervención fue en operaciones parciales, arreglos, ampliaciones, etc. -
LE VILLE DEL PALLADIO Elenco
LE VILLE DEL PALLADIO Elenco Le 24 ville palladiane del Veneto, che tra il 1994 e il 1996 sono state inserite nella lista Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO : 1. Villa Almerico Capra , detta La Rotonda (Vicenza) 2. Villa Gazzotti Grimani (Vicenza località Bertesina) 3. Villa Angarano , conosciuta anche come Villa Bianchi Michiel (Bassano del Grappa, provincia di Vicenza) 4. Villa Caldogno (Caldogno, provincia di Vicenza) 5. Villa Chiericati (Vancimuglio di Grumolo delle Abbadesse, provincia di Vicenza) 6. Villa Forni Cerato (Montecchio Precalcino, provincia di Vicenza) 7. Villa Godi (Lonedo di Lugo di Vicenza, provincia di Vicenza) 8. Villa Pisani (Bagnolo di Lonigo, provincia di Vicenza) 9. Villa Pojana (Pojana Maggiore, provincia di Vicenza) 10. Villa Saraceno (Agugliaro, provincia di Vicenza) 11. Villa Thiene (Quinto Vicentino, provincia di Vicenza) 12. Villa Trissino (Meledo di Sarego, provincia di Vicenza) 13. Villa Trissino (Vicenza, località Cricoli) non è attualmente attribuita a Palladio, ma rimane legata tradizionalmente al suo nome 14. Villa Valmarana (Lisiera di Bolzano Vicentino, provincia di Vicenza) 15. Villa Valmarana (Vigardolo di Monticello Conte Otto, prov. di Vicenza) 16. Villa Piovene (Lugo di Vicenza, provincia di Vicenza) 17. Villa Badoer , detta La Badoera (Fratta Polesine, provincia di Rovigo) 18. Villa Barbaro (Maser, provincia di Treviso) 19. Villa Emo (Vedelago, provincia di Treviso) 20. Villa Zeno (Cessalto, provincia di Treviso) 21. Villa Foscari , detta La Malcontenta (Mira, provincia di Venezia) 22. Villa -

Approfondimento Le Ville Di Andrea Palladio
Approfondimento Le ville di Andrea Palladio L’evoluzione della campagna minacciava il suo predominio commerciale nel nell’entroterra veneto Mediterraneo orientale, quindi con la scoperta tra Quattro e Cinquecento dell’America e lo spostamento del baricentro del La nascita del modello abitativo della villa e la mondo dal Mediterraneo alle coste atlantiche. sua diffusione nella campagna veneta deriva dai Gli interessi politici ed economici di Venezia si mutamenti economici e politici che hanno investito spostarono così verso occidente, con investimenti i territori sottoposti al dominio della Serenissima pubblici che si affiancarono all’iniziativa privata: Repubblica di Venezia tra la seconda metà del il rilevamento cartografico della rete idrica dei Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento, possedimenti di terraferma, ordinato per decreto determinando la trasformazione del paesaggio nel 1460, le opere di bonifica e la ridefinizione agrario in quell’area. della rete infrastrutturale fino all’introduzione di All’inizio del XV secolo Venezia si era imposta più moderne tecniche di coltivazione. sulle Signorie di terraferma comprese tra il Po e il In questo processo di ridefinizione economica e Mincio; nel 1428, con la conquista di Bergamo, territoriale le ville svolsero un ruolo di primo piano: i suoi possedimenti arrivarono fino all’Adda, ai esse, infatti, diventarono i nodi di una fitta rete di confini del Ducato di Milano. L’imposizione della trasporti, sia via acqua sia via terra. La diffusione pace interna e l’avvio di una politica -

Villa Forni Cerato Palladio's Re-Design of an Old House
Pall adiana JOURNAL OF CENTER FOR PALLADIAN STUDIES IN AMERICA FALL 2019 Barboursville Iterations of the “Rotunda House” Henry Hull When James Barbour (1775 –1842) set out to build his home in his personality made a tremendous impact not only on his political native Orange County, Virginia, he consulted the same person career, but also on his agrarian pursuits and architectural aspirations. 1 upon whom he had built his political career, Thomas Jefferson. Barboursville would come to embody these passions in the specific One of only a few houses for which Jefferson was largely responsible language of Jeffersonian Palladianism. for the design, Barboursville is at the epicenter In 1808, Barbour started his architectural en - of neoclassical architectural discourse in the deavor with a pair of two-story structures early republic. At least 14 years in the making, arranged in an arc flanking the western hillside Barbour’s residence underwent a series of of his future residence. Barbour, then in his design changes involving the leading architectural mid-30s, served as Speaker of the Virginia House figures in the United States, including Thomas of Delegates. He and his family likely occupied Jefferson as well as Robert Mills and Benjamin these buildings in 1810, when the next critical Henry Latrobe. A remarkable assemblage development of Barbour’s project occurred. of 19th-century depictions of Barboursville chronicles Jefferson’s commitment and As part of Barboursville’s architectural influence in reforming domestic architecture in development, he commissioned Cephas the United States. Thompson to paint his portrait. Thompson, a contemporary of Barbour, was an itinerant From a young age, James Barbour devoted his portrait artist from Massachusetts, who trav - life to a career in public service.