Tesi Finale Con Margini
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

(Hansard) First Session Wednesday 07 December 2011
1 No. 35 of 2011 FIFTH NATIONAL ASSEMBLY PARLIAMENTARY DEBATES (HANSARD) FIRST SESSION WEDNESDAY 07 DECEMBER 2011 2 CONTENTS PAPERS LAID QUESTION (ORAL) MOTION BILL (Public) ADJOURNMENT 3 Members Members THE CABINET (Formed by Dr. the Hon. Navinchandra Ramgoolam) Dr. the Hon. Navinchandra Ramgoolam, GCSK, Prime Minister, Minister of Defence, Home FRCP Affairs and External Communications Dr. the Hon. Ahmed Rashid Beebeejaun, GCSK, Deputy Prime Minister, Minister of Energy and FRCP Public Utilities Hon. Charles Gaëtan Xavier-Luc Duval, GCSK Vice-Prime Minister, Minister of Finance and Economic Development Hon. Anil Kumar Bachoo, GOSK Vice-Prime Minister, Minister of Public Infrastructure, National Development Unit, Land Transport and Shipping Dr. the Hon. Arvin Boolell, GOSK Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade Dr. the Hon. Abu Twalib Kasenally, FRCS Minister of Housing and Lands Hon. Mrs Sheilabai Bappoo, GOSK Minister of Social Security, National Solidarity and Reform Institutions Dr. the Hon. Vasant Kumar Bunwaree Minister of Education and Human Resources Hon. Satya Veyash Faugoo Minister of Agro-Industry and Food Security Hon. Devanand Virahsawmy, GOSK Minister of Environment and Sustainable Development Dr. the Hon. Rajeshwar Jeetah Minister of Tertiary Education, Science, Research and Technology Hon. Tassarajen Pillay Chedumbrum Minister of Information and Communication Technology Hon. Louis Joseph Von-Mally, GOSK Minister of Fisheries and Rodrigues Hon. Satyaprakash Ritoo Minister of Youth and Sports Hon. Louis Hervé Aimée Minister of Local Government and Outer Islands Hon. Mookhesswur Choonee Minister of Arts and Culture Hon. Shakeel Ahmed Yousuf Abdul Razack Mohamed Minister of Labour, Industrial Relations and Employment Hon. Yatindra Nath Varma Attorney General 4 Hon. -

No. 08 of 2016 SIXTH NATIONAL ASSEMBLY PARLIAMENTARY
1 No. 08 of 2016 SIXTH NATIONAL ASSEMBLY PARLIAMENTARY DEBATES (HANSARD) (UNREVISED) FIRST SESSION TUESDAY 24 MAY 2016 2 CONTENTS PAPERS LAID QUESTIONS (Oral) STATEMENT BY MINISTER MOTION ANNOUNCEMENT BILLS (Public) ADJOURNMENT 3 Members Members THE CABINET (Formed by the Rt. Hon. Sir Anerood Jugnauth, GCSK, KCMG, QC) Hon. Sir Anerood Jugnauth, GCSK, Prime Minister, Minister of Defence, Home Affairs, KCMG, QC Minister of Finance and Economic Development, Minister for Rodrigues and National Development Unit Hon. Charles Gaëtan Xavier-Luc Duval, Deputy Prime Minister, Minister of Tourism and External GCSK Communications Hon. Showkutally Soodhun, GCSK Vice-Prime Minister, Minister of Housing and Lands Hon. Ivan Leslie Collendavelloo, GCSK, Vice-Prime Minister, Minister of Energy and Public SC Utilities Hon. Seetanah Lutchmeenaraidoo, GCSK Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade Hon. Yogida Sawmynaden Minister of Youth and Sports Hon. Nandcoomar Bodha, GCSK Minister of Public Infrastructure and Land Transport Hon. Mrs Leela Devi Dookun-Luchoomun Minister of Education and Human Resources, Tertiary Education and Scientific Research Hon. Anil Kumarsingh Gayan, SC Minister of Health and Quality of Life Dr. the Hon. Mohammad Anwar Husnoo Minister of Local Government Hon. Prithvirajsing Roopun Minister of Social Integration and Economic Empowerment Hon. Marie Joseph Noël Etienne Ghislain Minister of Technology, Communication and Innovation Sinatambou Hon. Ravi Yerrigadoo Attorney General Hon. Mahen Kumar Seeruttun Minister of Agro-Industry and Food Security Hon. Santaram Baboo Minister of Arts and Culture Hon. Ashit Kumar Gungah Minister of Industry, Commerce and Consumer Protection Hon. Mrs Marie-Aurore Marie-Joyce Minister of Gender Equality, Child Development and 4 Perraud Family Welfare Hon. -
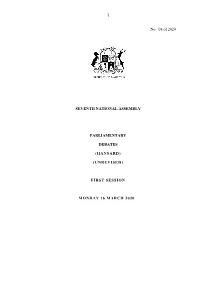
Debate No 08 of 2020 (UNREVISED)
1 No. 08 of 2020 SEVENTH NATIONAL ASSEMBLY PARLIAMENTARY DEBATES (HANSARD) (UNREVISED) FIRST SESSION MONDAY 16 MARCH 2020 2 CONTENTS PAPERS LAID QUESTION (Oral) MOTIONS ADJOURNMENT 3 THE CABINET (Formed by Hon. Pravind Kumar Jugnauth) Hon. Pravind Kumar Jugnauth Prime Minister, Minister of Defence, Home Affairs and External Communications, Minister for Rodrigues, Outer Islands and Territorial Integrity Hon. Ivan Leslie Collendavelloo, GCSK, SC Deputy Prime Minister, Minister of Energy and Public Utilities Hon. Mrs Leela Devi Dookun-Luchoomun, Vice-Prime Minister, Minister of Education, GCSK Tertiary Education, Science and Technology Dr. the Hon. Mohammad Anwar Husnoo Vice-Prime Minister, Minister of Local Government and Disaster Risk Management Hon. Alan Ganoo Minister of Land Transport and Light Rail Dr. the Hon. Renganaden Padayachy Minister of Finance, Economic Planning and Development Hon. Nandcoomar Bodha, GCSK Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade Hon. Louis Steven Obeegadoo Minister of Housing and Land Use Planning Hon. Mrs Fazila Jeewa-Daureeawoo, GCSK Minister of Social Integration, Social Security and National Solidarity Hon. Soomilduth Bholah Minister of Industrial Development, SMEs and Cooperatives Hon. Kavydass Ramano Minister of Environment, Solid Waste Management and Climate Change Hon. Mahen Kumar Seeruttun Minister of Financial Services and Good Governance Hon. Georges Pierre Lesjongard Minister of Tourism Hon. Maneesh Gobin Attorney General, Minister of Agro-Industry 4 and Food Security Hon. Yogida Sawmynaden Minister of Commerce and Consumer Protection Hon. Jean Christophe Stephan Toussaint Minister of Youth Empowerment, Sports and Recreation Hon. Mahendranuth Sharma Hurreeram Minister of National Infrastructure and Community Development Hon. Darsanand Balgobin Minister of Information Technology, Communication and Innovation Hon. -

(Hansard) (Unrevised) First Session Tuesday 07 May 2019
1 No. 06 of 2019 SIXTH NATIONAL ASSEMBLY PARLIAMENTARY DEBATES (HANSARD) (UNREVISED) FIRST SESSION TUESDAY 07 MAY 2019 2 CONTENTS ANNOUNCEMENT OBITUARY PAPERS LAID QUESTIONS (Oral) MOTIONS STATEMENTS BY MINISTERS BILLS (Public) ADJOURNMENT QUESTIONS (Written) 3 THE CABINET (Formed by Hon. Pravind Kumar Jugnauth) Hon. Pravind Kumar Jugnauth Prime Minister, Minister of Home Affairs, External Communications and National Development Unit, Minister of Finance and Economic Development Hon. Ivan Leslie Collendavelloo, GCSK, Deputy Prime Minister, Minister of Energy and Public SC Utilities Hon. Sir Anerood Jugnauth, GCSK, Minister Mentor, Minister of Defence, Minister for KCMG, QC Rodrigues Hon. Mrs Fazila Jeewa-Daureeawoo Vice-Prime Minister, Minister of Local Government and Outer Islands, Minister of Gender Equality, Child Development and Family Welfare Hon. Yogida Sawmynaden Minister of Technology, Communication and Innovation Hon. Nandcoomar Bodha, GCSK Minister of Public Infrastructure and Land Transport, Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade Hon. Mrs Leela Devi Dookun-Luchoomun Minister of Education and Human Resources, Tertiary Education and Scientific Research Hon. Anil Kumarsingh Gayan, SC Minister of Tourism Dr. the Hon. Mohammad Anwar Husnoo Minister of Health and Quality of Life Hon. Prithvirajsing Roopun Minister of Arts and Culture Hon. Marie Joseph Noël Etienne Ghislain Minister of Social Security, National Solidarity, and Sinatambou Environment and Sustainable Development Hon. Mahen Kumar Seeruttun Minister of Agro-Industry and Food Security Hon. Ashit Kumar Gungah Minister of Industry, Commerce and Consumer Protection Hon. Maneesh Gobin Attorney General, Minister of Justice, Human Rights and Institutional Reforms Hon. Jean Christophe Stephan Toussaint Minister of Youth and Sports 4 Hon. -

Le DPM Ivan Collendavelloo Démantèle La Thèse De Corruption
Affaire BWSC-Saint Louis Le DPM Ivan Collendavelloo démantèle la thèse de corruption Pravind Jugnauth : • « Je viens devant vous moi « Je m’attendais à avec les mains propres » ce que Boolell me donne des noms » Jurassic Park : Quand l’Express et Melhia Bissière oublient les 20 juin 2020 No. 13 Gratuit dinosaures de La Sentinelle Séquelles de la PNQ sur les médicaments Pourquoi le Dr Arvin Boolell a-t-il balancé le nom du Dr Pankaj Wadhwa au Parlement ? • Le patron du Aegle group a comme associé un certain Tevindren Sithanen Créativité Technologique Droit international L’opposition britannique exerce une pression sur Boris Johnson pour que l’archipel des Chagos retourne à Maurice Tik Tok, la nouvelle • Pravind Jugnauth : « L’occupation du territoire mauricien « reminds us of our deep concerns as forme d’art des jeunes to historic wrongs in relation to race and slavery » Black Lives Matter Hippisme Béyoncé réclame l’inculpation des policiers Premier League meurtriers de Liverpool va reprendre son Le sport roi Breonna Taylor destin en main à Everton est de retour 2 20 juin 2020 - Edition No. 13 Budget 2020-2021 Droit international L’opposition britannique exerce une pression sur Boris Johnson pour que l’archipel des Chagos retourne à Maurice • Pravind Jugnauth : « L’occupation du territoire mauricien par les anciens colons anglais « reminds us of our deep concerns as to historic wrongs in relation to race and slavery » sur le dossier de l’archipel grateful for the opportunity to de Chagos. provide input to this report. Soulignons durant le “The United Kingdom has no week-end le Foreign and doubt about its sovereignty Commonwealth Office a over the Chagos Archipelago, émis un communiqué pour which has been under faire état de cette affaire. -

Magazine REVI LALIT No
KONTENI Nimero 128 Me 2017 - Zin 2017 EDITORYAL: Leta Burzwa: Zot Institisyon an Kriz................................................................... 3 DOSYE: Zot Institisyon an Kriz Planet Earth Avan, Permi pu Biznes Answit: Ki Prezidan Repiblik? ........................................ 5 Rol Spiyker an Kriz, Parlman an Kriz ............................................................................. 6 Otaz bann Zom Dezespere ...................................................................................................... 7 Financial Services: FSC an Kriz ........................................................................................ 9 Lalit an Aksyon ................................................................................................................... 8 Jabaljas & Bulbak ......................................................................................................... 10 DOSYE LATER 10 Demand LALIT ................................................................................................................ 11 Guvernman bizin al Delavan Met dibut nuvo sekter Agro-Alimanter ............................... 12 Konferans de Pres: LALIT met kestyon later lor azanda .......................................... 13 Frederick Robert, Sef Tablisman St Felix Reprezant IRS MonRoze .................................. 14 Eleman pu enn Veritab Vilaz Integre pu Baie du Cap ......................................................... 16 20-enn Lakaz Richelieu “Unfi t for Occupation” ............................................................ -

Jurassic Park Reloaded Version
SPECIAL EDITION 03 ÉDITION SPÉCIALE - 04 | MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 mazavaroo.mumazavaroo.mu RS 5.00 Le 'BEST OF' des promesses non tenuEs de ramgoolam ALLIANCE NATIONALE Jurassic Park reloaded version parti travailliste Exit rupture, place à la déchirure les intellos humiliés 2 POLITIQUE ÉDITION SPÉCIALE - 04 | MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 MAZAVAROO2 ÉLECTIONS | ÉDITION 2019 SPÉCIALE - 03 MAZAVAROO ÉLECTIONS| ÉDITION SPÉCIALE 2019 - 032 Le 'BEST OF' des promesses non tenuEs de ramgoolam • Hôpital pédia- 1995 : Augmentation trique de 15% pour les fonctionnaires Encore une annonce qui n’a jamais été concrétisée. Cet Battu en 1991, Navin Ramgoolam se hôpital, avait-il promis, serait présente à nouveau devant l’électorat spécialisé dans le traitement en 1995 avec deux promesses princi- des cas complexes de maladies pales : Une augmentation de 15% de des enfants. salaire pour les fonctionnaires et la diffusion gratuite de la chaîne d’infor- Freedom of mation britannique, Sky News. Ni l’un, ni l’autre n’a été honoré par le leader information du Parti Travailliste (PTr). A la place, on a eu droit à une rupture avec le act : fais ce que MMM, une Macarena Party avec des jeunes filles à Albion et le fameux ‘trou jedis… Ne fais pas Bheenick’, dans le premier budget de ce que je fais ce dernier comme ministre des Finances travailliste. Bheenick avait à peine tenu quelques mois comme Grand argentier, et a dû démissionner en raison de ce scandale. Et dire maintenant qu’il En 2005, Navin Ramgoolam avait promis une Freedom augmentera la pension de vieillesse (qu’il avait déjà refusé en 2014), of Information Act. -

Read L'express Weekly, 23 April 2010
INTERVIEW| Constituency 18 with Nita Deerpalsing and Vijay Makhan> pp. 34-35 Insert N°3 • Friday 23 APRIL 2010 [THIS ISMAURITIUS> pp.40-41 ELECTORAL FEVER : Editorial ] the contagion spreads. by Touria PRAYAG “Le berger à la bergère” George Bernard Shaw, you will recall, sent the following invitation to Winston Churchill, “I am enclosing two tickets to the fi rst night of my new play. Bring a friend... if you have one.” Churchill’s reply did not take long to come, “Cannot possibly attend fi rst night. Will attend second... if there is one.” Tit for tat! Tit for tat was also the response of Prime Minister Navin Ramgoolam to the lobby of campaigners for quotas for women in politics, “‘No’ to one out of three. But ‘yes’ to three out of three!” and three women were fi elded in a constituency where, I think, they might have a fi ghting chance. Yes, there were disappointments that the parties did not fi eld a bigger number of female candidates. There were also and es- pecially perhaps personal ambitions which were frustrated af- ter high expectations. However, one can only serve women by giving them the same opportunities as their male counterparts. No more, no less. If the world at large remains egregiously male- dominated in nearly all spheres (look worldwide at the corpo- rate world above a certain level, for example) it is because of the lack of equal opportunities. Girls are demonstrably higher per- formers academically where there is really equal opportunity. Nor is the number of women fi elded or even elected a mea- sure of the rights women have. -

No. 02 of 2017 SIXTH NATIONAL
1 No. 02 of 2017 SIXTH NATIONAL ASSEMBLY PARLIAMENTARY DEBATES (HANSARD) (UNREVISED) FIRST SESSION TUESDAY 04 APRIL 2017 2 CONTENTS PAPERS LAID QUESTIONS (Oral) MOTIONS STATEMENTS BY MINISTERS BILLS (Public) ADJOURNMENT QUESTIONS (Written) 3 THE CABINET (Formed by Hon. Pravind Kumar Jugnauth) Hon. Pravind Kumar Jugnauth Prime Minister, Minister of Home Affairs, External Communications and National Development Unit, Minister of Finance and Economic Development Hon. Ivan Leslie Collendavelloo, GCSK, Deputy Prime Minister, Minister of Energy and Public SC Utilities Hon. Sir Anerood Jugnauth, GCSK, Minister Mentor, Minister of Defence, Minister for KCMG, QC Rodrigues Hon. Showkutally Soodhun, GCSK Vice-Prime Minister, Minister of Housing and Lands Hon. Seetanah Lutchmeenaraidoo, GCSK Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade Hon. Yogida Sawmynaden Minister of Technology, Communication and Innovation Hon. Nandcoomar Bodha, GCSK Minister of Public Infrastructure and Land Transport Hon. Mrs Leela Devi Dookun-Luchoomun Minister of Education and Human Resources, Tertiary Education and Scientific Research Hon. Anil Kumarsingh Gayan, SC Minister of Tourism Dr. the Hon. Mohammad Anwar Husnoo Minister of Health and Quality of Life Hon. Prithvirajsing Roopun Minister of Arts and Culture Hon. Marie Joseph Noël Etienne Ghislain Minister of Social Security, National Solidarity, and Sinatambou Environment and Sustainable Development Hon. Mahen Kumar Seeruttun Minister of Agro-Industry and Food Security Hon. Ashit Kumar Gungah Minister of Industry, Commerce and Consumer Protection Hon. Ravi Yerrigadoo Attorney General Hon. Jean Christophe Stephan Toussaint Minister of Youth and Sports Hon. Soomilduth Bholah Minister of Business, Enterprise and Cooperatives Hon. Marie Roland Alain Wong Yen Minister of Social Integration and Economic Cheong, MSK Empowerment 4 Hon. -

Sir Anerood Jugnauth 1930-2021 Spéciale 05 Juin 2021 No
Edition Sir Anerood Jugnauth 1930-2021 Spéciale 05 juin 2021 No. 211 Gratuit Vous allez nous manquer, RAMBO! Sir Anerood Jugnauth 29 mars 1930 – 3 juin 2021 When comes such another? 05 juin 2021 - Edition No. 211 2 05 juin 2021 - Edition No. 211 SirSir Anerood Anerood Jugnauth Jugnauth 1930-2021 1930-2021 Sir Anerood Jugnauth : Un géant politique qui a marqué l’histoire de notre pays • Homme de parole, SAJ a respecté son engagement en cédant sa place· Homme de Premier de parole, ministre SAJ au a leaderrespecté du son MMM, engagement Paul Bérenger en cédant sa place de Premier ministre au leader du MMM, Paul Bérenger en •2003 L’homme de La Caverne a bâti sa réputation comme l’architecte du · L’homme«miracle économique»fort de La Caverne de Maurice a bâti sa réputation comme l’architecte du «miracle économique» de Maurice • A 84 ans, Sir Anerood Jugnauth a accédé pour la sixième fois au· A poste 84 ans, de SirPremier Anerood ministre Jugnauth en décembre a accédé pour 2014, la personnesixième fois dans leau monde poste de démocratique Premier ministre ne s’était en décembre fait élire 2014, à ce personneposte à cet dans âge le monde démocratique ne s’était fait élire à ce poste à cet âge •«En « En 2019, 2019, SAJ SAJ cède cède sa place sa place comme comme Premier Premier ministe ministre à son fils,à son fils,Pravind Pravind et est etconsidéré est considéré comme comme «Mentor « Minister»Mentor Minister » De nombreux observateurs politiques, des politiciens de tous bords confondus ainsi que les Mauriciens en général estiment sir Anerood Jugnauth comme un géant de la politique, voir même un vrai animal politique, qui a su moderniser et transformer le pays durant ses années au pouvoir. -
Leadership Au Ptr : Navin Ramgoolam, Une Épine Au Pied Du Parti Travailliste
Glissement de terrain Covid-19 : Pravind à Souillac : Rs 96 millions Jugnauth : « Il y aura des de travaux risques qu’on devra prendre » Edition 9 / 12 octobre 2020 www.ionnews.mu Leadership au PTr : Navin Ramgoolam, une épine au pied du Parti travailliste 1 Appel à contributeurs à contributeurs Vous voulez écrire un article, une tribune ou bien tout simplement devenir un contributeur régulier ? N'hésitez pas. Le blog d’ION News a été conçu pour vous ! Faites-nous parvenir vos ecrits au mail suivant: [email protected] Vous voulez écrire un article, une tribune ou bien tout simplement devenir un contributeur régulier ? N'hésitez pas. Le blog d’ION News a été conçu pour vous ! Faites-nous parvenir vos écrits au mail suivant [email protected] Les grands titres Leadership au PTr : Navin Ramgoolam, une épine 4 au pied du Parti travailliste Leader du PTr : Shakeel Mohamed pas du même 5 avis que son père mais condamne Patrick Assirvaden Les leaders de l’opposition réunis à Ebène : 6 Xavier-Luc Duval : «Une rencontre très cordiale » Covid-19 : Pravind Jugnauth : « Il y aura des 7 risques qu’on devra prendre » Procédures d’admission en Grade 1 : Attente et 8 frustration Glissement de terrain à Souillac : Rs 96 millions 10 de travaux Informatisation des services publics : Des projets 11 contraints à être abandonnés Un kilo d’héroïne destiné à Maurice saisi en 13 Afrique du Sud Après 30 ans, un SDF mauricien espère pouvoir 14 rentrer à Maurice de La Réunion Covid-19 : Le virus peut persister jusqu’à 28 jours 15 sur les smartphones et les billets de banque L’e-paper ION NEWS a été conçu pour s'adapter aux écrans de téléphones portables pour une expérience de lecture optimisée. -

No. 25 of 2020 SEVENTH NATIONAL ASSEMBLY PARLIAMENTARY DEBATES (HANSARD) (UNREVISED) FIRST SESSION TUESDAY 14 JULY 2020
1 No. 25 of 2020 SEVENTH NATIONAL ASSEMBLY PARLIAMENTARY DEBATES (HANSARD) (UNREVISED) FIRST SESSION TUESDAY 14 JULY 2020 2 CONTENTS PAPERS LAID MOTION BILLS (Public) MOTION OF NO CONFIDENCE ADJOURNMENT 3 THE CABINET (Formed by Hon. Pravind Kumar Jugnauth) Hon. Pravind Kumar Jugnauth Prime Minister, Minister of Defence, Home Affairs and External Communications, Minister for Rodrigues, Outer Islands and Territorial Integrity Hon. Louis Steven Obeegadoo Deputy Prime Minister, Minister of Housing and Land Use Planning, Minister of Tourism Hon. Mrs Leela Devi Dookun-Luchoomun, Vice-Prime Minister, Minister of Education, GCSK Tertiary Education, Science and Technology Dr. the Hon. Mohammad Anwar Husnoo Vice-Prime Minister, Minister of Local Government and Disaster Risk Management Hon. Alan Ganoo Minister of Land Transport and Light Rail Dr. the Hon. Renganaden Padayachy Minister of Finance, Economic Planning and Development Hon. Nandcoomar Bodha, GCSK Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade Hon. Mrs Fazila Jeewa-Daureeawoo, GCSK Minister of Social Integration, Social Security and National Solidarity Hon. Soomilduth Bholah Minister of Industrial Development, SMEs and Cooperatives Hon. Kavydass Ramano Minister of Environment, Solid Waste Management and Climate Change Hon. Mahen Kumar Seeruttun Minister of Financial Services and Good Governance Hon. Georges Pierre Lesjongard Minister of Energy and Public Utilities Hon. Maneesh Gobin Attorney General, Minister of Agro-Industry and Food Security Hon. Yogida Sawmynaden Minister of Commerce and Consumer 4 Protection Hon. Jean Christophe Stephan Toussaint Minister of Youth Empowerment, Sports and Recreation Hon. Mahendranuth Sharma Hurreeram Minister of National Infrastructure and Community Development Hon. Darsanand Balgobin Minister of Information Technology, Communication and Innovation Hon.