Indice 1. Introduzione……………………………………………………………………………………………
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Linea 34 ACCIAROLI - S
Linea 34 ACCIAROLI - S. MARIA DI CASTELLABATE - AGROPOLI - SALERNO (VINCIPROVA) DAL 14/09/2015 FERIALE Acciaroli - Agnone - Casa del Conte - S. Marco di Castellabate - S. Maria di Castellabate - Agropoli - Paestum - Capaccio - Bivio S. Cecilia - Battipaglia – Salerno FS/C.so Garibaldi. Percorso estivo per Napoli: Acciaroli - Agnone - Casa del Conte - S. Marco di Castellabate – S. Maria di Castellabate – Agropoli – Paestum – Capaccio – Bivio S. Cecilia – Battipaglia Autostrada A3 RC/SA – Napoli Via G. Ferraris - P.zza Garibaldi – C. so Umberto I – Via De Pretis - P.zza Municipio Validità 02 23 32 27 02 02 04 23 09 09 23 02 04 02 02 02 02 02 02 23 02 23 17 02 04 GALDO (CAP.) 6.20 7.00 15.05 17.35 ACCIAROLI PORTO 5.20 6.40 7.25 8.50 9.50 9.50 12.50 15.30 16.20 17.50 18.00 18.50 20.10 MONTECORICE 5.32 6.52 7.37 9.02 10.02 10.02 13.02 15.42 16.32 18.02 19.02 20.22 S. MARCO DI C.TE 5.44 5.45 6.35 6.35 7.05 7.50 9.20 9.20 10.15 10.15 12.55 13.30 13.30 14.20 15.20 15.55 16.50 18.20 18.20 18.55 19.15 20.35 S. MARIA DI C.TE 5.50 5.50 6.40 6.40 7.10 7.30 7.55 9.30 9.30 10.30 10.30 11.30 13.00 13.35 14.30 15.30 16.00 17.00 18.30 18.25 19.00 19.30 20.40 AGROPOLI TENDOSTR. -
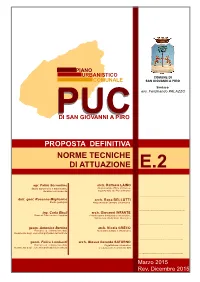
Norme Tecniche Di Attuazione E.2
PIANO URBANISTICO COMUNE DI COMUNALE SAN GIOVANNI A PIRO Sindaco avv. Ferdinando PALAZZO PPDI SAN UUGIOVANNCCI A PIRO PROPOSTA DEFINITIVA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E.2 agr. Fabio Sorrentino arch. Raffaele LAINO Studio agronomico e naturalistico, Responsabile Ufficio di Piano e Relazione di Incidenza responsabile del Procedimento ................................................. dott. geol. Rosanna Miglionico arch. Rosa BELLOTTI Studio geologico Responsabile Servizio Urbanistica ................................................. ing. Carla Eboli arch. Giovanni INFANTE Piano di Zonizzazione Acustica Pianificazione territoriale e urbanistica, Valutazione Ambientale Strategica ................................................. geom. Antonino Bertino arch. Nicola GRECO Raccolta ed elaborazione dati, Normativa Edilizia e Urbanistica rilevamento degli elementi significativi del territorio ................................................. geom. Felice Lombardi arch. Giosuè Gerardo SATURNO Raccolta ed elaborazione dati, Progettazione urbanistica rilevamento degli elementi significativi del territorio e valutazione in ambiente GIS ................................................. Marzo 2015 Rev. Dicembre 2015 Indice TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................................ 5 Art. 1 Elaborati costitutivi del PUC ............................................................................................ 5 Art. 2 Principi – Natura giuridica – Finalità .............................................................................. -

Comune Di Acerno [email protected]
Comune di Acerno [email protected] Comune di Agropoli [email protected] Comune di Albanella [email protected] Comune di Alfano [email protected] Comune di Altavilla Silentina [email protected] Comune di Amalfi [email protected] Comune di Angri [email protected] Comune di Aquara [email protected] Comune di Ascea [email protected] Comune di Atena Lucana [email protected] Comune di Atrani [email protected] Comune di Auletta [email protected] [email protected] Comune di Baronissi [email protected] Comune di Battipaglia [email protected] Comune di Bellizzi [email protected] Comune di Bellosguardo [email protected] Comune di Bracigliano [email protected] Comune di Buccino [email protected] Comune di Buonabitacolo [email protected] Comune di Caggiano [email protected] Comune di Calvanico [email protected] [email protected] Comune di Camerota [email protected] Comune di Campagna [email protected] Comune di Campora [email protected] Comune di Cannalonga [email protected] Comune di Capaccio [email protected] Comune di Casal Velino [email protected] Comune di Casalbuono [email protected] Comune di Casaletto -

Italy - Cilento and the Amalfi Coast - Self-Guided Leisure Cycling Holiday
Tel : +47 22413030 | Epost :[email protected]| Web :www.reisebazaar.no Karl Johans gt. 23, 0159 Oslo, Norway Italy - Cilento and The Amalfi Coast - Self-Guided Leisure Cycling Holiday Turkode Destinasjoner Turen starter 42540 Italia Naples Turen destinasjon Reisen er levert av 8 dager Sorrento Fra : NOK 0 Oversikt The region of Campania is well known for its archaeological and cultural treasures, featuring, above all, the Roman ruins of Pompeii, the island of Capri and the stunningly beautiful Sorrento and Amalfi Coast. Reiserute Day 1: Arrival into Naples Airport - Transfer to Paestum Day 2: Paestum to Casal Velino Day 3: Casal Velino Loop (through Palinuro) Day 4: Casal Velino to Paestum Day 5: Paestum to Salerno and Amalfi Day 6: Amalfi to Sorrento Day 7: Free Day - Sorrento Day 8: Transfer from Sorrento to Naples Airport During the week you will explore the coastal roads of Cilento, passing through some of its most spectacular scenery, with grand views of the Mediterranean. You will explore sleepy little hamlets that seem not to have changed since medieval times and visit some of its most important archaeological sites, including the imposing Greek temples of Paestum (UNESCO World Heritage). Not forgetting some quality relaxation time sipping a cappuccino or a glass of local wine, or lounging on the beach soaking in the warm Mediterranean sun. The second part of your holiday will be spent cycling along the wildly spectacular Amalfi Coast, where steep vertical cliffs rise up from the shimmering Mediterranean to make way for little hamlets clinging to the rock faces and lemon groves precariously growing on tiny agricultural terraces. -

187-GRADUATORIA PROVINC AP 2009 10 I Grado PROV
GRADUATORIA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROVINCIALE - ANNO SCOLASTICO 2009-10 Prec. Art. Prec .Art. Punteggio Prec. 33 lettera 33 lettera Prec. PREC Classe DATA DI Punteggio altri Art. 21 l. g l. H l. Lav. L. conc ALTRO N. COGNOME NOME NASCITA Comune res. Residenza COMUNI 104/92 104/92 104/92 madre 100 richiesta RUOLO 1 CIOCIANO DOMENICO 09/06/1972 CAPACCIO 10 4 SI AD00 2 SATURNO EMMA 22/02/1967 CAMEROTA 14 8 SI AD00 3 OLIVA ORIETTA 29/08/1967 ANGRI 12 6 SI AD00 4 TAMMARO ALESSANDRA 24/10/1969 NOCERA INF. 10 4 SI AD00 5 LUONGO DARIO 10/04/1962 CAMPAGNA 6 0 SI AD00 6 ALFINITO STEFANIA 28/07/1964 BATTIPAGLIA 13 7 SI AD00 7 VILLANO CARMINE 20/01/1966 NOCERA SUP. 10 4 SI AD00 8 RUOCCO FRANCESCO 12/07/1964 CAMEROTA 16 10 AD00 9 DI MASO GIUSEPPE 29/03/1967 SALERNO 16 10 AD00 10 SERGIO LUCIA 01/07/1963 CAVA TIRRENI 15 9 AD00 11 AMATO ANTONIO 18/12/1961 SALERNO 14 8 AD00 12 TURCO LUISA 22/12/2006 MOIO DELLA CIV. 13 7 AD00 13 BUBOLO GENNARO 16/12/1964 SERRE 12 6 AD00 14 MALAFRONTE GINEVRA 04/10/1968 SCAFATI 12 6 AD00 15 COLARUSSO VINCENZO 08/01/1969 CAMEROTA 12 6 AD00 16 BERGAMO VINCENZO 27/01/1966 EBOLI 10 4 AD00 17 MOTTOLA VERA 07/10/1973 BATTIPAGLIA 10 4 AD00 18 DESIDERIO MADDALENA 13/05/1957 SALERNO 9 3 AD00 19 GENUA CARMINE 11/02/1962 SALERNO 9 3 AD00 20 DE SANTIS PAOLA 26/06/1968 S.CIPRIANO PIC. -

SPECIALE BORGHI Della CAMPANIA2
SPECIALE BORGHI della CAMPANIA2 COPIA OMAGGIO edizione speciale FIERE un parco di terra e di mare laboratorio di biodiversità a park of land and sea R laboratory of biodiversity www.cilentoediano.it GLI 80 COMUNI DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI Agropoli Gioi Roccagloriosa Aquara Giungano Rofrano Ascea Laureana Cilento Roscigno Auletta Laurino Sacco Bellosguardo Laurito Salento Buonabitacolo Lustra San Giovanni a Piro Camerota Magliano Vetere San Mauro Cilento Campora Moio della Civitella San Mauro la Bruca Cannalonga Montano Antilia San Pietro al Tanagro Capaccio Monte San Giacomo San Rufo Casal velino Montecorice Sant’Angelo a Fasanella Casalbuono Monteforte Cilento Sant’Arsenio Casaletto Spartano Montesano sulla Marcellana Santa Marina Caselle in Pittari Morigerati Sanza Castel San Lorenzo Novi Velia Sassano Castelcivita Omignano Serramezzana Castellabate Orria Sessa Cilento Castelnuovo Cilento Ottati Sicignano degli Alburni Celle di Bulgheria Perdifumo Stella Cilento Centola Perito Stio Ceraso Petina Teggiano Cicerale Piaggine Torre Orsaia Controne Pisciotta Tortorella Corleto Monforte Polla Trentinara Cuccaro Vetere Pollica Valle dell’Angelo Felitto Postiglione Vallo della Lucania Futani Roccadaspide I 15 COMUNI NELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI Albanella Ogliastro Cilento Sala Consilina Alfano Padula Sapri Atena Lucana Pertosa Torchiara Caggiano Prignano Cilento Torraca Ispani Rutino Vibonati zona del parco Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Ai Focei si deve, invece, la fondazione di Velia (VI secolo a.C.), patria della scuola Eleatica di Parmenide che ha fecon- dato e illuminato la storia della filosofia occidentale. La Certosa di San Lorenzo di Padula costituisce un vero e proprio gioiello dell’architettura monastica, principale esem- pio del Barocco del Mezzogiorno, inserita tra i Monumenti Internazionali già nel lontano 1882. -
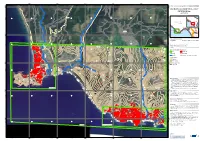
PALINURO and CAMEROTA - ITALY REFERENCE Map OVERVIEW Production Date: 24/10/2013 # # # # N Piaggine Campobasso " Padula 0 N ' " 4
524000 526000 528000 530000 532000 15°16'0"E 15°17'0"E 15°18'0"E 15°19'0"E 15°20'0"E 15°21'0"E 15°22'0"E 15°23'0"E 0 0 0 0 TWIST Simulation Exercise 2013 Activation ID: EMSN-008 0 0 6 6 3 3 4 4 4 4 PALINURO and CAMEROTA - ITALY REFERENCE Map OVERVIEW Production date: 24/10/2013 # # # # N Piaggine Campobasso " Padula 0 N ' " 4 0 Centola ' ° 4 0 ° # ! 4 # 0 Bari 4 Naples # # # Montesano # Sulla Marcellana # Potenza #Vallo Della Lucania Salerno # Ascea Submerged volcano # # PalinLuarogonegro Vibonati# Potenza Sapri # #Rivello #Centola # PALINURO # San Giovanni A Piro Trecchina # Lauria Licusati # !# # # Maratea Marina Di Camerota 0 0 Cosenza 0 0 0 0 4 4 #Tortora 3 3 4 4 4 4 # Lido Di Tortora # Praia A Mare # Cartographic Information 1:17,000 Full color A1, high resolution (300dpi) N " 0 N ' " 3 0 ' ° 3 0 ° 4 0 4 L a Map CoordinateSystem: WGS 1984 Zone 33N m 4 b 2 4 Graticule: WGS 84 geographical coordinates 5 7 ro 5 0 0 6 5 62 Legend 00 5 6 7 2 5 57 General Information Settlements 550 5 00 525 AOI residential 5 7 5 Hydrology Physiography 5 2 o 5 r 2 b 2 5 Rivers Contour lines and elevation (m) m a L Transportation 4 2 5 5 2 Highway 4 5 7 5 4 7 0 3 5 5 Primary road 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 Secondary road 4 4 4 4 5 0 Local road 50 Palinuro 25 5 0 0 75 !# 0 1 N " 0 N ' " 75 2 0 ' 5 ° 2 7 1 0 ° 00 Camerota 4 0 4 !# 3 0 0 00 300 125 0 0 1 0 0 5 0 0 7 0 0 3 0 5 5 2 4 0 0 3 0 5 0 4 100 3 2 0 5 0 5 1 350 Map Information 0 1 5 4 The Twist project is funded by the European Union. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus SITA
Orari e mappe della linea bus SITA SITA Aquara - Rocca - Capaccio - Bivio S. Cecilia Visualizza In Una Pagina Web La linea bus SITA (Aquara - Rocca - Capaccio - Bivio S. Cecilia) ha 29 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Aquara - Rocca - Capaccio - Bivio S. Cecilia: 07:20 - 07:30 (2) Aquara- Ponte Calore - Felitto: 05:15 (3) Aquara- Capaccio-Batt.-Aut.-Svpont-Saler.: 05:55 - 12:00 (4) Aquara-Roccadaspide: 05:55 - 17:15 (5) Battipaglia-Albanella- Roccadaspide: 17:10 - 19:15 (6) Bivio S. Cecilia - Albanella - Rocca - Aquara: 09:10 (7) Bivio S. Cecilia - Albanella - Roccadaspide: 15:00 (8) Bv. S. Cecilia - Battipaglia - Bellizzi - Pontecagnano - Salerno: 16:55 (9) Felitto - Capaccio - Battip. - Aut.Salerno: 13:25 (10) Felitto-Capaccio-Battipaglia: 05:50 - 17:15 (11) Felitto-Roccadaspide: 10:40 (12) P.Te Barizzo- Albanella-Roccadaspide: 13:05 (13) Piaggine - Roccadaspide - Battipaglia - Salerno: 06:25 (14) Piaggine - Villa Littorio - S.P. 29 - S.S.166 - Roccadaspide: 10:20 - 17:25 (15) Piaggine -Felitto - Roccad. - Albanella - Bv. S. Cecilia - Battipaglia: 04:50 (16) Piaggine- Roccadaspide - Battipaglia - Salerno: 14:15 - 14:25 (17) Piaggine-Laurino-Rocca-Alb.-Batt.-Aut.- Fuorni-Salerrno: 06:45 (18) Roccadaspide - Albanella - Battipaglia - Salerno: 11:15 - 16:05 (19) Roccadaspide - Albanella - Bivio S. Cecilia: 13:40 (20) Roccadaspide - Felitto - Laurino - Piaggine: 13:50 (21) Roccadaspide - Felitto - Laurino - Villa Littorio - Piaggine: 08:10 (22) Roccadaspide-Albanella-P.Te Barizzo: 12:20 (23) Roccadaspide-Aquara: 05:30 - 18:40 (24) Roccadaspide-Felitto: 10:00 - 12:50 (25) Salerno - Aut.- Battipaglia - Capaccio - Roccadaspide: 12:10 (26) Salerno - Battipaglia - Roccadaspide - Piaggine: 17:00 (27) Salerno - Bellizzi - Battipaglia - Capo. -

Le Opportunità Di Fruizione Turistica Il Parco Nazionale Del Cilento E Vallo
Le opportunità di fruizione turistica Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano- Geopark- è dotato di una rete sentieristica di circa 1.800 km, estesa in maniera omogenea su tutta la superficie del parco e delle aree contigue. Recentemente è stata anche pubblicata, a cura del parco, la cartografia completa di tutta la rete sentieristica costituita da 10 tavole in scala 1:25.000. Essa costituisce una fitta rete che si sviluppa attorno ai due principali sentieri del Parco, uno costiero l’altro interno, su itinerari molto vari tra loro che rispecchiano la varietà morfologica, naturalistica e paesaggistica del territorio. Il principale sentiero costiero, denominato Trans Parco Costiero (TPC), permette di percorrere l’intero tratto di costa rientrante nel territorio del Parco che va da Agropoli alla foce del Bussento. Esso attraversa tratti di costa incontaminata, con bassissima densità abitativa, a tratti caratterizzati dalla forte presenza di attività umane legate soprattutto alle attività turistiche dei principali centri abitati. Il principale sentiero interno altro non è che un tratto del Sentiero Italia (SI), ossia il sentiero che percorre l’intero territorio nazionale dalla catena alpina sino alle isole maggiori. Esso si sviluppa quasi totalmente in ambito montano attraversando quelli che sono i principali rilievi carbinatici del parco ossia: i monti Alburni ed il massiccio del monte Cervati. Tra queste due direttrici principali, grosso modo con andamento NW-SE, si intreccia la fitta maglia dei sentieri che permette di accedere a quelli che sono i principali geositi del parco. Alcuni di essi (monte Cervati, gola del Sammaro, monte della Stella) il parco ha provveduto recentemente a renderli maggiormente accessibili realizzandovi opere accessorie quali: passerelle e staccionate in legno, gradini, livellamento del piano di calpestio, panche ed aree sosta, cartellonistica informativa e divulgativa. -

PROVINCIA DI SALERNO Decreto Del Presidente Della Provincia
PROVINCIA DI SALERNO Decreto del Presidente della Provincia data 27 dicembre 2019 N. 163 del registro generale Oggetto: Approvazione Piano relativo al “ Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - Razionalizzazione delle misure di gestione della viabilità in presenza di neve e ghiaccio – Manutenzione invernale 2019/2020 ” IL PRESIDENTE Con la partecipazione del ViceSegretario Generale dott. Alfonso Ferraioli VISTA la proposta di decreto n. 34 del registro del Settore Viabilità e Trasporti redatta all’interno; PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 28 del 29 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021; VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; VISTA la Legge n. 56/2014; VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27; VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; DECRETA 1) di approvare la proposta di decreto n. 34 del registro del Settore proponente inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell’esecuzione del presente decreto. ¡ ¢ ¢ £ ¤ ¡ ¥ ¤ £ ¥ £ ¦ ¡ ¦ ¢ ¡ § ¨ © © © ¢ © ! " ! # $ % & ' ( ) * & % + , - . / 0 1 0 2 3 4 2 5 6 - . 2 7 - / - - 8 . 9 8 8 9 5 - 7 8 2 9 7 8 0 4 : 0 9 ; ; 0 2 < 9 1 0 2 7 9 > 0 1 1 9 1 0 2 7 - ? - > > - 5 0 3 @ . - ? 0 4 - 3 8 0 2 7 - ? - > > 9 / 0 9 6 0 > 0 8 A 0 7 B . -

Delibera Del Coordinamento Istituzionale
Via Villa Comunale, 1 – 84073 Sapri (SA) Telefono 0973.605542 – Fax 0973.605541 www.pianosociales9.it * e-mail: [email protected] – pec [email protected] DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE N. 2 DEL 09/12/2021 Oggetto: Centro di Riabilitazione Silba S.P.A. – Provvedimenti. L’anno duemilaventuno, il giorno nove, del mese di Aprile, alle ore 18:16, si è riunito, in seconda convocazione, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale S/9, in videoconferenza, a seguito delle disposizioni dei D.P.C.M. inerenti l’emergenza COVID-19, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, giusta convocazione prot. n. 1468/2021. Svolge le funzioni di Presidente il dott. Antonio Gentile, nella qualità di Sindaco del Comune Capofila, la Coordinatrice dell’Ufficio di Pano, rag. Di Luca Gianfranca, presente per ragioni d’ufficio e la dott.ssa Di Nardo Annagrazia che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Risultano rispettivamente presenti ed assenti i rappresentanti degli Enti come da elenco che segue: 1 A.S.L. Salerno Assente 2 Comune di Alfano Presente: Sindaco 3 Comune di Camerota Assente 4 Comune di Casaletto Spartano Presente: Delegato 5 Comune di Caselle in Pittari Presente: Delegato 6 Comune di Celle di Bulgheria Presente: Sindaco 7 Comune di Centola Presente: Delegato 8 Comune di Ispani Presente: Sindaco 9 Comune di Morigerati Presente: Delegato 10 Comune di Roccagloriosa Assente 11 Comune di Rofrano Presente: Sindaco 12 Comune di Santa Marina Assente 13 Comune di San Giovanni a Piro Presente: Delegato 14 Comune di Sapri Presente: Sindaco 15 Comune di Torraca Presente: Sindaco 16 Comune di Torre Orsaia Presente: Sindaco 17 Comune di Tortorella Presente: Sindaco 18 Comune di Vibonati Presente: Delegato 19 Coordinatore dell’Ufficio di Piano Presente PRESENTI N. -

Comuni REFERENTE Telefono ORARIO APERTURA SEDE AMBULATORIO STP Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Roccapiemonte, Castel S.Giorg
Comuni REFERENTE Telefono ORARIO APERTURA SEDE AMBULATORIO STP Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Roccapiemonte, Castel S.Giorgio ANTONIO SPINELLI 081 9212728 8,30-12,00 Nocera Inferiore Via Giordano, 7 LUNEDI, MERCOLEDI , VENERDI Angri, Scafati, S.Egidio Montalbino, Corbara GIUSEPPE FIMIANI 081 5356252 9,00-12,00 Via dei Goti snc Angri GIOVEDI GIUSEPPE DAMIANI 9,00-12,00 Poliambulatorio Via Passanti,1 Scafati MERCOLEDI Sarno, Pagani, S. Valentino Torio, S.Marzano sul Sarno FRANCESCO ATTIANESE 081 9684059 15,00-17,30 MARTEDI Ospedale Villa Malta Via Sarno_Striano 9,00-12,00 MERCOLEDI ANDREA 081 92132603 9,00-12,00 Via Olivella Pagani GAROFALO MARTEDI , GIOVEDI Eboli, Altavilla Silentina, Buccino, Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, DIANA REPPUCCI 0828 362637 15,00-17,30 LUNEDI, GIOVEDI Via Sacro Cuore Piazzale Lombardi - Eboli Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Palomonte, Postiglione, Ricigliano, 9,00-11,30 VENERDI Romagnano al Monte, S.Gregorio Magno, Santomenna, Serre, Sicignano degli Alburni Battipaglia, Bellizzi, Olevano sul Tusciano GERARDO ZOPPI 0828 674513 9,30-13 ,00 LUNEDI MARTEDI Poliambulatorio Via Generale Gonzaga - Battipaglia 15,00-17,00 MERCOLEDI Salerno, Pellezzano CARMELO PETRAGLIA 089 694339/4342 16,00-18,00 Ambulatroio STP Via M.Vernieri - Salerno LUNEDI GIOVEDI M.S.Severino, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Siano DOMENICO RUSSO 8,15 - 13,00 MARTEDI GIOVEDI VENERDI Poliambulatorio Piazza XX Settembre - Mercato S. 15,00 -18,00 MARTEDI E GIOVEDI Severino Capaccio , Albanella, Aquara, Bellospguardo, Castel S.Lorenzo Castelcivita, ANTONIO DE ROSA 0828 9426732 12,00-13,00 Via Italia, 61 - Palazzo Quadrifoglio - Capaccio Controne, Corleto Monforte, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, MARTEDI , GIOVEDI Monteforte Cilento, Ottati, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sanza, S.