Un'analisi Interpretativa Della Maschilità Nella Televisione
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Erenews 2020 3 1
ISSN 2531-6214 EREnews© vol. XVIII (2020) 3, 1-45 European Religious Education newsletter July - August - September 2020 Eventi, documenti, ricerche, pubblicazioni sulla gestione del fattore religioso nello spazio pubblico educativo e accademico in Europa ■ Un bollettino digitale trimestrale plurilingue ■ Editor: Flavio Pajer [email protected] EVENTS & DOCUMENTS EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Guide on Art 2: Respect of parental rights, 2 CONSEIL DE L’EUROPE / CDH Une éducation sexuelle complète protège les enfants, 2 EUROPEAN COMMISSION Racial discrimination in education and EU equality law. Report 2020, 3 WCC-PCID Serving a wounded world in interreligious solidarity. A Christian call to reflection, 3 UNICEF-RELIGIONS FOR PEACE Launch of global multireligious Faith-in-Action Covid initiative, 3 OIEC Informe 2020 sobre la educacion catolica mundial en tiempos de crisis, 4 WORLD VALUES SURVEY ASSOCIATION European Values Study. Report 2917-2021, 4 USCIRF Releases new Report about conscientious objection, 4 PEW RESEARCH CENTER Between belief in God and morality: what connection? 4 AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS Fighting discrimination on grounds of religion and ethnicity 5 EUROPEAN WERGELAND CENTER 2019 Annual Report, 5 WORLD BANK GROUP / Education Global Practice Simulating the potential impacts of Covid, 5 AMERICAN ACADEMY OF RELIGION AAR Religious Literacy Guidelines, 2020, 6 CENTRE FOR MEDIA MONITORING APPG Religion in the Media inquiry into religious Literacy, 6 NATIONAL CHRONICLES DEUTSCHLAND / NSW Konfessionelle Kooperation in Religionsunterricht, -
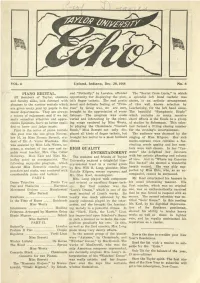
Taylor University Echo Chronicle
VOL.6 Upland, Indiana, Dec. 28, 1918 No. 6 PIANO RECITAL. and "Butterfly," by Lavalee, afforded The "Sextet from Lucia," in which All members of Taylor, students opportunity for displaying the pian a splendid left hand technic was and faculty alike, look forward with ist's finger technic. The real poetic shown, is an artistic arrangement pleasure to the various recitals which mood and delicate feeling of "Prim of this well known selection by are given every year by pupils in the rose" by Grieg was, we are sure, Leschetizky, for the left hand alone. music departments. They are always brought to the appreciation of every The beautiful "Symphonie Etude" a source of enjoyment and if we but listener. The program was made which contains so many massive make ourselves attentive and appre varied and interesting by the pleas chord effects is the finale to a group ciative listeners, leave us better quali ing songs rendered by Miss Wertz. of studies by Schumann. This selec fied to know and judge music. In playing the Chaminade "Concert tion formed a fitting closing number First in the series of piano recitals Stuck," Miss Berrett not only dis for the evening's entertainment. this year was the one given Novem played all kinds of finger technic, but The audience was charmed by the ber 16, by Miss Neoma Berrett, stu brought her recital to a most brilliant singing of Miss Kilgore. Her rich dent of Dr. A. Verne Westlake. She climax. mezzo-soprano voice contains a fas was assisted by Miss Lela Wertz, so cinating Creole quality and her num prano, a student of our new and ca HIGH QUALITY bers were well chosen. -

CLASSIFIED ADS Home?" Starring Laurel & Hardy
set about the rebuilding of the small Coates presented the program on the behind the console. They seemed to organ. It must be said at this point organ and piano. set the mood for the meeting, and I'm that to this writer, no group ever The end of the year in St. Louis told, were the handiwork of Mrs. Jureit. showed such great spirit in the face of signals a "New Beginning" for us with The featured artist this Sunday disappointment or such "espirit de the hope of '72 seeing the small organ afternoon was Pete Dumser, and artist corp" in banding together to start playing and a new home for its larger he is, for he wove a melodic medley of another project. We all looked for sister. At any rate, watch our smoke traditional and pop Christmas music, ward eagerly to the Affton project and this year and a happy and prosperous punctuated by familiar standards. His when it didn't pan out everyone just and productive new year to us all ... program was well received. The "early picked himself up (as the song says) "Ten-Four". bird" feature was the early birds them and went back to work with new JOHN FERGUSON selves. Perhaps Lee Taylor coaxed sights. music from the big instrument which We don't feel at liberty yet to dis encouraged the more timid souls to close the location of the little Wur SOUTH FLORIDA try their hands, and the "open con litzer at this printing, but work on the Bouquets to Mr. -
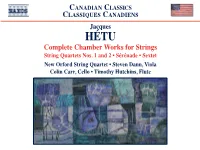
Jacques HÉTU Complete Chamber Works for Strings String Quartets Nos
CANADIAN CLASSICS CLASSIQUES CANADIENS Jacques HÉTU Complete Chamber Works for Strings String Quartets Nos. 1 and 2 • Sérénade • Sextet New Orford String Quartet • Steven Dann, Viola Colin Carr, Cello • Timothy Hutchins, Flute Jacques Jacques Hétu (1938-2010) Complete Chamber Works for Strings HÉTU A Brief Survey of Jacques Hétu’s Compositional Style contrasts a quirky and arrhythmic theme with interludes of (1938-2010) glassy and furtive tremolo. A cello solo that evokes some Melodicism, lush harmonies and instrumental discourse of the more avant-garde melodies of the initial Allegro is at Complete Chamber Works for Strings are all important elements in Jacques Hétu’s music and the heart of the movement. The final movement, Allegro, his style combines expressivity and angular rhythms begins with a unison that mirrors the very beginning of the within very traditional musical forms. His early quartet, this time utilizing a much wider version of the tri- String Quartet No. 1, Op. 19 (1972) 18:18 compositions, influenced by Bartók, Hindemith and tone for striking effect. A fugue follows, which gains 1 Allegro 4:10 various leading French composers, have a marked sense momentum until it is suddenly interrupted by a recollection 2 Andante 6:29 of polytonality and are imbued with percussive rhythms of the theme from the second movement. After this 3 Andante – Vivace 3:01 and harmonic tension. In later years his musical language sudden change of character, the tremolo of the third 4 Allegro 4:38 matured with more open and spacious frameworks and movement is brought back to break the spell, leading to increasingly lyrical expression. -
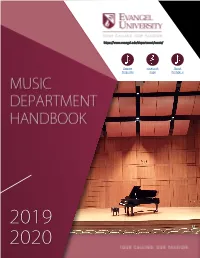
Music Department Handbook Will Be Governed by the Rules in the University Cata- Log and the Student Handbook
https://www.evangel.edu/department/music/ Degree Facebook About Programs page Evangel U table of contents ACCREDITATION .................................................................................................................... 2 FACULTY & STAFF ................................................................................................................... 3 PURPOSES, OBJECTIVES, STANDARDS........................................................................ 7 ADMISSION INTO THE PROGRAM ................................................................................. 8 SOPHOMORE REVIEW......................................................................................................... 9 DEGREE PLANS .................................................................................................................... 10 B.M. in Music Education ............................................................................................. 11 B.M. in Worship Leadership ........................................................................................ 12 B.M. in Performance .................................................................................................... 13 B.S. in Music .................................................................................................................... 15 B.A. in Music ................................................................................................................... 15 MUSIC MINORS ................................................................................................................... -

Stahl, Childs Combine Piano Talent
Mrs. Al Lerberg Concordia Collece 101 po * THE CONCORDIAN VOLUME LVI THE CONCORDIA COLLEGE. MOOR HEAD. MINNESOTA. MARCH 12. 1965 No. 23 Augenstein Returns for Graduation Dr. Leroy Augenstein, who gregations will participate in Ridge National Laboratory, Oak was a Faith in Life speaker last this service. Ridge, Tennessee. Dr. Wollan is September, will be this year's Dinner will be served in the a 1923 graduate of Concordia commencement speaker. Dr. Commons from 12:15 to 1:15 and is the son of the late Profes- Augenstein is chairman of the p.m. All students and as many sor Thomas C. Wollan, a profes- department of biophysics at guests as possible will be ac- sor of mathematics at Concordia Michigan State University. commodated. for many years. Again special Dr. Augenstein received his Commencement exercises in music will be provided by the B.S. degree from the Univer- Memorial Auditorium begin at concert choir and band. sity of Chicago, his M.S. and 3:00 p.m. with the address by Three hundred and thirteen PhJD. degrees from the Uni- Augenstein. An honorary de- students, including those who versity of Illinois. His profes- gree of Doctor of Science will met graduation requirements in sional experience includes be conferred upon Dr. Ernest O. December, will receive their di- work with the Brookhaven Wollan, a physicist at the Oak plomas. National Laboratory, the Atomic Energy Commission and the United States Science Exhibit at the Seattle World's C-400 Recruits Seniors Dr. Leroy Augenstein Fair. He has edited and writ- Opportunity to participate in a unique venture of alumni sup- ten books on biology and ra- port is rapidly closing for 360 of Concordia's students. -

THE COLLECTED POEMS of HENRIK IBSEN Translated by John Northam
1 THE COLLECTED POEMS OF HENRIK IBSEN Translated by John Northam 2 PREFACE With the exception of a relatively small number of pieces, Ibsen’s copious output as a poet has been little regarded, even in Norway. The English-reading public has been denied access to the whole corpus. That is regrettable, because in it can be traced interesting developments, in style, material and ideas related to the later prose works, and there are several poems, witty, moving, thought provoking, that are attractive in their own right. The earliest poems, written in Grimstad, where Ibsen worked as an assistant to the local apothecary, are what one would expect of a novice. Resignation, Doubt and Hope, Moonlight Voyage on the Sea are, as their titles suggest, exercises in the conventional, introverted melancholy of the unrecognised young poet. Moonlight Mood, To the Star express a yearning for the typically ethereal, unattainable beloved. In The Giant Oak and To Hungary Ibsen exhorts Norway and Hungary to resist the actual and immediate threat of Prussian aggression, but does so in the entirely conventional imagery of the heroic Viking past. From early on, however, signs begin to appear of a more personal and immediate engagement with real life. There is, for instance, a telling juxtaposition of two poems, each of them inspired by a female visitation. It is Over is undeviatingly an exercise in romantic glamour: the poet, wandering by moonlight mid the ruins of a great palace, is visited by the wraith of the noble lady once its occupant; whereupon the ruins are restored to their old splendour. -
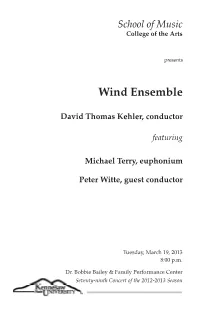
Wind Ensemble Featuring Michael Terry, Euphonium and Peter Witte
School of Music College of the Arts presents Wind Ensemble David Thomas Kehler, conductor featuring Michael Terry, euphonium Peter Witte, guest conductor Tuesday, March 19, 2013 8:00 p.m. Dr. Bobbie Bailey & Family Performance Center Seventy-ninth Concert of the 2012-2013 Season Welcome to the Kennesaw State University School of Music The School of Music at KSU has dedicated, vibrant, and talented faculty and staff that are completely devoted to teaching, performing, scholar- ship, and serving our community. It is an incredibly exciting place to study, boasting state-of-the-art facilities with opportunities to produce and explore music in a dynamic place that is ahead of the curve for what it means to be a musician in the 21st century. Our students come from the leading musical honor organizations across the region and are poised to lead the cultural offerings and musical education in our area and beyond for years to come. We welcome you to attend a concert, meet our faculty and staff, and feel the energy and excitement that our students exude. We are fully commit- ted to our purpose as educators, performers, and scholars. We hope that you will find as much enjoyment in our product as we do in producing it. Welcome! For more information about the School of Music, please visit www.kennesaw.edu/music Please consider a gift to the Kennesaw State University School of Music. Contact Holly Elrod at: [email protected] or 770-423-6907 Kennesaw State University School of Music Audrey B. and Jack E. Morgan, Sr. Concert Hall March 19, 2013 Wind Ensemble David Thomas Kehler, conductor featuring KSU Concerto Winner Michael Terry, euphonium and special guest conductor, Peter Witte Lincolnshire Posy (1937) Percy Aldridge Grainger I. -

~:!COUGAR Backfield
MONDAY-WEDNESDAY-FRIDAY IS YOUR GROUP REPRESENT FOOTBALL SCRIMMAGE ED IN DEBATE? TOMORROW .. VOL. XXX. STATE COLLEGE OF WASHINGTON, PULLMAN, WASH., FRIDAY, SEPTEMBER 28, 1923 1923. No. 5 NATURAL HISTORY CLUB MISS MARY CAMERON + ·r --:· ·:· ·:· ·:· .;. ·:. + ·l- ·:. ·r + ·~ ELECTS NEW OFFICERS I·:· TWEftTY -SIX CO-EDS :MISS MARY CAMERON + IS IT SPELLED RIGHT? :~: ! COUGAR BACKFIElD The Natural History club has elect ed the following officers for the com I CHARMS AUOifNCf Today is the last opportunity MfN SHOW UP WELL CHOSEN TO COMPRISE ing semester: President, Mary Large; i ·!· for students to correct their ·:-:~ I -- vice president, Phillips Putnam; sec •:• names and addresses in the retary-treasurer, Edith Hardin; social ••• copy for the Student Directory. 1 WOMEN'S GlEE ClUB chairman, Clairmont Siekerman; pro AT lECTURE RECITAl + The copy is in the library f IN FIRST SCRIMMAGE grams, Fred Warren; corresponding 7 lobby and all students are ·~ I secretary, Horace Skinner. 0:· urged to correct their names at + Mrs. Kimbrough, Director, An The program of the club for this ''Happy Mediums'' Title of Pro- ·:· once in order that the Student ·<- ' Line Expected to Show Improve- 1 uounces Even Number of So semester will be printed the early part I I. gram Given Yesterday by ·:· Directory may be as complete + . ment With Development of pranos and Altos of next week. 1· New Piano Instructor ••• and correct as possible. .;. Old and New Material 1 -:· -:- -~ + ·:· ·:· .;. ·:· ·:· ·:· .;. ·:· .,. + .,. i WILL TOUR WASHINGTON ; TELLS FOLK-LORE ORIGIN SCHEDULE 728 CLASSES WHELAN HELPS COACH LINE FRUSH S~UAD DIVIDED l I IN 421 SUBJECTS I Last Year's Humorous Skits to Be 1 Makes Appeal for Good American It has b~en neccss.ary to scheduie j New Material Shows Possibilities in Continued With Variations and TO BfTTfR COACHING · Music, Not of "Barney Google" 782 classes 111 421 subJects on the cur- Marker, Brown, Martin, Wal- Additions Type riculum at the State College this se- dorf and Mathers mestcr because of the crowd of stu- Men With Previous Experience I dents. -

Read Doc \ Amanda Lear Albums (Music Guide)
XGZHZWH7DTKQ PDF ^ Amanda Lear albums (Music Guide) Amanda Lear albums (Music Guide) Filesize: 3.68 MB Reviews Complete guideline for publication fanatics. It is actually writter in straightforward words rather than confusing. I am effortlessly could get a pleasure of looking at a written book. (Kirstin Schuppe) DISCLAIMER | DMCA CJOPSIGFENGY # Book > Amanda Lear albums (Music Guide) AMANDA LEAR ALBUMS (MUSIC GUIDE) Reference Series Books LLC Feb 2012, 2012. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 250x192x10 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Source: Wikipedia. Commentary (music and lyrics not included). Pages: 25. Chapters: Amanda Lear compilation albums, Amanda Lear video albums, Brief Encounters, Back in Your Arms, I Am a Photograph, Sweet Revenge, Never Trust a Pretty Face, Secret Passion, Diamonds for Breakfast, With Love, Incognito, Heart, Tam-Tam, Uomini Più Uomini, Cadavrexquis, Alter Ego, Forever Glam!, The Sphinx Das beste aus den Jahren 1976 1983, Tant Qu'il Y Aura Des Hommes, Brand New Love Aair, Ieri, Oggi, I'm Coming Up, Sings Evergreens, Tendance, Poet Amanda Lear, Super 20, La Ragazza dal Pigiama Giallo, Live in Concert 1979. Excerpt: For the 1945 film, see Brief Encounter. For the 1967 film, see Brief Encounters (film). Brief Encounters is the fourteenth studio album by French singer Amanda Lear. The album was released in Italy on October 16, 2009 as a double CD set containing twenty five new recordings sung in both English and French, comprising eight original compositions and a selection of covers. The first CD contains pop, acoustic and jazz numbers, while the second CD features more dance oriented tracks. -

Trans-Atlantic Circulation of Black Tropes: Èsù and the West African Griot As Poetic References for Liberation in Cultures Of
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2012 Trans-Atlantic circulation of black tropes: Èsù and the West African griot as poetic references for liberation in cultures of the African diaspora Jean-Baptiste Meunier Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the Comparative Literature Commons Recommended Citation Meunier, Jean-Baptiste, "Trans-Atlantic circulation of black tropes: Èsù and the West African griot as poetic references for liberation in cultures of the African diaspora" (2012). LSU Doctoral Dissertations. 2971. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/2971 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. TRANS-ATLANTIC CIRCULATION OF BLACK TROPES: ÈSÙ AND THE WEST AFRICAN GRIOT AS POETIC REFERENCES FOR LIBERATION IN CULTURES OF THE AFRICAN DIASPORA A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy In Comparative Literature by Jean-Baptiste Meunier Licence, Université Lyon 2 – 2005 Master, Université Lyon 2 –2008 August 2012 Pour Karim ii ACKNOWLEDGEMENTS It is a real honor to thank those who have made this dissertation possible. I would like to express my deepest appreciation to my committee chair, Professor Pius Ngandu Nkashama for his guidance and for his support during this adventure. -

Ethical Encounters
Doktorsavhandlingar från JMK 52 Erika Theissen Walukiewicz Ethical Encounters The Value of Care and Emotion in the Production of Mediated Narratives Erika Theissen Walukiewicz Ethical Encounters ISBN 978-91-7911-368-1 ISSN 1102-3015 Department of Media Studies Doctoral Thesis in Journalism at Stockholm University, Sweden 2021 Ethical Encounters The Value of Care and Emotion in the Production of Mediated Narratives Erika Theissen Walukiewicz Academic dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy in Journalism at Stockholm University to be publicly defended on Friday 5 February 2021 at 13.00 in JMK-salen, Garnisonen, Karlavägen 104, online via Zoom, public link is available at the department website. Abstract Factual storytelling that relies on the participation of real-life people must navigate between obligations towards the participant and the story. By placing the relationship between storyteller and subject at the centre, this thesis offers an interdisciplinary examination of ethical and moral issues in the context of turning other people’s experiences into mediated narrative. Besides bringing the interests of participating subjects to the forefront, the study explores the relevance of care ethics within a media context and argues how this perspective contributes to ethical and moral reflection in the scholarly domain of media ethics as well as within media practice. This involves operationalizing the theory of care ethics, with particular emphasis on relational obligations and the moral significance of emotions. With its focus on relational and emotional aspects, the study joins the emerging discussion about the affective dimensions of journalism and extends this discussion to the domain of media ethics.