UNA SEPARAZIONE Di Asghar Farhadi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
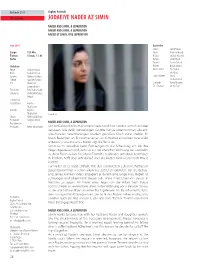
Jodaeiye Nader Az Simin
W-6885:W_ 28.01.2011 16:51 Uhr Seite 28 Berlinale 2011 Asghar Farhadi Wettbewerb JODAEIYE NADER AZ SIMIN NADER AND SIMIN, A SEPARATION NADER AND SIMIN, A SEPARATION NADER ET SIMIN, UNE SEPARATION Iran 2011 Darsteller Simin Leila Hatami Länge 123 Min. Nader Peyman Moadi Format 35 mm, 1:1.85 Hodjat Shahab Hosseini Farbe Razieh Sareh Bayat Termeh Sarina Farhadi Stabliste Richter Babak Karimi Regie Asghar Farhadi Naders Vater Ali-Asghar Buch Asghar Farhadi Shahbazi Kamera Mahmood Kalari Simins Mutter Shirin Schnitt Hayedeh Safiyari Yazdanbakhsh Ton Mahmood Somayeh Kimia Hosseini Sammakbashi Frl. Ghahraei Merila Zarei Tonschnitt Reza Narimizadeh Mischung Mohammad Reza Delpak Szenenbild, Ausstattung Keyvan Moghadam Kostüm Keyvan Moghadam Sareh Bayat Maske Mehrdad Mirkiani Produzent Asghar Farhadi Ausführender NADER AND SIMIN, A SEPARATION Produzent Negar Eskandarfar Simin möchte mit ihrem Ehemann Nader und ihrer Tochter Termeh den Iran verlassen. Alle dafür notwendigen Schritte hat sie unternommen; alle ent- sprechenden Vereinbarungen wurden getroffen. Doch dann meldet ihr Mann Bedenken an: Er möchte seinen an Alzheimer erkrankten Vater nicht unbetreut zurücklassen – Nader sagt die Reise ab. Simin reicht daraufhin beim Familiengericht die Scheidung ein. Als ihre Klage abgewiesen wird, zieht sie aus der ehelichen Wohnung aus und kehrt zu ihren Eltern zurück. Die kleine Termeh entscheidet sich dafür, beim Vater zu bleiben, hofft aber sehr darauf, dass die Mutter bald wieder nach Hause kommt. Für Nader ist es nicht einfach, mit den veränderten Lebensverhältnissen zurechtzukommen – schon allein aus zeitlichen Gründen. Für die Betreu - ung seines kranken Vaters engagiert er darum eine junge Frau. Razieh ist schwan ger und übernimmt diesen Job, ohne ihren Ehemann davon in Kennt nis zu setzen. -

Gefesselter Blick, Freies Urteil Asghar Farhadis Realismus – Eine Werksichtung
Jörn Glasenapp Gefesselter Blick, freies Urteil Asghar Farhadis Realismus – Eine Werksichtung I. Der Regisseur der gemäßigten Fremdheit Ob es Asghar Farhadi nicht zuletzt Donald Trump zu verdanken hat, dass er Ende Februar 2017 bei der 89. Oscarverleihung für sein Whodunit- Ehedrama The Salesman (Foruschande, 2016) den Oscar für den bes- ten fremdsprachigen Film erhielt? Wir wissen es nicht. Und doch wird man getrost annehmen dürfen, dass das grosso modo liberale, eher dem demokratischen Lager nahestehende Hollywood die Prämierung des ira- nischen Films als opportunes Zeichen betrachtete, um Stellung gegen die von der Trump-Administration einen Monat zuvor verabschiedete Exe- cutive Order 13769 zu beziehen, den sogenannten »Muslim ban«, der Bürgerinnen und Bürgern aus dem Iran und sechs weiteren mehrheitlich muslimischen Staaten 90 Tage, Flüchtlingen 120 Tage und Flüchtlingen aus Syrien dauerhaft die Einreise in die USA untersagte. Darüber, ob die US-Grenzbehörden Farhadi eine Einreise-Sondergenehmigung erteilt hätten, lässt sich ebenfalls nur spekulieren. Denn wenig überraschend ließ es sich der Regisseur nicht nehmen, die Verleihung zu boykottieren und sein Fernbleiben zum Signum des Protests gegen Trumps xenophobe und muslimfeindliche Politik zu machen, die er nicht zuletzt im folgen- den, die menschen- und völkerverbindende Kraft des Films beschwören- den Statement kritisierte, das er in der Oscarnacht verlesen ließ: »I’m sorry I’m not with you tonight. My absence is out of respect for the people of my country, and those of the other six nations who have been disrespected by the inhumane law that bans entry of immigrants to the U. S. Dividing the world into the ›us‹ and ›our enemies‹ categories creates fear – a deceitful justification for aggression and war. -

NADER and Simin a Film by Asghar Farhadi a SEPARATION
NADER AND SIMIN a film by Asghar Farhadi A SEPARATION NADER AND SIMIN A SEPARATION a film by Asghar Farhadi Iran / 2011 / 123 min / colour / 35mm 1:1.85 / persian WORLD SALES & FESTIVAL WITh ThE particIpation OF InTERnATIOnAL pRESS Memento Films International DreamLab Films Vanessa Jerrom: 9 cité Paradis Nasrine Médard de Chardon +336 14 83 88 82 75010 Paris – France 14, chemin des Chichourliers claire Vorger: Tel: +33 1 53 34 90 20 06110 Le Cannet – France +336 20 10 40 56 [email protected] Tel/Fax: +33 4 93 38 75 61 [email protected] www.memento-films.com [email protected] www.dreamlabfilms.com DIRECTOR’S PROFILE ASGHAR FARHADI Biography Filmography Asghar Farhadi was born in 1972 in Isfahan, Iran. Whilst at school he 2011 became interested in writing, drama and the cinema, took courses at Nader and Simin, A Separation the Iranian Young Cinema Society and started his career as a filmma- (Jodaeiye Nader az Simin) ker by making super 8mm and 16mm films. Competition – Berlin 2011 He graduated with a Master’s Degree in Film Direction from Tehran 2009 University in 1998. About Elly During his studies, he wrote and directed several student plays, wrote (Darbareye Elly) for the national radio and directed a number of TV series, including Silver Bear – Best Director – Berlinale 2009 episodes of Tale of a City. In 2001, Farhadi wrote the screenplay for Ebrahim Hatamikia’s box- 2006 Fireworks Wednesday office and critical success Low Heights. (Chahar shanbeh souri) His directorial debut was in 2003 with Dancing in the Dust. -

Hier Anschauen, Falls Sie Das Mit Der Hausarbeit, Der Heckenschere Und Den Bügeleisen Einmal Überprüfen Wollen
V.i.S.d.P. Dr. Nils Bernstein www.uni-hamburg.de/sz Modifizierte Titelbilder: Parodie einer Filmszene aus Pulp Fiction Lektüre aus Die Leiden des jungen Werther Obligatorische Kriterien Trifft Trifft für Trifft voll zu einige für mich zu zu Gruppe von Verehrern Spezifische Praxis (z.B. Imitationen, Zitierung, Konsultation) Initiierungserlebnis, Aha-Effekt (Der denkt ja wie ich) Wird nicht nur in einer einzelnen sozialen Gruppe gelesen Kriterienkatalog für Kultbücher Der „Kult-o-meter“ Mögliche Kriterien Trifft Trifft für Trifft voll zu einige für mich zu zu Literarischer Erfolg, große Lesergemeinschaft Romanform, eher kurz (200-300 Seiten) Innovativ Neben Innovationen gleichzeitig Verwendung bekannter Topoi und Stilelemente Kult in Literatur und Film – Kultbücher und Kultfilme Der beste Weg des kulturellen Zugangs ist, zu prüfen, welche Texte in einer bestimmten Kultur besonders wahrgenommen werden. Kultbücher scheiden die Geister: Die einen lieben sie, die anderen hassen sie, doch niemandem sind sie egal. Zu Kultbüchern gehören so unterschiedliche Werke wie Die Leiden des jungen Werther 1774 oder Der Fänger im Roggen (1951). Bei Kultfilmen ist der Unterschied vergleichbar. Und Kultphänomene zu Musik sind vielleicht noch etwas schwieriger beschreibbar zu machen. Wir haben im Seminar eine Bandbreite von Phänomen genauer untersucht, zum Beispiel den Prototyp eines Kultromanes „Die Leiden des jungen Werther, Bands wie Nirvana, Rammstein oder die Figur Elvis Presley, den chilenischen Dichter Nicanor Parra, „Aus dem Leben eines Taugenichts von Eichendorff, James Dean als Kultprotagonisten in dem Film „Rebel without a cause und vieles andere mehr. Als Gast konnten wir PD Dr. Christian Klein von der Universität Wuppertal einladen, der über das Thema Kultbücher habilitiert hat und sicherlich der Experte schlechthin zu dem Thema ist. -

Champs- Élysées Film Festival DU 6 Juin Au 12 Juin 2012
CHAMPS- ÉLYSÉES FILM FESTIVAL DU 6 JUIN AU 12 JUIN 2012 01 ÉDITORIAL SOPHIE DULAC Champs-Elysées Film Festival n’est pas un festival de plus à Paris, mais l’évènement culturel qui se tiendra sur les Champs-Elysées du 6 au 12 juin prochain. PRÉSIDENTE Pourquoi cette initiative, qui plus est, dans une année délicate pour ne pas dire difficile, où s’entremêlent élections, crise économique, morosité ambiante et peur de l’avenir ? Depuis 2009, les cinémas DU FESTIVAL n’ont pas désempli. Plus de 200 millions de spectateurs ont fréquenté les salles obscures. Les théâtres, les concerts, les spectacles sont pleins à craquer. Nous, hommes et femmes de culture, vendons du rêve au public, nous leur permettons le temps d’une séance, d’une soirée, d’oublier le monde dans lequel nous vivons. Nous leur donnons accès à la diversité, les faisons rire ou pleurer, leur ouvrons les portes d’un espace qui leur permet de s’évader. C’est notre métier et au-delà de cela, notre plaisir. Mon plaisir est de prendre possession des Champs-Elysées, notre plus belle avenue du monde. Faire briller le temps d’une semaine, les cinémas français et américain indépendants, recevoir de grandes personnalités de ce métier, proposer une cinématographie inédite, ouvrir des discussions avec des professionnels, faire une place de choix aux courts métrages et inviter le public aux avant-premières sont les maîtres mots de cet événement. S’amuser, se faire plaisir, quelle meilleure manière de faire partager sa passion au travers de son métier ! 02 03 SOMMAIRE LES PRÉSIDENTS DU FESTIVAL LAMBERT MICHAEL 04 10 13 WILSON MADSEN SÉLECTION OFFICIELLE SÉLECTION OFFICIELLE LES JOURNÉES LES LONGS MÉTRAGES LES COURTS MÉTRAGES PROFESSIONNELLES Un festival de cinéma à Paris, sur les Champs-Elysées, c’est on ne peut plus prestigieux. -

Francisco José García Lozano
09_FranciscoGARCIA.qxd:ok_Modelo_art.qxd 10/4/12 10:37 Página 351 «Todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera» * cine Francisco José García Lozano Los conflictos familiares han existi- Nader y Simin, una separación, do desde el comienzo de los tiem- de Asghar Farhadi pos y, de hecho, la literatura, el tea- tro y el cine han aprovechado a La cinta del iraní Asghar Farhadi, fondo esta temática. El séptimo ar- de quien sólo se ha estrenado en Es- te ha abordado las diatribas fami- paña A propósito de Elly (2009), se ha liares desde incontables enfoques: alzado en la última gala de los Os- enalteciéndola (¡Qué bello es vivir!, car con el galardón a la Mejor Pelí- de Frank Capra; La gran familia, de cula de Habla no Inglesa. Ya en el Fernando Palacios), como caldo de último Festival de Berlín fue la gran cultivo de conflictos interiores (Co- triunfadora, donde se convirtió en mo en un espejo, de Ingmar Berg- la primera producción del país en man; Interiores, de Woody Allen) o ganar el Oso de Oro a la Mejor Pe- como fuente de perturbadoras y lícula, además de hacerse con sen- oscuras situaciones (Happiness, Pa- dos Osos de Plata al Mejor Actor y líndormos, de Todd Solonz). Nader Mejor Actriz en reconocimiento y Simin, una separación, de As- respectivo del trabajo colectivo de ghar Farhadi, y Los descendientes, sus actores y actrices, que compar- de Alexander Payne, se caracteri- ten los galardones. Un merecido zan por mostrarnos unas cartogra- palmarés para una película envol- fías emocionales sinceras y profun- vente y magistral, que además sir- das de la familia como lugar de en- cuentro y desencuentro. -

Dossier De Presse F.Pdf
Dossier de presse trigon-film UNE SÉPARATION Un film de Asghar Farhadi Iran, 2011 DISTRIBUTION trigon-film Limmatauweg 9 5408 Ennetbaden Tél: 056 430 12 30 Fax: 056 430 12 31 [email protected] www.trigon-film.org CONTACT MÉDIAS Régis Nyffeler 077 410 76 08 [email protected] MATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUE www.trigon-film.org FICHE TECHNIQUE Réalisation & scénario: Asghar Farhadi Pays: Iran Année: 2011 Langue, sous-titres: Farsi, f/a Durée: 123 minutes Image: Mahmood Kalari Montage: Hayedeh Safiyari Son: Reza Narimizadeh, Mahmood Sammakbashi, Mohammad Reza Delpak Décors: Keyvan Moghadam Costumes: Keyvan Moghadam Maquillage: Mahrdad Mirkiani Production: Asghar Farhadi, Negar Eskandarfar FICHE ARTISTIQUE Leila Hatami Simin Peyman Moadi Nader Shahab Hosseini Hodjat Sareh Bayat Razieh Sarina Farhadi Termeh Babak Karimi Le juge Ali-Asghar Shahbazi Le père de Nader Shirin Yazdanbakhsh La mère de Simin Kimia Hosseini Somayeh FESTIVALS Berlinale 2011 : - Ours d’or du meilleur film - Ours d’argent de la meilleure actrice à l’ensemble des interprètes féminines - Ours d’argent du meilleur acteur à l’ensemble des interprètes masculins - Prix du jury œcuménique - Prix des lecteurs du Morgen Post 2 SYNOPSIS Lorsque sa femme le quitte, Nader engage une aide-soignante pour s’occuper de son père malade. Il ignore alors que la jeune femme est enceinte et a accepté ce travail sans l’accord de son mari, un homme psychologiquement instable… RÉSUMÉ Simin voudrait quitter l’Iran avec son mari Nader et leur fille Termeh. Elle a entrepris toutes les démarches nécessaires et tout réglé en prévision de leur départ. C’est alors que son mari lui fait part de ses scrupules: il ne veut pas abandonner son père qui souffre de la maladie d’Alzheimer. -

Cinematic Overtures
H O W T O R E A D O P E N I N G S C E N E S Cinematic Overtures Leonard Hastings Schoff Memorial Lectures University Seminars Leonard Hastings Schoff Memorial Lectures The University Seminars at Columbia University sponsor an annual series of lectures, with the support of the Leonard Hastings Schoff and Suzanne Levick Schoff Memorial Fund. A member of the Columbia faculty is invited to deliver before a general audience three lectures on a topic of his or her choosing. Columbia University Press publishes the lectures. Charles Larmore, The Romantic Legacy 1996 Saskia Sassen, Losing Control? Sovereignty in the Age of Globalization 1996 David Cannadine, The Rise and Fall of Class in Britain 1999 Ira Katznelson, Desolation and Enlightenment: Political Knowledge After Total War, Totalitarianism, and the Holocaust 2003 Lisa Anderson, Pursuing Truth, Exercising Power: Social Science and Public Policy in the Twenty-First Century 2003 Partha Chatterjee, The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World 2004 David Rosand, The Invention of Painting in America 2004 George Rupp, Globalization Challenged: Conviction, Conflict, Community 2006 Lesley A. Sharp, Bodies, Commodities, and Biotechnologies: Death, Mourning, and Scientific Desire in the Realm of Human Organ Transfer 2007 Robert W. Hanning, Serious Play: Desire and Authority in the Poetry of Ovid, Chaucer, and Ariosto 2010 Boris Gasparov, Beyond Pure Reason: Ferdinand de Saussure’s Philosophy of Language and Its Early Romantic Antecedents 2012 Douglas A. Chalmers, Reforming Democracies: Six Facts About Politics That Demand a New Agenda 2013 Philip Kitcher, Deaths in Venice: The Cases of Gustav von Aschenbach 2013 Robert L. -
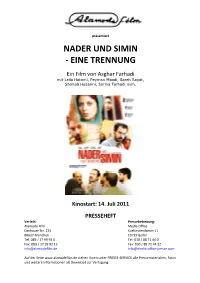
Nader Und Simin - Eine Trennung
präsentiert NADER UND SIMIN - EINE TRENNUNG Ein Film von Asghar Farhadi mit Leila Hatami, Peyman Moadi, Sareh Bayat, Shahab Hosseini, Sarina Farhadi uvm. Kinostart: 14. Juli 2011 PRESSEHEFT Verleih: Pressebetreuung: Alamode Film Media Office Dachauer Str. 233 Kurfürstendamm 11 80637 München 10719 Berlin Tel: 089 / 17 99 92 0 Tel: 030 / 88 71 44 0 Fax: 089 / 17 99 92 13 Fax: 030 / 88 71 44 22 [email protected] [email protected] Auf der Seite www.alamodefilm.de stehen Ihnen unter PRESSE-SERVICE alle Pressematerialien, Fotos und weitere Informationen als Download zur Verfügung. INHALTSVERZEICHNIS Cast & Crew S. 3 Kurzinhalt & Pressenotiz S. 4 Inhalt S. 5 Interview mit dem Regisseur Asghar Farhadi S. 8 Iranisches Kino S. 10 Biografie & Filmografie Asghar Farhadi S. 13 Vor der Kamera S. 14 Für ein selbstbestimmtes Leben von Mädchen und Frauen – Die Aktivitäten von TERRE DES FEMMES S. 16 Deutsche Pressestimmen zur Berlinale S. 17 Internationale Pressestimmen zur Berlinale S. 19 2 STAB UND BESETZUNG Besetzung Simin Leila Hatami Nader Peyman Moadi Hodjat Shahab Hosseini Razieh Sareh Bayat Termeh Sarina Farhadi Richter Babak Karimi Naders Vater Ali-Asghar Shahbazi Simins Mutter Shirin Yazdanbakhsh Somayeh Kimia Hosseini Frl. Ghahraei Merila Zarei Stab Regie Asghar Farhadi Buch Asghar Farhadi Kamera Mahmood Kalari Schnitt Hayedeh Safiyari Ton Mahmood Sammakbashi Tonschnitt Reza Narimizadeh Mischung Mohammad Reza Delpak Szenenbild, Ausstattung Keyvan Moghadam Kostüm Keyvan Moghadam Maske Mehrdad Mirkiani Produzent Asghar Farhadi Ausführender Produzent Negar Eskandarfar Eine Produktion von Asghar Farhadi in Zusammenarbeit mit DreamLab Films im Verleih von Alamode Film TECHNISCHE DATEN: Länge: 123 Minuten Produktionsland/-jahr: Iran 2011 Format: 1:1.85 / Farbe 3 KURZINHALT Nader und Simin sitzen vor dem Scheidungsrichter. -

Mediendossier Trigon-Film
Mediendossier trigon-film A Separation von Asghar Farhadi Iran 2011 VERLEIH trigon-film Limmatauweg 9 5408 Ennetbaden Tel. 056 430 12 30 Fax. 056 430 12 31 info @trigon-film.org www.trigon-film.org MEDIENKONTAKT Tel. 056 430 12 35 [email protected] BILDMATERIAL www.trigon-film.org MITWIRKENDE Regie und Drehbuch Asghar Farhadi Kamera Mahmood Kalari Schnitt Hayedeh Safiyari Ton Mahmood Sammakhbashi Tonschnitt Reza Narimizadeh Mischung Mohammad Reza Delpak Kostüm, Ausstattung, Keyvan Moghadam Maske Mehrdad Mirkiani Produktion Asghar Farhadi, Negar Eskandarfar in Zusammenarbeit mit DreamLab Films Land Iran Entstehungsjahr 2011 Dauer 123 Minuten Sprache/UT Farsi, f/d DARSTELLENDE Leila Hatami Simin Peyman Moadi Nader Shahab Hosseini Hodjat Sareh Bayat Razieh Sarina Farhadi Termeh Babak Karimi Richter Ali-Asghar Shahbazi Naders Vater Shirin Yazdanbakhsh Simins Mutter Kimia Hosseini Somayeh Merila Zarei Frl. Ghahraei FESTIVALS UND AUSZEICHNUNGEN Berlinale 2011: GOLDENER BÄR für den besten Film 2 SILBERNE BÄREN für die besten Schauspielerinnen und die besten Schauspieler Preis der ökumenischen Jury LobEndE Erwahnung dEr FriEdEnsfilmprEisjury Fajr International Film Festival 2011, Teheran: Publikumspreis, bester Film, beste Kamera, bester Regisseur, bestes Drehbuch, bester Ton, beste Nebenschauspielerin, bester Nebenschauspieler Sydney Filmfestival: Bester Film Eriwan Filmfestival: Bester Film KURZINHALT Simin möchte mit ihrer Tochter Termeh den Iran verlassen. Ihr Mann Nader will bleiben, um seinen an Alzheimer erkrankten Vater nicht allein zurücklassen. Deshalb reicht Simin beim Familiengericht die Scheidung ein. Als ihre Klage abgewiesen wird, zieht sie in die Wohnung ihrer Eltern. Termeh bleibt vorerst beim Vater und hofft, dass ihre Mutter bald wieder nach Hause kommt. Zur Betreuung seines kranken Vaters engagiert Nader eine junge Frau. -

APRIL-MAY 2012 Downloa
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY APR 25 Director: Asghar Farhadi APR 26 (7:10 & 9:15) KIDS MATINEE SUN 1PM APR 22 & 23 & 24 (7:00 & 9:15) APR 27 & 28 (3:00 matinee, 7:10 & 9:15) Iran, 2011, 123 minutes; Persian with subtitles; rated G In his exhilarating new film, KIDS MATINEE SAT 1PM BIG MIRACLE (7:00 & 9:20) German master Wim Wenders (Wings THE SECRET WORLD ACADEMY AWARD WINNER! THE of Desire, The Buena Vista Social Club) captures OF ARRIETTY BEST FOREIGN LANGUAGE FEATURE! PINA the brilliantly inventive dance world of legendary cho- DOLBY STEREO APR-MAY 2012 CINECENTA.COM Director: Wim Wenders reographer Pina Bausch. Wenders had conceived with ! A Separation is one of the strongest GREY Germany/France, 2011, 104 minutes; Bausch a dance film like none seen before. After her films of the year. A middle-class Tehran couple (Peyman Moadi German with subtitles; rated G untimely death in 2009, Wenders continued with and Leila Hatami) attempt to separate, and in their stubborn- Director: Joe Carnahan USA, 2012, 117 min; the project, turning it into the most exciting tribute APR 22, 4p.m. *****ness and lack of communication irrevocably affect the lives 14A Cast: Liam Neeson, Dermot Mulroney he could imagine. Sensual and visually stunning, AMAZING GRACE of those around them, including their precocious 11-year-old Pina takes the audience into Bausch’s work Fundraiser for Mount St. daughter (Sarina Farhadi), the husband's Alzheimer's-stricken A taut, lean, intense drama about men-against- “SPIRITED AND in her imaginative sets (a gliding monorail, a Mary Hospital. -

December 4, 2012 (XXV:14) Asghar Farhadi, a SEPARATION (2011, 123 Min)
December 4, 2012 (XXV:14) Asghar Farhadi, A SEPARATION (2011, 123 min) Directed, produced and written by Asghar Farhadi Original Music by Sattar Oraki Cinematography by Mahmoud Kalari Film Editing by Hayedeh Safiyari Academy Award Best Foreign Language Film of the Year (Iran) Peyman Moadi…Nader Leila Hatami…Simin Sareh Bayat…Razieh Shahab Hosseini…Hojjat Sarina Farhadi…Termeh Merila Zare'i…Miss Ghahraii Ali-Asghar Shahbazi…Nader's Father Babak Karimi…Interrogator Kimia Hosseini…Somayeh Night, 2006 Fireworks Wednesday, 2004 Beautiful City, 2003 Shirin Yazdanbakhsh…Simin's Mother Dancing in the Dust, 2002 Low Heights, 2002 “Yadashthaye Sahabanu Zolghadr…Azam koodaki”, 2000 “Roozegare javani”, 2000 “Dastane yek shahr.” Mohammadhasan Asghari…Creditor Shirin Azimiyannezhad…Woman in the Bus MAHMOUD KALARI (b. April 31, 1951, Tehran, Iran) has 60 Hamid Dadju…Creditor cinematographer credits, some of which are 2012 I'm his wife, 2011 A Mohammad Ebrahimian…Judge Separation, 2010 40 years old, 2010 Adamkosh, 2009 7:05, 2009 Samad Farhang…Interrogator's Office Manager Love at 40, 2008 Shirin, 2008 Khake ashena, 2006 Mainline, 2006 Ali Fattahi…Soldier The Fish Fall in Love, 2006 Havana File, 2006/I Offside, 2006 Nafise Ghodrati…School Teacher Fereshte va farsh, 2005 Yek boos-e koochooloo, 2005 Bab'Aziz - The Roya Hosseini…Police Officer Prince That Contemplated His Soul, 2005 The Willow Tree, 2005 Seyyed Jamshid Hosseini…Accused Man “Cinema Iran”, 2005 Tickets, 2004 Al-Ghazali: The Alchemist of Hamid Janane…Soldier Happiness, 2004 Abadan, 2004 Friday's