Maasiana & Callimachea
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Scrivere Leggere Interpretare
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE SCRIVERE LEGGERE INTERPRETARE STUDI DI ANTICHITÀ IN ONORE DI SERGIO DARIS A CURA DI FRANCO CREVATIN E GENNARO TEDESCHI TRIESTE 2005 © Università degli Studi di Trieste - 2005 URL: www.sslmit.units.it/crevatin/franco_crevatin_homepage.htm In copertina foto di P.Daris inv. 98 (Alceo; Ia-Ip) Nota dei Curatori Ci sono momenti in cui dimensione accademica e fatti umani si intrecciano inestricabilmente: assieme ad altri Amici e Colleghi abbiamo desiderato fissare uno di tali momenti, nel quale la stima scientifica e la gratitudine per l’insegnamento ricevuto diventano parte della nostra storia condivisa. A Sergio Daris, che esce dai ruoli universitari, non occorre dire “arrivederci”, perché già sappiamo che la nostra consuetudine e lo scambio di idee continueranno come nel passato. F.C. G.T. I N D I C E ISABELLA ANDORLINI, Note di lettura ed interpretazione a PSI IV 299: un caso di tracoma, pp. 6 ANGELA ANDRISANO, La lettera overo discorso di G. Giraldi Cinzio sovra il comporre le satire atte alla scena: Tradizione aristotelica e innovazione, pp. 9 MARIA GABRIELLA ANGELI BERTINELLI – MARIA FEDERICA PETRACCIA LUCERNONI, Centurioni e curatori in ostraka dall'Egitto, pp. 44 GINO BANDELLI, Medea Norsa giovane, pp. 32 GUIDO BASTIANINI, Frammenti di una parachoresis a New York e Firenze (P.NYU inv. 22 + PSI inv. 137), pp. 6 MARCO BERGAMASCO, ¥(Upereth\j a)rxai=oj in POsl III 124, pp. 9 LAURA BOFFO, Per il lessico dell’archiviazione pubblica nel mondo greco. Note preliminari, pp. 4 FRANCESCO BOSSI, Adesp. Hell. 997a, 5 Ll.-J.-P., pp. 2 MARIO CAPASSO, Per l’itinerario della papirologia ercolanese, pp. -

The Newest Sappho: P. Sapph. Obbink and P. GC Inv. 105, Frs. 1–4 Mnemosyne Supplements Monographs on Greek and Latin Language and Literature
The Newest Sappho: P. Sapph. Obbink and P. GC inv. 105, frs. 1–4 Mnemosyne Supplements monographs on greek and latin language and literature Executive Editor G.J. Boter (vu University Amsterdam) Editorial Board A. Chaniotis (Oxford) K.M. Coleman (Harvard) I.J.F. de Jong (University of Amsterdam) T. Reinhardt (Oxford) volume 392 The titles published in this series are listed at brill.com/mns The Newest Sappho: P. Sapph. Obbink and P. GC inv. 105, frs. 1–4 Studies in Archaic and Classical Greek Song, vol. 2 Edited by Anton Bierl André Lardinois leiden | boston This is an open access title distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported (cc-by-nc 3.0) License, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Bierl, Anton, 1960- editor. | Lardinois, A. P. M. H., editor. Title: The newest Sappho (P. Sapph. Obbink and P. GC inv. 105, frs. 1-4) : studies in archaic and classical Greek song, vol. 2 / edited by Anton Bierl, Andre Lardinois. Other titles: Studies in archaic and classical Greek song, vol. 2 | Mnemosyne, bibliotheca classica Batava. Supplementum ; v. 392. Description: Leiden ; Boston : Brill, 2016. | Series: Mnemosyne. Supplements ; volume 392 | Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2016005748 (print) | LCCN 2016006766 (ebook) | ISBN 9789004311626 (hardback : alk. paper) | ISBN 9789004314832 (e-book) Subjects: LCSH: Sappho–Manuscripts. | Greek poetry–Manuscripts. Classification: LCC PA4409 .N494 2016 (print) | LCC PA4409 (ebook) | DDC 884/.01–dc23 LC record available at http://lccn.loc.gov/2016005748 Want or need Open Access? Brill Open offers you the choice to make your research freely accessible online in exchange for a publication charge. -

The Cologne Fragment of Alcaeus Lloyd-Jones, Hugh Greek, Roman and Byzantine Studies; Summer 1968; 9, 2; Proquest Pg
The Cologne Fragment of Alcaeus Lloyd-Jones, Hugh Greek, Roman and Byzantine Studies; Summer 1968; 9, 2; ProQuest pg. 125 The Cologne Fragment of Alcaeus Hugh Lloyd-Jones EINHOLD MERKELBACH has lately published a new fragment R of Alcaeus which is of great interest.1 Following the civilised practice of Girolamo Vitelli and his Florentine successors, Merkelbach has shown the piece to many scholars before its publi cation, and the first edition contains suggestions by many experts, including the two leading authorities on Lesbian poetry, Edgar Lobel and Denys Page. The first publication is admirably done and is accompanied by a good photograph of the manuscript, which prob ably dates from the first century of our era; Merkelbach compares the writing of POxy. 2295. I have little to contribute in the way of new readings, and owe much of the material here presented to Merkel bach's publication and to the commentary on a fragment of the same poem given by Page in Sappho and Alcaeus;2 readers will find it useful to have Merkelbach's publication in hand while studying this article. Still, I hope a rather fuller commentary on this important piece may be found useful. TEXT p:r/v8tK" 7a /LTJ ~-[v8tKa 7]a /LTJ £v 8tKfI K£[t]/L€V" [ ]aavTas alaxvvL . .JTaTa ,..,.7JVDLKa [ ]7]v DE 7T€pl'aAov[ T' av]aYKa OtJ'TWS £tp"7 V]O'/LW AE[ K£ 8£0'/LOV [ ]~~VL ~lf.f)OAtWL 7T. L Jav· 7"T]V avaYK TJV 1 8p&]aaJI'Tas- Merkelbach: alaxvv[vov}Ta Ta Lobel: alaxvv[8EvJTa Ta Page 2 utrum avJ&YKaL (Merkelbach) an avJ&YKa (Page) incertum 3 aV]XEvL Merkelbach 1 Pe%n. -

Technique in the Service of Humanism: A.B. Poynton's Legacy to E.R. Dodds1
«EIKASMOS» XV (2004) Technique in the service of Humanism: A.B. Poynton’s legacy to E.R. Dodds1 Humanism and technique represent a polarity that can usefully define impor- tant aspects of the evolution of classical studies and classical education in Britain between the mid-nineteenth and mid-twentieth centuries2. It was memorably enun- ciated at Oxford in 1936 in the inaugural lecture of the Regius Professor of Greek3, Eric Robertson Dodds (1893-1979)4, who is himself considered an outstanding example of a humanistic approach to classical scholarship. Yet during his career he produced exemplary editions of three Greek texts: Euripides’ Bacchae (1944); Plato’s Gorgias (1959); and Proclus’ Elements of Theology (1933)5. In the case of the latter two he investigated in detail the manuscript tradition, an activity in the realm of technique that could be considered almost the complete antithesis to humanism6. Now, as is well known, Dodds’s particular version of humanism involved an outreach into psychology, anthropology and psychical research, interests largely developed autodidactically, though they were inspired by his most celebrated teacher, Gilbert Murray (1866-1957). But less is known of the early influences that helped him become an outstanding technical scholar. In this paper I aim to identify them through an account of his relations with his tutor during the first phase of his classical 1 Two manuscript collections in the Bodleian Library, Oxford are identified as DP (= E.R. Dodds Papers; cited by box and, where relevant, file numbers), and MP (= Gilbert Murray Papers; cited by the numbers of the microfilm reel and folios). -

Bulletin of the John Rylands Library
·· .. THE PRESENT POSITION OF PAPYROLOGY.1 BY B. P. GRENFELL, D.LITT., F.B.A., PROFF.sSOR OF PAPYR OLOGY IN THE UNIVERSITY OF OXFORD. HE conquest of Egypt by Alexander the Great in 332 B.c. T brought the country of the Pharaohs out of its comparative isolation into the main stream of European culture, which through Greece and Rome extends to our own day. Under the Ptolemies the most brilliant of the Hellenistic kingdoms, with Alexandria as the literary and scientific centre of the civilized world, under the Romans the richest and most important province of the Empire, under the earlier Byzantine Emperors foremost in the defence of T rinitarian Christianity and the foundation of Monasticism, Egypt had great in fluence on the history of the West for nearly a thousand years, until with the invasion of the Arabs in 640 the country was again isolated, not to return to the main stream until 1870, when once more, as the Khedive Ismail remarked at the opening of the Suez Canal, Egypt became part of Europe. The Ptolemies made Greek the official language, and under the Romans, who conquered Egypt in 30 B.C., but employed Latin only in the highest official and in military circles, a knowledge of Greek be came general, though ancient Egyptian continued to be spoken down to the third century, when in a Grrecised form it became the Coptic language, which lasted till the sixteenth century. Hence the great majority of papyri from Egypt, written between 300 B.C. and the middle of the seventh century, are in Greek, and though there are many written in demotic and Coptic, and a few in Latin, Hebrew, Syriac, Aramaic, and Pehlevi, papyrology has come to mean practically the study of Greek papyri, including various substitutes for papyrus as writing-material, such as ostraca (bits of broken pottery), wooden or wax tablets, and after the second century vellum. -

Private Papers of John Barron
1 St Peter’s College – Archives SP:P25 – The Papers of Professor John Barron Name(s) of creator(s): Barron, John Penrose (1934-2008), academic and educational administrator Dates of creation of material: 1687 - 2007 Level of description: Fonds Extent: 27 boxes Biographical history: John Penrose Barron (JPB) was born in Morley, west Yorkshire, on 27 April 1934. Educated at Clifton College, Bristol, he went up to Oxford in 1953 as an exhibitioner at Balliol College, where he read Classics. He graduated in 1957 with first-class honours, going on to complete his doctorate in 1961 on the history of Samos to 439 BC. Barron’s academic career began when he joined Bedford College, London, as an Assistant Lecturer in Latin. In 1964, he moved to University College London as a Lecturer in Archaeology, becoming Reader in 1967. For twenty years from 1971, he was Professor of Greek at King’s College London, having been elected to the Chair at the age of only 37. He was also Director of the Institute of Classical Studies of London University (1984-1991), Pro-Vice- Chancellor for the Arts (1987-1989) and Dean of the Institutes for Advance Study (1989-1991). He also served as the University of London’s Public Orator (1978-1981, 1986-1988). His publications include Introduction to Greek Sculpture (1965, revised 1981) and The Silver Coins of Samos (1966). In 1991, he was elected Master of St Peter’s College, Oxford, a post he would hold until 2003. His Mastership was characterised by a rise in both the number of female students at the college and its academic performance. -
Alt Context 1897-1930
1897 – Context – 102 {{All Saints', Evesham. The solemn services of Good Friday and Holy Saturday. / LITURGIES.-- pp. 10. ; 24o..-- Oxford : Mowbray & Co., [1897.] Held by: British Library}} {{Are our Clergy rightly ordained? ... With a preface by the Rev. T. T. Carter, etc. / Staley, Vernon ; Carter, Thomas Thellusson.-- pp. 20. ; 8o..-- Oxford : Mowbray & Co., [1897.] Held by: British Library}} {Are the Writings of Dionysius the Areopagite genuine? / Parker, John, Vicar of Willoughby and Wysall ; Dionysius, Saint, called the Areopagite.-- pp. 20. ; 8o..-- London & Oxford : J. Parker & Co., 1897. Held by: British Library} {{{Aristophanous Hippes. The Knights of Aristophanes / adapted for performance by the Oxford University Dramatic Society, 1897. With an English version adapted from that of J. Hookham Frere by L.E. Berman.-- 8vo.-- Oxford, [1897] Held by: National Library of Scotland}}} {{At Evening Time it shall be Light. [A sacred poem.] / Newsham, Louisa.-- 8o..-- Oxford : Mowbray & Co., [1897.] Held by: British Library}} {{To the most High, Mightie and Magnificent Empresse ... Victoria ... Her most humble servant H. W. [i.e. Sir T. H. Warren] doth in all humilitie dedicate, present and consecrate these his verses. / W., H. ; Victoria, Queen of Great Britain and Ireland ; Warren, Sir Thomas Herbert, K.C.V.O..-- 8o..-- Oxford : [Daniel Press], [1897.] Held by: British Library}} {{{The Bible for home reading / edited, with comments and reflections for the use of Jewish parents and children, by C[laude] G[oldsmid] Montefiore.-- 2nd ed.-- v.-- London & New York [pr. Oxford] : [s.n.], 1897- Held by: Trinity College Dublin}}} {{{Bustle. [A lecture.] Delivered on January 21, 1897. / Milner, Alfred, Viscount Milner.-- pp. -
Hesperos-Studies-In-Ancient-Greek-Poetry-Presented
HESPEROS Hesperos Studies in Ancient Greek Poetry Presented to M. L. West on his Seventieth Birthday Edited by P. J. FINGLASS C. COLLARD N. J. RICHARDSON 1 3 Great Clarendon Street, Oxford ox2 6dp Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offices in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York © Oxford University Press 2007 The moral rights of the authors have been asserted Database right Oxford University Press (maker) First published 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this book in any -

Download: Brill.Com/Brill-Typeface
The Newest Sappho: P. Sapph. Obbink and P. GC inv. 105, frs. 1–4 Mnemosyne Supplements monographs on greek and latin language and literature Executive Editor G.J. Boter (vu University Amsterdam) Editorial Board A. Chaniotis (Oxford) K.M. Coleman (Harvard) I.J.F. de Jong (University of Amsterdam) T. Reinhardt (Oxford) volume 392 The titles published in this series are listed at brill.com/mns The Newest Sappho: P. Sapph. Obbink and P. GC inv. 105, frs. 1–4 Studies in Archaic and Classical Greek Song, vol. 2 Edited by Anton Bierl André Lardinois leiden | boston This is an open access title distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported (cc-by-nc 3.0) License, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Bierl, Anton, 1960- editor. | Lardinois, A. P. M. H., editor. Title: The newest Sappho (P. Sapph. Obbink and P. GC inv. 105, frs. 1-4) : studies in archaic and classical Greek song, vol. 2 / edited by Anton Bierl, Andre Lardinois. Other titles: Studies in archaic and classical Greek song, vol. 2 | Mnemosyne, bibliotheca classica Batava. Supplementum ; v. 392. Description: Leiden ; Boston : Brill, 2016. | Series: Mnemosyne. Supplements ; volume 392 | Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2016005748 (print) | LCCN 2016006766 (ebook) | ISBN 9789004311626 (hardback : alk. paper) | ISBN 9789004314832 (e-book) Subjects: LCSH: Sappho–Manuscripts. | Greek poetry–Manuscripts. Classification: LCC PA4409 .N494 2016 (print) | LCC PA4409 (ebook) | DDC 884/.01–dc23 LC record available at http://lccn.loc.gov/2016005748 Want or need Open Access? Brill Open offers you the choice to make your research freely accessible online in exchange for a publication charge. -
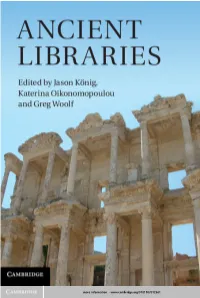
Ancient Libraries
more information - www.cambridge.org/9781107012561 Ancient Libraries The circulation of books was the motor of classical civilisation. But books were both expensive and rare, and so libraries – private and public, royal and civic – played key roles in articulating intellectual life. This collection, written by an international team of scholars, presents a fundamental reassessment of how ancient libraries came into being, how they were organised and how they were used. Drawing on papy- rology and archaeology, and on accounts written by those who read and wrote in them, it presents new research on reading cultures, on book collecting and on the origins of monumental library buildings. Many of the traditional stories told about ancient libraries are chal- lenged. Few were really enormous, none was designed as a research centre and occasional conflagrations do not explain the loss of most ancient texts. But the central place of libraries in Greco-Roman culture emerges more clearly than ever. jason konig¨ is Senior Lecturer in Greek at the University of St Andrews. He works broadly on the Greek literature and culture of the Roman Empire. He is author of Athletics and Literature in the Roman Empire (2005) and Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture (2012), and editor, jointly with Tim Whitmarsh, of Ordering Knowledge in the Roman Empire (2007). katerina oikonomopoulou is a postdoctoral research fellow for the programme ‘Medicine of the Mind, Philosophy of the Body – Discourses of Health and Well-Being in the Ancient World’ at the Humboldt-Universitat¨ zu Berlin. -

Papers & Posters Abstracts
Centro Storico di Firenze CITTÀ METROPOLITANA inscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1982 DI FIRENZE INTERNATIONAL CONGRESS OF EGYPTOLOGISTS XI Florence, Italy 23 - 30 August 2015 MUSEO EGIZIO FIRENZE FLORENCE EGYPTIAN MUSEUM www.ice11florence.org CAMNES Center for Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies ICE XI International Congress of Egyptologists XI Florence (Italy) August 23rd – 30th 2015 Paper and Poster Abstracts 2 PAPERS Ali Abdelhalim Ali Ain Shams University Overwriting in the titles of Ptolemy XII in the Temple of Kom Ombo. Despite the new method of modifications in the titles of Ptolemy XII at Kom Ombo, it was not the first case in the ancient Egyptian civilization, as it occurs in the New-Kingdom. Changes in the modified titles in the New-Kingdom include the name of the king inside the cartouche, while the cases of Kom Ombo concerns only with adding "nb-tȝwy" (Lord of two Lands) to "nsw-bity" (King of Upper and Lower Egyt) and "nb-ḫʿw" (Lord of Crowns) to "sȝ-Rʿ" (Son of Re) in front of the cartouches. The king's name remains without modification inside the cartouches. The present paper deals with those modifications of the Coronation- and Birth-names of Ptolemy XII as one of the most characteristics on the columns of the Hypostyle Hall of the Temple of Kom Ombo. I will give interpretations whether technically, politically or historically through investigating the changes of forms of both names. Schafik Allam IANES-University of Tuebingen Bemerkungen zum Testament in Altägypten. Aus Altägypten sind (öffentliche) Testamente von Privatpersonen überliefert worden. Es sind Urkunden, die vorn einer Behörde oder in Gegenwart von Zeugen errichtet wurden. -

ARESU-DISSERTATION-2015.Pdf (2.285Mb)
The Author as Scribe. Materiality and Textuality in the Trecento The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Aresu, Francesco Marco. 2015. The Author as Scribe. Materiality and Textuality in the Trecento. Doctoral dissertation, Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:17467386 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA The Author as Scribe. Materiality and Textuality in the Trecento A dissertation presented by Francesco Marco Aresu to The Department of Romance Languages and Literatures in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of Italian Harvard University Cambridge, Massachusetts May 2015 © 2015 Francesco Marco Aresu. All rights reserved. ! ! Professor Jeffrey Schnapp Francesco Marco Aresu The Author as Scribe. Materiality and Textuality in the Trecento Abstract In this dissertation, I explore the relationship between the material aspects of an editorial artifact and their literary implications for the texts it contains. I show how the interpretation of a text needs to be accompanied by an inquiry into the material conditions of its production, circulation and reception. This study is intended as both an investigation of the material foundations of institutions of literary study and a reflection on some often neglected sides of contemporary theorizations concerning textuality, writing, and media.