Serenissima in Scena-2014.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Representações Do Feminino Em La Locandiera E La Putta Onorata, De Carlo Goldoni
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS CAROLINE BARBOSA FARIA FERREIRA REPRESENTAÇÕES DO FEMININO EM LA LOCANDIERA E LA PUTTA ONORATA, DE CARLO GOLDONI Vitória 2019 CAROLINE BARBOSA FARIA FERREIRA REPRESENTAÇÕES DO FEMININO EM LA LOCANDIERA E LA PUTTA ONORATA, DE CARLO GOLDONI Tese apresentada ao programa de Pós-Graduação em Letras do Centro de Ciências Humanas e Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção do título de Doutora em Letras, na área de concentração Estudos Literários. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Paula Regina Siega Co-orientador: Prof. Dr. André Luís Mitidieri Vitória 2019 Aos meus pais Aos meus amados Gilberto e Levi. AGRADECIMENTOS A Deus, porque sei que sem Ele nada seria possível. Aos meus amados Gilberto e Levi, pelo grande amor, incentivo, apoio, compreensão, paciência e ajuda em todos os momentos. Aos meus pais, Claudio e Shirley, porque sempre acreditaram em mim e me fazerem crer que eu poderia ir além. À minha orientadora, Profa. Dra. Paula Regina Siega, pela grande amizade, atenção, solicitude, e confiança no meu trabalho. Ao meu co-orientador, Prof. Dr. André Luis Mittidieri, por todo o auxílio no meu Exame de Qualificação e durante a escritura da tese. À Profa. Dra. Ester Abreu Vieira de Oliveira, pelas disciplinas de teatro que tanto enriqueceram os meus conhecimentos, e pelos valorosos comentários, questionamentos e observações em meu Exame de Qualificação. A todos os meus colaboradores, aqui no Brasil e na Itália, que me enviaram artigos e livros, sem os quais não poderia certamente ter construído esta tese. -
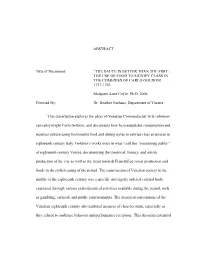
The Use of Food to Signify Class in the Comedies of Carlo Goldoni 1737-1762
ABSTRACT Title of Document: “THE SAUCE IS BETTER THAN THE FISH”: THE USE OF FOOD TO SIGNIFY CLASS IN THE COMEDIES OF CARLO GOLDONI 1737-1762. Margaret Anne Coyle, Ph.D, 2006 Directed By: Dr. Heather Nathans, Department of Theatre This dissertation explores the plays of Venetian Commedia del’Arte reformer- cum-playwright Carlo Goldoni, and documents how he manipulates consumption and material culture using fashionable food and dining styles to satirize class structures in eighteenth century Italy. Goldoni’s works exist in what I call the “consuming public” of eighteenth century Venice, documenting the theatrical, literary, and artistic production of the city as well as the trend towards Frenchified social production and foods in the stylish eating of the period. The construction of Venetian society in the middle of the eighteenth century was a specific and legally ordered cultural body, expressed through various extra-theatrical activities available during the period, such as gambling, carnival, and public entertainments. The theatrical conventions of the Venetian eighteenth century also explored nuances of class decorum, especially as they related to audience behavior and performance reception. This decorum extended to the eating styles for the wealthy developed in France during the late seventeenth century and spread to the remainder of Europe in the eighteenth century. Goldoni ‘s early plays from 1737 through 1752 are riffs on the traditional Commedia dell’Arte performances prevalent in the period. He used food in these early pieces to illustrate the traditional class and regional affiliations of the Commedia characters. Plays such as The Artful Widow, The Coffee House, and The Gentleman of Good Taste experimented with the use of historical foods styles that illustrate social placement and hint at further character development. -

Bibliografia Di Carlo Goldoni Nel Trecentenario Della Nascita a Cura Di Paolo Bignamini E Daniela Ferrario
ScenAperta – Polo Teatrale dell’Altomilanese Ass. Cult. ScenAperta Altomilanese Teatri presentano: GOLDONIANA Bibliografia di Carlo Goldoni nel trecentenario della nascita A cura di Paolo Bignamini e Daniela Ferrario Le opere (http://www.pelagus.org/it/libri/Carlo_Goldoni.html) Alessandro Longhi Ritratto di Carlo Goldoni (1762). Casa Goldoni, Venezia LA LOCANDIERA GLI AMORI DI ZELINDA E LINDORO I DUE GEMELLI VENEZIANI I MALCONTENTI I MERCATANTI I PUNTIGLI DOMESTICI I RUSTEGHI IL BUGIARDO IL CAVALIER DI BUON GUSTO IL CONTRATTEMPO IL FESTINO IL FILOSOFO INGLESE IL GELOSO AVARO IL GIUOCATORE IL MEDICO OLANDESE IL MERCANTE FALLITO IL PADRE DI FAMIGLIA IL POETA FANATICO IL PRODIGO IL RAGGIRATORE IL RITORNO DALLA VILLEGGIATURA IL SERVITORE DI DUE PADRONI IL TUTORE IL VECCHIO BIZZARRO IL VECCHIO FASTIDIOSO IL VENTAGLIO IL VERO AMICO IRCANA IN ISPAAN LA BOTTEGA DEL CAFFE' LA BUONA FAMIGLIA LA CAMERIERA BRILLANTE LA CASA NOVA LA DAMA PRUDENTE LA DONNA DI GARBO LA FIGLIA OBBEDIENTE LA MADRE AMOROSA LA MOGLIE SAGGIA LA PUTTA ONORATA LA SERVA AMOROSA LA SPOSA PERSIANA LA SUOCERA E LA NUORA LA VEDOVA SCALTRA LA VILLEGGIATURA L'ADULATORE L'AMANTE DI SE MEDESIMO L'AVVENTURIERE ONORATO L'AVVOCATO VENZIANO LE AVVENTURE DELLA VILLEGGIATURA LE DONNE CURIOSE LE FEMMINE PUNTIGLIOSE LE MASSERE LE SMANIE PER LA VILLEGGIATURA L'EREDE FORTUNATA L'IMPOSTORE L'INCOGNITA L'UOMO DI MONDO L'UOMO PRUDENTE MEMORIE PAMELA NUBILE TERENZIO TORQUATO TASSO UNA DELLE ULTIME SERE DI CARNOVALE I libri su Goldoni Sergio Leone e Ferruccio Soleri Il teatro di Goldoni sulle scene italiane del Novecento Paolo Bosisio Ediz. Electa 1993 - 265 pagine Il volume si pone l’obiettivo di ricostruire, con il supporto di tutti gli elementi documentari disponibili, il percorso compiuto dalle commedie di Goldoni sui nostri palcoscenici a partire dal Settecento, con particolare riferimento alle numerose e spesso significative interpretazioni registiche e attoriali novecentesche. -

Masks and Masked Performance in Giorgio Strehler's Vision of the Commedia Dell'arte
Masks and Masked Performance in Giorgio Strehler's Vision of the Commedia dell'Arte by Gabrielle Houle A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Centre for Drama, Theatre and Performance Studies University of Toronto © Copyright by Gabrielle Houle 2013 Masks and Masked Performance in Giorgio Strehler's Vision of the Commedia dell'Arte Gabrielle Houle Doctor of Philosophy Centre for Drama, Theatre and Performance Studies University of Toronto 2013 Abstract This thesis examines the role of solid and painted masks in Giorgio Strehler's successive stagings of Carlo Goldoni's Servant of Two Masters at the Piccolo Teatro of Milan between 1947 and 1997. Through my description and analysis of documentary evidence about these stagings, the Piccolo Teatro, Giorgio Strehler, his mask-makers Amleto and Donato Sartori, his actors, and lighting designer, I demonstrate that masks were used in the above-mentioned productions as rhetorical tools that expressed Strehler's relationship with Goldoni (the man and his work), communicated his political convictions on stage, partook in his attempted reform of the Italian theatre after World War II, displayed his vision of theatre history, proved his endorsement of the actors' potential in performance, and helped position the Piccolo Teatro within an Italian and pan-European artistic elite. My examination of video recordings and photographs of the productions, letters of personal correspondence, theatre reviews, transcriptions of interviews, and programme notes, among other documents, traces the evolution of Strehler's interpretative vision of the Commedia dell'Arte over fifty years. This vision, as I argue in the introduction and conclusion to my thesis, helped shape how other theatre directors, educators, as well as actors, mask-makers, and, ii arguably, academics have come to imagine Goldoni's work, Commedia dell'Arte, and masked performance. -
Commedie Di Carta. Considerazioni Su Alcune Traduzioni Goldoniane Mai Allestite in Croazia
K. Radoš-Perković, Commedie di carta. Considerazioni su alcune traduzioni goldoniane... - SRAZ LVI, 239-252 (2011) UDC 821.131.1-22.03=163.42 Original scientific paper Ricevuto il 27 ottobre 2011 Approvato per la pubblicazione il 15 novembre 2011 Commedie di carta. Considerazioni su alcune traduzioni goldoniane mai allestite in Croazia Katja Radoš-Perković Facoltà di Lettere e Filosofia Università di Zagreb [email protected] Il saggio si propone di presentare un certo numero di traduzioni croate di com- medie goldoniane che, non essendo mai state allestite nei teatri domestici, vengono definite come “commedie di carta”. Due tra queste vengono analizzate in confronto ad altre traduzioni della stessa commedia con maggiore fortuna scenica, mentre il resto dei titoli “di carta” viene considerato come potenziale teatrale. Il saggio offre anche i dati sulle traduzioni teatrali mai pubblicate e sui capolavori non ancora tradotti e quindi non accessibili al pubblico croato. Nel vasto repertorio goldonistico croato presente sulle scene dei teatri domestici dal lontano 1862,1 esiste un certo numero di traduzioni mai allestite, oppure allestite soltanto da gruppi filodrammatici amatoriali.2 Le ricerche del 1 Anche se formalmente la prima rappresentazione croata di una commedia goldoniana è un adattamento della Locandiera intitolato Anica krčmarica, le indagini del maggiore goldonista croato Frano čale hanno portato alla luce una versione in latino del Servi- tore di due padroni allestita nel 1772 dagli studenti del Collegio dei Gesuiti di Zagabria. Inoltre, un altro teatrologo croato, Slavko Batušić, ha scoperto che dietro al titolo di Ljubomirović ili priatel pravi attribuito a Matija Jandrić e pubblicato nel 1821 dal parroco Tomaš Mikloušić si nascondeva una traduzione della commedia goldoniana Il vero amico. -
Dei Fogli Miei Leuropa Tutta E
«DEI FOGLI MIEI L’EUROPA TUTTA È PIENA»: O CASO PORTUGUÊS MARIA JOÃO ALMEIDA* Como cremos ser notório, a obra de Goldoni faz parte de um património teatral que há muito transcende os confins do território italiano. Por vezes esquecida, mas nunca igno- rada, a dramaturgia do autor sobreviveu nos palcos europeus, após 1793, por mais de século e meio, por vezes desnaturada por leituras abusivas ou maldestras, e frequentemente sufo- cada por confusões e contaminações com a Commedia dell’Arte. Ganhou forma, assim, «la storia di un lungo tra- dimento»1 que o autor das palavras citadas, Ugo Ronfani, define como «un tentativo di restaurazione preriforma del repertorio goldoniano»2. Em Itália, a redescoberta de Goldoni e o reencontro com a verdadeira dimensão da sua drama- turgia deu-se tardiamente em pleno Novecentos, no segundo * Maria João Almeida. Licenciada e doutorada pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, lecciona Literatura e Cultura italianas nesta Faculdade, desde 1990. Investigadora do Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa, desenvolve actualmente investigação em história do teatro em Portugal e em literatura dramática italiana. Tem publicado artigos em livros e revistas portuguesas. Publicou recentemente O Teatro de Goldoni no Portugal de Setecen- tos (Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007). 1 Ugo Ronfani, “L’Italia per Carlo Goldoni – Carlo Goldoni per l’Italia”, in AA.VV., Goldoni Vivo, pubbl. a cura di U. Ronfani, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, 1994 (Quaderni di Vita Italiana, n.º 1/1994), p. 27. 2 Id., ibid. -

Carlo Goldoni and the Dramma Giocoso Per Musica
Venetian playwright and pioneer of modern theatre Carlo Goldoni (1707-1793) led a ‘double life’ as a librettist, authoring nearly as 24 many libretti as comedies- libretti which, born from the same mind Pervinca Rista and the same hand that brought forth his famous, and famously controversial, overhaul of the practices of comic theatre, could not but push the limits of the standing tradition to open a new chapter in opera history. Goldoni became one of the first to give shape to the dramma giocoso per musica, an innovative, realistic, and enduring new genre with intimate connections to prose comedy that met with overwhelming international success, becoming the foundation for the works of future generations, including W. A. Mozart and his Italian librettist Lorenzo da Ponte. Perhaps because of his stature and At the origins of influence as a comic playwright, Goldoni has rarely been considered Rista Pervinca as an innovator in the musical sphere. This study aims to shed new Classical opera light on his primary role in the evolution of Classical opera, and on the legacy of his innovations in the European musical tradition. Carlo Goldoni and the dramma giocoso per musica aria Musicologica Pervinca Rista (b. Italy) holds a PhD in Comparative Literature (Johns 24 Hopkins University, Baltimore, MD, USA), along with numerous advan- ced degrees in Violin Performance earned in both the US and Italy. She has won numerous academic and musical awards, and performs con- certs regularly worldwide. She has authored texts for music, has transla- At the origins of Classical opera ted numerous works from Italian to English, and has published research in class-A international journals. -

At the Piccolo Teatro of Milan Between
Masks and Masked Performance in Giorgio Strehler's Vision of the Commedia dell'Arte by Gabrielle Houle A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Centre for Drama, Theatre and Performance Studies University of Toronto © Copyright by Gabrielle Houle 2013 Masks and Masked Performance in Giorgio Strehler's Vision of the Commedia dell'Arte Gabrielle Houle Doctor of Philosophy Centre for Drama, Theatre and Performance Studies University of Toronto 2013 Abstract This thesis examines the role of solid and painted masks in Giorgio Strehler's successive stagings of Carlo Goldoni's Servant of Two Masters at the Piccolo Teatro of Milan between 1947 and 1997. Through my description and analysis of documentary evidence about these stagings, the Piccolo Teatro, Giorgio Strehler, his mask-makers Amleto and Donato Sartori, his actors, and lighting designer, I demonstrate that masks were used in the above-mentioned productions as rhetorical tools that expressed Strehler's relationship with Goldoni (the man and his work), communicated his political convictions on stage, partook in his attempted reform of the Italian theatre after World War II, displayed his vision of theatre history, proved his endorsement of the actors' potential in performance, and helped position the Piccolo Teatro within an Italian and pan-European artistic elite. My examination of video recordings and photographs of the productions, letters of personal correspondence, theatre reviews, transcriptions of interviews, and programme notes, among other documents, traces the evolution of Strehler's interpretative vision of the Commedia dell'Arte over fifty years. This vision, as I argue in the introduction and conclusion to my thesis, helped shape how other theatre directors, educators, as well as actors, mask-makers, and, ii arguably, academics have come to imagine Goldoni's work, Commedia dell'Arte, and masked performance. -

Dzieła Carla Goldoniego Omawiane W Pracy Carlo Goldoni, Tutte Le Opere
Dzieła Carla Goldoniego omawiane w pracy Carlo Goldoni, Tutte le opere, 14 t., red. Giuseppe Ortolani, Mondadori, Milano 1935–1956: t. II (1936): Teatro comico; t. IV (1940): La figlia obbediente; t. V (1941): Introduzione, o sia apertura di Teatro per la prima sera dell’Autunno dell’Anno 1753, Introduzione, o sia apertura di Teatro per la prima sera dell’Autunno dell’Anno 1754, Introduzione, o sia apertura di Teatro per la prima sera dell’Autunno dell’Anno1755, Il Festino, Terenzio. Torquato Tasso, I Malcontenti; t. VII (1946): La scuola di ballo, L’impresario delle Smirne; t. XII (1952): Sonetto di Ringraziamento e di Addio, recitato dalla Prima Donna nel teatro di Sant’Angelo alla fine della „Putta onorata”, l’ultima sera del carnevale 1749, Sonetto recitato dalla prima donna in S. Angelo in fine dell’innesto delle due Commedie „Putta onorata” e „Buona mugier” l’ultima sera del carnevale 1750, che serve d’Addio, Complimento di Rosaura che nell’ultima sera del carnevale dell’anno 1751 si recito nel Teatro di Sant’Angelo, Complimento di Flaminia recitato nel Teatro Vendramino l’ultima sera del carnovale dell’anno 1754, Ringraziamento dopo la recita della Commedia che ha per titolo la „Madre amorosa”, Prologo che precede le Commedia intitolata i Viaggiatori, Complimento fatto al popolo dalla prima donna l’ultima sera di Carnovale, dopo la precedente Commedia delle Massare, continuando anche in questo medesimo vernacolo Veneziano, Il Monte di Parnaso, Introduzione alle recite Autunnali in Venezia nell’anno 1760. Recitata dalla Signora Caterina Bresciani, Prima Donna della Compagnia che dicesi di S.